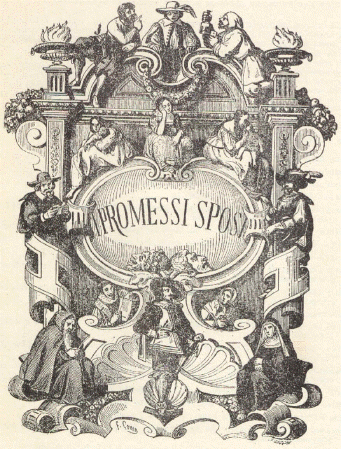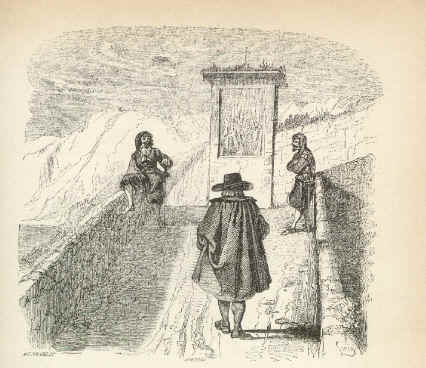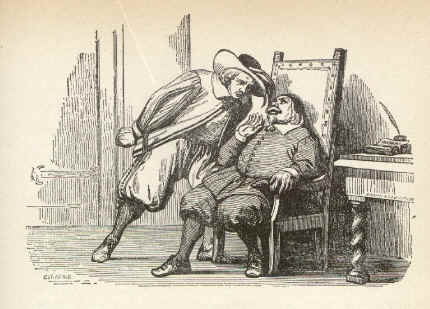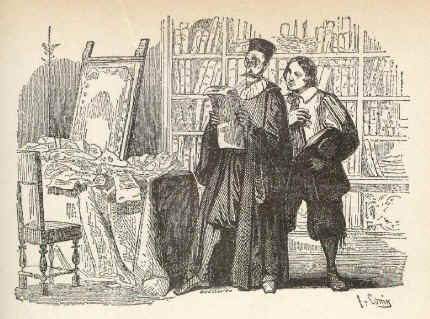|
|
 |
|
Il riassunto dei
Promessi Sposi
|
||
|
Quel ramo del lago di Como. – Il romanzo si apre con la celebre descrizione di quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, e che viene quasi ad un tratto a restringersi e a prendere corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra ed un’ampia costiera dall’altra parte. Tra il promontorio e la costiera è un ponte, che sembra rendere ancora più sensibile quella trasformazione, e segnare il punto in cui il lago cessa e l’Adda ricomincia. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di San Martino, l’altro il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli che lo fanno assomigliare a una sega. Lecco. – Lecco, il borgo principale che dà il nome a quel territorio, giace poco discosto dal ponte, sulla riva del lago. Ai tempi in cui accaddero i fatti narrati nel romanzo, quel borgo era anche una fortezza, che aveva l’onore di alloggiare un comandante e il vantaggio non invidiabile di possedere una guarnigione di soldati spagnoli. Dietro Lecco, dall’una all’altra di quelle terre, dalle alture alla riva, corrono strade e stradette più o meno ripide o piane. La passeggiata di don Abbondio. - Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla sua passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre 1628, don Abbondio, curato di uno di quei paesi. Diceva tranquillamente il suo ufficio e, talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario, e proseguiva il suo cammino buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo al sentiero, o girando oziosamente gli occhi intorno. Giunse ad una svolta, dove era solito alzare gli occhi dal libro e guardarsi dinanzi, e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata la strada correva diritta per circa sessanta passi, poi si biforcava: una viottola saliva alla curia, l’altra, il cui muro non arrivava ai fianchi del passeggero, scendeva alla valle fino al torrente. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale erano dipinte certe figure lunghe e serpeggianti, che, nell’intenzione dell’artista, volevano dir fiamme, e cert’altre figure indescrivibili che volevano dire anime del purgatorio. L’incontro coi bravi. - Don Abbondio, voltata la stradetta, e guardando come era solito, verso il tabernacolo, vide fermi due uomini: uno a cavalcioni sul muricciolo basso, l’altro in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. Essi, per l’abito e per il portamento, mostravano a prima vista di essere due bravi, cioè uomini che, al servizio di qualche ricco e potente signore, commettevano ribalderie di ogni genere. I governatori spagnoli avevano promulgato molte grida (o editti) contro questi furfanti, ma esse non erano servite ad altro che ad attestare l’impotenza del governo d’allora. La minacciosa intimazione. – Era evidente che i due bravi erano ad attendere qualcuno; ma ciò che più dispiacque a don Abbondio fu il dover accorgersi, per certi atti, che l’aspettato era proprio lui. Egli, tenendo sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su, per spiare le loro mosse, e, vedendoseli venire proprio incontro, fu assalito da mille pensieri. Si chiese se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, ma si sovvenne subito di no. Fece un rapido esame, se avesse peccato contro qualche potente, ma anche in quel turbamento la coscienza lo rassicurava. Intanto i bravi si avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l’indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo, e, girando le due dita intorno al collo, volse la faccia all’indietro, allo scopo di guardare con la coda dell’occhio se qualcuno arrivasse; ma non vide nessuno. Non potendo perciò schivare il pericolo, affrettò il passo, perché i momenti di quell’incertezza gli erano così penosi, che non desiderava altro che abbreviarli. Recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e ilarità che poté, e, quando si trovò di fronte ai due galantuomini, si fermò sui due piedi. I due bravi, con un tono minaccioso, diffidarono don Abbondio, in nome del loro padrone don Rodrigo, dal celebrare il matrimonio tra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che avrebbe dovuto aver luogo all’indomani, e, nello stesso tempo, gli ingiunsero di non fare parola di ciò a nessuno, altrimenti… E sottolinearono la loro intimazione un ehm! Molto significativo. Don Abbondio, con voce tremante, non seppe balbettare che dei tronchi monosillabi, dichiarandosi umilmente disposto all’obbedienza; e quelli si allontanarono cantando una canzonaccia. Il povero don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato; poi prese la stradetta che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l’altra. Ritratto di don Abbondio. – Don Abbondio, avverte a questo punto il Manzoni, non era nato con un cuor di leone. Trovatosi a vivere in un’epoca, nella quale la forza legale non proteggeva affatto il debole, aveva dovuto accorgersi di essere nella condizione di un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva perciò volentieri obbedito ai parenti che lo volevano prete, preoccupandosi non tanto degli obblighi e dei nobili fini del ministero, quanto piuttosto di poter vivere con qualche agio e di mettersi in una classe riverita e forte. Si era poi fatto un sistema particolare di vita, che consisteva principalmente nello scansare tutti i contrasti, e nel cedere in quel che non poteva scansare. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia, e procurando di far vedere all’altro ch’egli non gli era volontariamente nemico, come se gli dicesse: ma perché non avete saputo esser voi il più forte? Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcun pericolo. Il battuto era almeno un imprudente, l’ammazzato era sempre stato un uomo torbido. Aveva infine una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie: che a un galantuomo, il quale badi a sé, e stia nei suoi panni, non accadono mai brutti incontri. In tal modo, destreggiandosi alla meglio, il pover’uomo era riuscito a passare i sessant’anni, senza gravi burrasche. Il soliloquio di don Abbondio. – Si pensi ora che impressione dovesse fare sull’animo di don Abbondio l’incontro coi bravi, che veniva a sconcertargli in un momento un sistema di quieto vivere, che gli era costato tanti anni di studio e di pazienza. Mentre si avviava col capo basso verso casa, tumultuavano in lui opposti e disordinati pensieri. Pensava quale pretesto avrebbe potuto prendere con Renzo, «un agnello se nessuno lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli…». Inveiva contro quei ragazzacci, che, per non saper che fare, s’innamorano e vogliono maritarsi, e non si curano dei travagli in cui mettono un povero galantuomo… Non aveva avuto a che fare con don Rodrigo, altro che toccare il petto col mento e la terra colla punta del suo cappello, quelle poche volte che l’aveva incontrato per la strada; ma in quel momento gli dava in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli da altri, senza interrompere in fretta con un «ohibò». Perpetua. – Giunto alla porta, che era in fondo al paese, mise in fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; aprì, entrò, richiuse diligentemente; e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito la serva Perpetua, avviandosi verso il salotto, dove questa stava apparecchiando la tavola per la cena. Perpetua era una serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare secondo l’occasione, tollerare a tempo il brontolìo e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerare le proprie, che divenivano di giorno in giorno più frequenti, da quando aveva passato l’età sinodale dei quarant’anni. Essa era rimasta zitella, per aver rifiutato tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. Vedendo entrare il padrone con un viso così stravolto, comprese subito che doveva essergli accaduto qualche cosa di straordinario. La confessione di don Abbondio. - Don Abbondio, lasciadosi cadere tutto ansante sul seggiolone, tentò dapprima di eludere le domande della donna, protestando che non gli era accaduto nulla, orinandole di dargli soltanto un bicchiere del suo vino, che vuotò in fretta come una medicina. Ma infine, sia perché Perpetua minacciava di domandar qua e là cosa fosse accaduto al suo padrone, sia perché don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo segreto quanta ne aveva Perpetua di conoscerlo, il povero curato, dopo aver fatto più volte giurare la serva che non fiaterebbe, le raccontò, con molte sospensioni e con molti ohimè, il suo miserabile caso. I pareri di Perpetua. – La donna, dopo una violenta reazione di sdegno, consigliò don Abbondio di informare di tutto l’arcivescovo, che era un sant’uomo e un uomo di polso; ma il povero curato non volle neppur sentirne parlare, perché, quando gli fosse toccata una schioppettata nella schiena, l’arcivescovo non gliela avrebbe certo potuta togliere. Poi, preso il lume, si avviò brontolando verso la sua camera; ma, giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, raccomandò ancora caldamente il silenzio «per amor del cielo!» e scomparve.
La notte di don Abbondio. – Si racconta che il principe di Condè dormì profondamente la notte prima della battaglia di Rocroi; ma don Abbondio, che sapeva soltanto che l’indomani sarebbe stato giorno di battaglia, e non aveva meditato alcun piano, passò gran parte della notte in consulte angosciose. Dopo essersi molto rivoltato nel letto, gli parve alfine che il partito migliore fosse quello di guadagnar tempo, menando Renzo per le lunghe, tanto più che mancavano solo pochi giorni al tempo proibito per le nozze, e, se avesse potuto tenere a bada quel ragazzone, avrebbe poi avuto due mesi di respiro, e in due mesi possono nascere molte cose. Presa questa decisione, potè finalmente chiuder occhio: ma che sonno! che sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. Il colloquio tra Renzo e don Abbondio. - Il mattino seguente Lorenzo, o, come dicevan tutti, Renzo, appena gli parve ora da non esser giudicato indiscreto, si presentò a don Abbondio con la lieta furia di un uomo di vent’anni, che deve in quel giorno sposare la donna che ama. Era in gran gala, con penne di vario colore al cappello, con un bel pugnale nel taschino dei calzoni, con una cert’aria di festa e nello stesso tempo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti. Don Abbondio l’accolse in modo incerto e misterioso. Renzo pensò che il curato avesse qualche pensiero per la testa, e gli chiese subito a quale ora gli faceva comodo che si trovassero in chiesa; ma don Abbondio prima finse di non ricordarsi che quello era il giorno fissato, poi protestò di non sentirsi bene, accennò a imbrogli, a ostacoli, a formalità non ancora compiute, numerando in latino, sulla punta delle dita, gli impedimenti dirimenti; infine chiese quindici giorni, una settimana almeno di tempo. Renzo dapprima si stupì, poi s’infuriò («che vuol ch’io faccia del suo latino-rum!»), ma poi, pur dichiarando che passata la settimana non si sarebbe più appagato di chiacchiere, finì col cedere. Renzo fa parlare Perpetua. - Uscito dalla casa di don Abbondio, Renzo tornò con la mente su quel colloquio, e sempre più lo trovava strano. Stette in forse un momento di tornare indietro, ma, vedendo Perpetua dinanzi a lui, che entrava in un orticello, si fermò ad attaccare discorso, col proposito di avere qualche maggiore spiegazione. Perpetua, pur giurando di non saper niente, lasciò capire con mezze parole che in tutta quella faccenda il suo padrone non aveva nessuna colpa, ma che si trattava di prepotenti e di birboni, di uomini senza timor di Dio… Renzo, nascondendo a stento l’agitazione che gli cresceva nel cuore, tentò ancora di strapparle il nome di colui che si opponeva al suo matrimonio; ma Perpetua, ripentendo che essa non sapeva nulla, entrò in fretta nell’orto, chiudendo l’uscio. Nuovo colloquio tra Renzo e don Abbondio. - Allora Renzo, confermato nei suoi sospetti, fu in un momento all’uscio di don Abbondio; si diresse difilato al salotto dove l’aveva lasciato, e con gli occhi stralunati gli chiese il nome del prepotente, che non voleva che egli sposasse Lucia. Don Abbondio, sorpreso e sbiancato come un cencio che esca dal bucato, spiccò un salto dal seggiolone per lanciarsi all’uscio; ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa, vi balzò prima di lui, girò la chiave e se la mise in tasca. Poi, forse senza avvedersene, mise la mano sul manico del coltello, che gli usciva dal taschino, ed assunse un aspetto così minaccioso, che don Abbondio, come avesse in bocca la tenaglia del cavadenti, fu costretto a rivelargli il nome di don Rodrigo. «Ah cane!» urlò Renzo. Il povero curato gli dipinse allora con colori terribili il brutto incontro, e lo rimproverò della bella prodezza di avergli voluto cavare di bocca ciò che egli nascondeva per prudenza e per suo bene. «Posso aver fallato», rispose Renzo, mentre apriva la porta. Don Abbondio, afferrandogli il braccio con la mano tremante, tentò di fargli giurare che avrebbe mantenuto il silenzio, ma il giovane, svincolandosi da lui, se ne partì con furia. Don Abbondio rimprovera Perpetua. – Don Abbondio, dopo aver richiamato invano il fuggitivo, si mise a chiamare Perpetua; ma questa non rispondeva ed egli non sapeva più in che mondo si fosse. Affannato e balordo, si rispose sul suo seggiolone, cominciando a sentirsi qualche brivido nelle ossa, e chiamando di tempo in tempo, con voce tremolante e stizzosa, Perpetua. Finalmente essa venne, con un gran cavolo sotto il braccio e con la faccia tosta, come se nulla fosse accaduto. Tra i due si svolse un colloquio assai agitato, a base di «voi sola potete aver parlato» e «non ho parlato». Basti dire che don Abbondio ordinò a Perpetua di metter la stanga all’uscio, di non aprire a nessuno, e, se alcuno bussasse, rispondere dalla finestra che egli era andato a letto con la febbre. E si mise a letto davvero. Renzo a casa di Lucia. – Renzo intanto camminava a passi infuriati verso la casa di Lucia, con la smania di vendicarsi di don Rodrigo. Avrebbe voluto correre alla casa di lui, o, poiché ciò era impossibile, prendere il suo schioppo, appiattarsi dietro una siepe, e, dopo avergli sparato, correre verso il confine e mettersi in salvo. Ma il ricordo di Lucia, scendendo ad un tratto fra quelle bieche fantasie, faceva subentrare al loro posto i migliori pensieri, a cui la sua mente era avvezza. Arrivò così alla casetta di Lucia, che era in fondo al villaggio, e che aveva dinanzi un piccolo cortile, cinto da un morettino. Appena entrato nel cortile, sentì un ronzìo che veniva da una stanza di sopra. S’immaginò che fossero le amiche e le comari, venute a far corteggio alla sposa, e non volle mostrarsi con quella notizia sul volto. Una fanciulletta, Bettina, che si trovava nel cortile, gli corse incontro, gridando: «lo sposo! Lo sposo!»; ed egli la mandò ad avvertire in segreto Lucia che l’attendeva nella stanza terrena. Lucia in abito da sposa. – Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche se la rubavano, ed essa si andava schermendo con la modestia un po’ guerriera delle contadine. I suoi neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, si ravvolgevano dietro il capo in molteplici trecce, trapassati da lunghi spilli d’argento, a guisa d’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati, alternati con bottoni d’oro a filigrana; portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastrini; una corta gonnella di seta, a pieghe fitte e riunite, due calze vermiglie, due pianelle di seta a ricami. Colloquio tra Renzo e Lucia. – Lucia, avvertita da Bettina, scese in fretta, e, vedendo la faccia e il portamento di Renzo, gliene chiese la causa, con un presentimento di terrore. Il giovane le raccontò brevemente la storia di quella mattina; e quando essa udì il nome di don Rodrigo: «Ah! – esclamò, arrossendo e tremando, - fino a questo segno!». Renzo le chiese ansioso che cosa sapeva, ma essa lo pregò di non farla parlare prima di aver chiamata la madre e licenziato le donne. Intanto la madre Agnese, messa in sospetto dallo sparire della figlia, era discesa a vedere che cosa c’era di nuovo. Lucia la lasciò con Renzo e andò ad avvertire le donne che per quel giorno non si faceva nulla, perché il curato era ammalato. Le donne si sparsero a raccontare l’accaduto, due o tre andarono fino all’uscio del curato, per verificare se era ammalato davvero. Perpetua rispose dalla finestra che aveva un febbrone, e così si troncarono le congetture, che già cominciavano a brulicare nei loro cervelli.
Lucia racconta l’incontro con don Rodrigo. – Lucia entrò nella stanza terrena mentre Renzo stava informando Agnese, e, con voce rotta dal pianto, raccontò come pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne, le era passato innanzi don Rodrigo, in compagnia di un altro signore, e aveva cercato di intrattenerla con chiacchiere non punto belle. Essa allora aveva affrettato il passo, raggiungendo le compagne; ma aveva sentito quell’altro signore ridere forte e don Rodrigo dire: «scommettiamo». Il giorno dopo coloro s’erano trovati ancora sulla strada, ma essa era nel mezzo delle compagne, con gli occhi bassi, e l’altro signore sghignazzava e don Rodrigo diceva: «vedremo, vedremo». Per grazia del cielo, quel giorno era l’ultimo della filanda. Essa aveva taciuto ogni cosa a sua madre, per non contristare la buona donna, per non mettere a rischio di viaggiare per molte bocche una storia che doveva esser gelosamente sepolta e che le nozze avrebbero troncata. Aveva però raccontato tutto in confessione al padre Cristoforo, ed egli le aveva consigliato di affrettare le nozze il più possibile e, nel frattempo, di starsene rinchiusa e di pregare il Signore. Fu allora che essa aveva pregato Renzo di concludere prima del tempo stabilito… Propositi di vendetta di Renzo. – Le parole di Lucia furono troncate da un violento scoppio di pianto, mentre Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza, e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello, gridava il suo proposito di volersi vendicare di don Rodrigo («Questa è l’ultima che fa quell’assassino!»). Lucia, tentando di calmare il giovane, propose di andare a stabilirsi lontano, dove colui non sentisse più parlare di loro; ma Renzo obbiettò che il curato non avrebbe dato loro la fede di stato libero, mentre, una volta maritati, tutto sarebbe stato più facile. Il consiglio di Agnese. – Dopo qualche momento Agnese prese a dire che il diavolo non è poi tanto brutto quanto si dipinge, e che il consiglio di un uomo che ha studiato avrebbe certo potuto aiutarli a trarsi d’imbarazzo. Essa propose a Renzo di recarsi a Lecco, da un certo dottore soprannominato Azzecca-garbugli (ma, per l’amor del cielo, non lo chiamasse così, chè questo era un soprannome!), una cima d’uomo, che aveva liberato molti da ben altri imbrogli. Renzo abbracciò molto volentieri questo parere, e Agnese, levati dalla stia quattro capponi, ai quali avrebbe dovuto tirare il collo per il banchetto di domenica, li consegnò al giovane perché da quei signori non bisognava mai andare con le mani vuote. Renzo uscì dalla parte dell’orto, per non essere veduto dai ragazzi, che gli sarebbero corsi dietro gridando: «lo sposo! Lo sposo!» e, mentre attraversava i campi, ripensando alla sua disgrazia, andava agitando quelle povere bestie secondo i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente. Renzo dal dottor Azzecca-garbugli. – Giunto al borgo, Renzo si fece indicare l’abitazione del dottor Azzecca-garbugli. Entrato in cucina, domandò alla serva se si poteva parlare al signor dottore. Essa, adocchiate le bestie, mise subito loro le mani addosso, benché Renzo si tirasse indietro, perché voleva che il dottore vedesse che egli portava qualche cosa. Questi capitò appunto mentre la donna diceva: «Date qui e andate innanzi», e con un «venite, figliolo», lo fece entrare nello studio. Renzo, ritto davanti al tavolo gremito di carte, con una mano nel cocuzzolo del cappello, che faceva girare con l’altra, cominciò col chiedere se, a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio, ci sia penale. Il dottore, credendo che la minaccia l’avesse fatta Renzo, disse che era un caso serio, contemplato in cento gride, e, cacciate le mani in quel caos di carte che aveva sul tavolo, ne prese una, la spiegò, e, tenendola sciorinata in aria, cominciò a leggere. Era una grida del 15 ottobre 1627, emessa dal governatore di don Gonzalo Fernandez de Cordova, che minacciava pene terribili contro tutti i prepotenti, compresi quelli che avessero tentato di impedire un matrimonio. Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l’occhio, cercando di mirar proprio quelle sacrosante parole, che gli parevano dover essere il suo aiuto. Il dottore, vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si meravigliava, e, ritenendo che egli fosse il colpevole, gli domandò perché si era fatto tagliare il ciuffo. Per intendere questa uscita, bisogna sapere che a quel tempo i bravi e i facinorosi d’ogni genere usavano portare un lungo ciuffo, che si tiravano poi sul volto, come una visiera, quando affrontavano qualcuno o stimavano necessario di travisarsi. Poiché Renzo, sorpreso, rispose che da povero figliuolo non aveva mai portato ciuffo in vita sua, il dottore, sempre convinto che egli fosse il colpevole, lo esortò a dire tutta la verità, poiché all’avvocato bisogna raccontare le cose chiare, a lui poi tocca imbrogliarle. Quando Renzo ebbe capito in quale equivoco era caduto il dottore, lo interruppe, dichiarando che la cosa era proprio tutta al rovescio, e che egli non aveva minacciato nessuno, ma che la bricconeria l’avevano fatta a lui e che egli era venuto per ottenere giustizia. Espose quindi il suo caso, nominando quel prepotente di don Rodrigo… Il dottore, sentendo pronunziare il nome di don Rodrigo, aggrottò le ciglia, aggrinzì il naso rosso, e, storcendo la bocca, dichiarò che non voleva sentire di quelle fandonie e che se ne lavava le mani. Poi spinse Renzo verso l’uscio, chiamò la serva e le ordinò di restituirgli i capponi. Renzo, più attonito e più stizzito che mai, dovette riprendersi le vittime rifiutate e ritornare al paese per raccontare alle donne il bel costrutto della sua spedizione. Fra Galdino. – Le donne, durante l’assenza di Renzo, dopo essersi tristemente levate il vestito delle feste, si erano messe a consultare di nuovo sul partito da prendere. Agnese parlava dei grandi effetti che si dovevano sperare dai consigli del dottore; ma Lucia diceva che bisognava aiutarsi in tutte le maniere, e che sarebbe stata una gran bella cosa far sapere a padre Cristoforo ciò che era accaduto. Mentre studiavano il modo di mettere in opera questo disegno, poiché esse in quel giorno non si sentivano il coraggio di andare al convento, distante di là forse due miglia, capitò per buona sorte fra Galdino, un laico cercatore cappuccino, che veniva alla cerca delle noci. Egli, dopo essersi lamentato per la scarsità dell’annata, prese a raccontare il gran miracolo delle noci, operato da padre Macario. Un giorno il padre Macario, passando attraverso il campo di un benefattore, lo vide intento ad abbattere un noce, che da tempo non produceva più frutti. Il buon padre esortò il benefattore a lasciare intatta la pianta, che in quell’anno medesimo avrebbe fatto più fiori che foglie. Il benefattore accondiscese e promise metà della raccolta per il convento. Infatti il noce fece in quell’anno noci a bizzeffe; ma il benefattore, prima di bacchiarle, morì, e il figlio, che era di stampo ben diverso, non solo non tenne fede alla promessa paterna, ma ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che i cappuccini sapessero far noci. Un giorno, però, quello scapestrato, che si vantava coi suoi amici del suo bel gesto, volle mostrar loro quello sterminato mucchio di noci; ma ebbe l’amara sorpresa di vedere, al posto delle noci, un bel mucchio di foglie secche. Da allora il convento raccolse ogni anno noci senza fine, e ne faceva tanto olio, che ogni povero veniva a prenderne: perché i conventi dei cappuccini sono come il mare, che riceve acqua da tutte le parti, e la torna a distribuire a tutti i fiumi. Frattanto Lucia, che era passata nell’altra stanza per prendere le noci, ritornò col grembiule così carico, che Angere le fece un volto attonito e severo per la sua prodigalità. Quindi Lucia pregò il frate di far sapere a padre Cristoforo che aveva gran premura di parlargli. Partito fra Galdino, Agnese biasimò la figlia per aver fatto una così abbondante elemosina, ma Lucia si giustificò, rispondendo che soltanto in quel modo il frate sarebbe tornato più presto al convento; e Agnese che, coi suoi difettucci, era una gran buona donna e si sarebbe buttata nel fuoco per quell’unica figlia, l’approvò. Ritorno di Renzo. – Frattanto tornò Renzo, che, gettati i capponi sul tavolo, raccontò il suo abboccamento col dottore. Agnese, stupefatta, avrebbe voluto dimostrare che il suo parere era buono e che Renzo non doveva aver saputo fare la cosa come andava fatta; ma Lucia troncò la discussione, dicendo che sperava di aver trovato un aiuto migliore. Renzo accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nella sventura o nell’impiccio; ma esclamò che, se non si fosse trovato un ripiego, avrebbe saputo farsi ragione da solo. Le donne consigliarono la pace, la pazienza, la prudenza; e, poiché incominciava ad imbrunire, si separarono tristemente, augurandosi la buona notte. Renzo, col cuore in tempesta, se ne tornò verso casa, ripetendo tra sé: «A questo mondo c’è giustizia finalmente!». Tant’è vero – commenta il Manzoni – che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dica. Il triste paesaggio d’autunno. – Il sole non era ancor tutto apparso sull’orizzonte, quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico, per salire alla casetta di Lucia. Pescarenico è un borgo di pescatori, che si trova sulla riva sinistra dell’Adda, o meglio del Lago, poco discosto dal ponte. Il convento era situato (e l’edificio ancora sussiste) al di fuori del borgo, lungo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno, un venticello d’autunno staccava dagli alberi le foglie appassite dei gelsi, nelle vigne brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte, ma ogni figura d’uomo rattristava lo sguardo e il pensiero. Ogni tanto si incontravano mendichi laceri e macilenti, che s’inchinavano al padre, per l’elemosina che avevano ricevuta o che andavano a cercare al convento; i lavoratori sparsi nei campi gettavano con risparmio la semente o lavoravano svogliatamente la zolla; la fanciulla scarna, che portava al pascolo la vaccherella magra e stecchita, le rubava qualche erba, di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevano vivere. Questi spettacoli accrescevano la mestizia del frate, il quale camminava già col triste presentimento di andare a sentire qualche sciagura. Padre Cristoforo. – Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant’anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno, s’alzava di tempo in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d’altero e d’inquieto, e subito s’abbassava, per riflessione d’umiltà; la barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, faceva ancor più risaltare le forme rilevate del volto; due occhi incavati, per lo più chinati a terra, sfolgoravano talvolta con vivacità repentina, come due cavalli bizzarri, condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno per esperienza che non si può vincerla, ma che fanno di tempo in tempo qualche sgambetto, che scontano subito con una buona tirata di morso. L’educazione di Lodovico. – Il padre Cristoforo non era stato sempre Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo di un mercante, che essendosi arricchito, aveva rinunziato al traffico, si era dato a vivere da signore, e aveva cercato ogni modo per far dimenticare che era stato mercante. Perciò aveva fatto educare il figlio nobilmente, dandogli maestri di lettere e d’esercizi cavallereschi. Lodovico aveva contratto abitudini signorili, ma quando volle mischiarsi coi nobili della sua città, vide che, a voler essere della loro compagnia, gli conveniva star sempre al di sotto e ingozzarne una ogni momento. Ciò non s’accordava né con la sua educazione, né con la sua natura. S’allontanò da essi indispettito, ma, volendo pure in qualche modo competere con essi, si era dato a fare sfoggio di magnificenze, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. Indole di Lodovico. – La sua indole, onesta insieme e violenta, gli faceva sentire un orrore spontaneo e sincero per le angherie, tanto più che le persone, che maggiormente ne commettevano, erano appunto coloro coi quali aveva ruggine. Così venne a costituirsi a poco a poco un protettore degli oppressi e un vendicatore dei tori. Ma non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. Oltre la guerra esterna, era tribolato continuamente da contrasti interni, perché a spuntarla in un impegno doveva anche lui adoperare raggiri e violenze, che la sua coscienza non poteva approvare. Doveva tenersi intorno un gran numero di bravacci, così che doveva vivere coi birboni per amore della giustizia. Tanto che più di una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate. Ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione a causa d’un accidente, il più serio che gli fosse ancora capitato. Incontro con un prepotente. – Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi e da un tale Cristoforo, maestro di casa, molto a lui affezionato, quando vide spuntar da lontano un signore, seguito da quattro bravi, col quale non aveva mai parlato, ma che gli era cordiale nemico, e al quale rendeva pur di cuore il contraccambio. Tutti e due camminavano rasenti al muro, ma Lodovico lo strisciava col lato destro, e ciò, secondo consuetudine, gli dava il diritto di non staccarsi dal muro per dare il passo ad altri; l’altro pretendeva all’opposto che quel diritto competesse a lui, come a nobile, e che a Lodovico toccasse andare nel mezzo, e ciò in forza di un’altra consuetudine. Quando si trovarono a viso a viso, il signor tale, squadrando Lodovico con cipiglio imperioso, pretese che gli cedesse la diritta, ma Lodovico gli rispose con egual arroganza. Dalle parole passarono ai fatti, e, sfoderate le spade, si avventarono l’uno contro l’altro, mentre i servitori si slanciavano alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale, sia per il numero, sia perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo, mentre questi voleva ad ogni costo la sua morte. Lodovico aveva già ricevuto una pugnalata al braccio sinistro da un bravo, e una sgraffiatura leggera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo, quando Cristoforo, vedendo il suo padrone all’estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questi, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Lodovico, come fuori di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, che cadde moribondo, quasi insieme col povero Cristoforo. I bravi, visto ch’era finita, si diedero alla fuga, e Lodovico si trovò solo, con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo ad una gran folla. Il fatto era accaduto vicino ad una chiesa di cappuccini, asilo allora impenetrabile alla giustizia. Lodovico, ferito, fu qui portato dalla folla, che lo raccomandava dicendo: «è un uomo dabbene che ha freddato un birbone superbo; l’ha fatto per sua difesa: c’è stato tirato per i capelli». Lodovico decide di farsi frate. – Lodovico, che non aveva mai prima d’allora sparso sangue, benché l’omicidio fosse a quei tempi cosa molto comune, vedendo l’uomo morto per lui e l’uomo morto da lui, ricevette un’impressione nuova e invincibile. Riflettendo ai casi suoi, sentì rinascere più che mai vivo e serio quel pensiero di farsi frate, che altre volte gli era passato per la mente: gli parve che Dio medesimo l’avesse messo sulla strada e datogli un segno del suo volere, facendolo capitare in un convento in quella congiuntura: e il partito fu preso. La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, che per cagione sua erano in un bell’intrigo, perché la famiglia dell’ucciso, che era assai potente, voleva ad ogni costo nelle unghie l’uccisore, vivo o morto. Ora questo, vestendo l’abito da cappuccino, accomodava ogni cosa. Il fratello dell’ucciso impose come condizione che Lodovico partisse subito da quella città; e il padre guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l’altro credesse, se gli piaceva, essere questo un atto d’ubbidienza, e tutto fu concluso. Così Lodovico a trent’anni si ravvolse nel sacco; e dovendo, secondo l’uso, lasciare il suo nome e prenderne un altro ne scelse uno che gli rammentasse in ogni momento ciò che doveva espiare, e si chiamò fra Cristoforo. Padre Cristoforo chiede perdono alla famiglia dell’ucciso. – Appena compiuta la cerimonia della vestizione, il guardiano intimò a fra Cristoforo che sarebbe andato lontano a fare il noviziato, ed egli chiese per grazia, prima di partire, di poter chiedere perdono al fratello dell’ucciso. Il gentiluomo pensò che, quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico; e invitò in fretta tutti i parenti per ricevere una soddisfazione comune. Il giorno dopo, a mezzogiorno, il palazzo brulicava di gente. Fra Cristoforo vide quell’apparecchio, ne indovinò il motivo e provò un leggero turbamento, ma pensò subito che come pubblico era stato lo scandalo, pubblica doveva essere la riparazione. Giunto davanti al fratello dell’ucciso, gli si pose in ginocchioni ai piedi, incrociò le mani al petto e chiese umilmente perdono. Quando egli tacque, s’alzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata e d’ira compressa, turbato da quelle parole, lo costrinse ad alzarsi, e, trasportato da quella commozione generale, gli gettò le braccia la collo, e gli diede e ne ricevette il bacio di pace. Un «bravo! Bene!» scoppiò da tutte le parti della sala; tutti si mossero e si strinsero intorno al frate. Il pane del perdono. – Vennero poi servitori con gran copia di rinfreschi, ma fra Cristoforo non volle che un semplice pane, come segno di carità e di perdono. Chiese quindi licenza, si liberò a fatica da tutti coloro che, trovandosi più vicini, gli baciavano il lembo dell’abito, il cordone, il cappuccio; e si trovò sulla strada, portato come in trionfo. Una folla di popolo lo accompagnò fino alla porta della città, da dove uscì per cominciare il suo viaggio ai piedi verso il luogo del suo noviziato. In tal modo il fratello dell’ucciso e il parentado, che s’erano aspettati d’assaporare in quel giorno la trista gioia dell’orgoglio, si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. Padre Cristoforo camminava, con una consolazione che non aveva mai più provata dopo quel giorno terribile. Fermatosi, all’ora della refezione, presso un benefattore, mangiò con una specie di voluttà pane del perdono; ma ne serbò un pezzo, come un ricordo perpetuo. Vita claustrale di padre Cristoforo. – Da allora, adempiendo sempre con gran voglia e con gran cura gli uffici, che gli venivano ordinariamente assegnati, di predicare e di assistere i moribondi, non lasciava ma sfuggire l’occasione di esercitarne altri due, che s’era imposti da sé: accomodare differenze e proteggere oppressi. Se una poverella sconosciuta, nel triste caso di Lucia, avesse chiesto il suo aiuto, egli sarebbe corso immediatamente. Trattandosi poi di Lucia, accorse con tanta più sollecitudine, in quanto conosceva l’innocenza di lei e sentiva una indignazione santa per la turpe persecuzione della quale era divenuta l’oggetto. Ma mentre abbiamo raccontato i fatti di padre Cristoforo, egli è arrivato e s’è affacciato all’uscio; e le donne, lasciando il manico dell’aspo che facevan girare, si sono alzate dicendo a una voce: «Oh padre Cristoforo! Sia benedetto!».
Agnese narra a padre Cristoforo l’accaduto. - Padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia, e, appena ebbe data un’occhiata alle donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi. Lucia scoppiò in pianto, Agnese cominciò a fare le scuse d’aver osato disturbarlo, ma il frate, messosi a sedere sur un banchetto a tre piedi, troncò i complimenti, chiedendo alle donne di raccontargli ogni cosa. Mentre Agnese faceva alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate diventava di mille colori, e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi. Terminata la storia, si coprì il volto con le mani ed esclamò: «O Dio benedetto! Fino a quando…!». Ma, senza compiere la frase, si rivolse di nuovo alle donne, dicendo: «Dio vi ha visitate. Povera Lucia!». Padre Cristoforo decide di recarsi da don Rodrigo. – Dopo aver contrappesato il pro e il contro di questo o di quel partito, il migliore gli parve d’affrontare don Rodrigo stesso, tentare di smuoverlo dal suo infame proposito, con le preghiere, coi terrori dell’altra vita, o anche di questa, se fosse possibile. Sopraggiunse intanto Renzo, che, vedendo padre Cristoforo, si lasciò sfuggire di aver compiuto dei tentativi infruttuosi presso i suoi amici per averli alleati nella vendetta; ma il frate, afferrato il braccio del giovane, lo esortò a lasciarsi guidare da lui e a non provocare nessuno. Poi, dopo aver promesso che sarebbe ritornato la sera, o al più tardi il mattino seguente, troncò tutti i ringraziamenti e le benedizioni, e partì. S'avviò al convento, arrivò a tempo per andare in coro a cantare sesta, desinò, e si mise subito in cammino verso il covile della fiera, che voleva provarsi di ammansire. Il palazzotto di don Rodrigo. – Il palazzotto di don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza di una bicocca, sulla cima di un poggio, più in su del paesello di Renzo e Lucia, discosto da questo forse tre miglia, e quattro dal convento. Ai piedi del poggio, dalla parte che guarda a mezzogiorno e verso il lago, giaceva un mucchietto di casupole, abitate da contadini di don Rodrigo, ed era come la capitale del suo piccolo regno. Padre Cristoforo attraversò il villaggio, salì per una viuzza a chiocciola, e pervenne su una piccola spianata, davanti al palazzotto. La porta era chiusa, segno che il padrone stava desinando e non voleva essere disturbato. Si sarebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata, se quattro creature, due vive e due morte, collocate di fuori, non avessero dato indizio che era abitata. Due grandi avvoltoi, con l’ali spalancate e coi teschi penzoloni, erano inchiodati sur un battente del portone; e due bravi, ciascuno sur una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando di essere chiamati a godere gli avanzi della tavola. Il padre si fermò ritto, in atto di chi si dispone ad aspettare; ma uno dei bravi lo invitò ad entrare, dando due picchi col martello. Si udì dal di dentro gli urli e le strida di mastini e di cagnolini; e, pochi momenti dopo, giunse un vecchio servitore, che, guardando il padre con una cert’aria di meraviglia e di rispetto, lo condusse fino all’uscio della sala del convito. Padre Cristoforo nella sala del convito. – Padre Cristoforo stava contrastando col servitore per ottenere di esser lasciato in qualche canto della casa, finchè il pranzo fosse terminato, quando l’uscio si aprì, e un certo conte Attilio, cugino di don Rodrigo, veduta una testa rasa e una tonaca, gridò: «Ehi! Ehi! Non ci scappi, padre riverito: avanti, avanti». Don Rodrigo, senza indovinare precisamente il soggetto di quella visita, pure, per non so quale presentimento, ne avrebbe fatto a meno; ma poiché quello spensierato di Attilio aveva fatto quella gran chiamata, non conveniva a lui tirarsi indietro, e disse: «Venga, padre, venga». Il padre s’avanzò, inchinandosi al padrone, e rispondendo a due mani al saluto dei commensali. I commensali. – Don Rodrigo sedeva a capo tavola. Alla sua destra era il conte Attilio, venuto da Milano a villeggiare per alcuni giorni; a sinistra, a un altro lato della tavola, stava il podestà del paese, quello stesso a cui in teoria sarebbe toccato far giustizia a Renzo e far stare a dovere don Rodrigo; a destra, in faccia al podestà, in atto di un rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il dottor Azzecca-garbugli, in cappa nera e col naso più rubicondo del solito; in faccia a don Rodrigo e al conte Attilio vi erano due invitati oscuri, che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e approvare ogni cosa dicesse un commensale e a cui un altro non contraddicesse. Il convito. – Padre Cristoforo si scusò con don Rodrigo di essere venuto in un’ora poco opportuna, e gli soggiunse all’orecchio, con voce più sommessa, di volergli parlare da solo a solo, con suo comodo, per un affare d’importanza. Don Rodrigo lo fece sedere, e, benché il padre si schermisse, gli fece portare da bere, perché non fosse mai vero che un cappuccino tornasse via da quella casa senza aver gustato del suo vino, o un creditore insolente senza aver assaggiato la legna dei suoi boschi. Padre Cristoforo dovette in tal modo assistere alla continuazione del pranzo, fra discussioni di cavalleria e di politica, che poco potevano interessarlo. Discussione su un problema di cavalleria. - Il conte Attilio sosteneva, con sprezzante arroganza, che un messo, il quale ardisca di porre in mano a un cavaliere una sfida, senza avergliene chiesta licenza, è un temerario, violabile, violabilissimo, bastonabile, bastonabilissimo. Il podestà, a sua volta, sosteneva, con dottrinaria cocciutaggine, che ogni passeggero è di sua natura inviolabile, per diritto delle genti, iure gentium, come dice anche il proverbio: ambasciator non porta pena. Don Rodrigo, che non avrebbe voluto che la questione andasse troppo avanti, propose, non senza ironia, che fosse rimessa a padre Cristoforo, il quale non era venuto al mondo col cappuccio in capo e aveva anch’egli, conosciuto il mondo. Il padre, dopo essersi invano schermito, enunciò il suo debole parere, che non vi dovrebbero essere né sfide, né bastonate, suscitando in tal modo le meraviglie e le proteste di tutti i commensali. Discussione sulla guerra. – Ma don Rodrigo, volendo troncare quella questione, portò il discorso sulla guerra di successione per il ducato di Mantova, che, alla morte di Vincenzo Gonzaga, era passata al duca di Nevers, suo parente più prossimo. Luigi XIII e il cardinale di Richelieu sostenevano questo principe, naturalizzato francese; mentre Filippo IV e il suo ministro conte d’Olivares, comunemente chiamato il conte duca, lo contrastavano; e poiché quel ducato era feudo dell’Impero, ambedue le parti si adoperavano presso l’imperatore Ferdinando II perché si risolvesse per l’una o per l’altra di esse. Anche qui il conte Attilio prese a contraddire il podestà, il quale, allegando la sua amicizia col signor castellano (=capitano) spagnolo, difendeva la tesi di Spagna e levava alle stelle il conte d’Olivares. Don Rodrigo intervenne di nuovo con un’occhiata presso il cugino, per fargli intendere che, per amor suo, cessasse di contraddire. Il conte tacque, e il podestà, come un bastimento disimbrogliato da una secca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. E chissà quando avrebbe preso terra, se don Rodrigo, che vedeva fremere il cugino, non avesse fatto portare un certo fiasco, per fare un brindisi al conte duca. Anche padre Cristoforo fu costretto ad associarsi al brindisi, mentre il dottor Azzecca-garbugli pronunciò con enfasi un elogio dei vini e dei pranzi dell’Illustrissimo signor don Rodrigo, dal cui palazzo la carestia era bandita e confinata in perpetuo. Accenno alla carestia. – La parola carestia, che il dottore aveva buttato fuori a caso, rivolse in un punto tutte le menti su quel triste soggetto. I convitati furono tutti d’accordo nell’urlare che carestia non c’era e che era tutta speculazione degli incettatori e dei fornai. Il disparere era solo sui rimedi da adottare: il podestà voleva dei buoni processi; il conte Attilio, seguito dagli altri, gridava che bisognava prendere coloro che, per voce pubblica, erano conosciuti come i più ricchi e i più cani, e impiccarli. Don Rodrigo intanto, che vedeva il padre Cristoforo sempre zitto e fermo, senza segno d’impazienza o di fretta, avrebbe fatto volentieri a meno di quel colloquio; ma congedare un cappuccino senza avergli dato udienza, non era secondo la regola della sua politica. Poiché la seccatura non si poteva evitare, si risolvette di affrontrla subito. S’alzò da tavola, e con lui tutta la rubiconda brigata, senza interrompere il chiasso. Chiesta poi licenza agli ospiti, si avvicinò in atto contegnoso al frate, che si era subito alzato con gli altri e gli disse: «Eccomi ai suoi comandi!»; e lo condusse in un’altra sala.
Il colloquio tra padre Cristoforo e don Rodrigo. – Don Rodrigo, piantatosi in piedi nel mezzo della sala, chiese a padre Cristoforo in che cosa potesse servirlo; ma il tono, con cui furono proferite le parole, voleva dir chiaramente, bada a chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati. Fu appunto questo tono, che diede coraggio al nostro padre Cristoforo e gli fece venir sulle labbra più parole del necessario. Temperò tuttavia le frasi, che gli si erano presentate alla mente, e disse con guardinga umiltà che era venuto a proporre un atto di giustizia, poiché certi uomini di mal affare avevano messo innanzi il nome di don Rodrigo per far paura a un povero curato e soverchiare due innocenti. Egli avrebbe potuto, con una parola, confondere coloro, restituire al diritto la sua forza, e sollevare quelli a cui era stata fatta una così crudele violenza…. Don Rodrigo lo interruppe con arroganza, ma padre Cristoforo, appellandosi a quel Dio, al cui cospetto dobbiamo tutti comparire, lo esortò a non ostinarsi a negare una giustizia così facile, per non doversi un giorno pentire di non aver ascoltato la parola di un ministro di Dio. Allora don Rodrigo ribattè con insolenza che aveva capito che una fanciulla gli stava molto a cuore, e poiché il padre credeva che egli potesse molto per lei, lo consigliò di metterla sotto la sua protezione. A questa proposta l’indignazione del frate, trattenuta a stento fino allora, traboccò; e piantando in faccia a don Rodrigo due occhi infiammati, gli rispose fieramente che quella innocente era sotto la protezione di Dio, e che aveva compassione di quella casa, sulla quale era sospesa la maledizione. «Verrà un giorno…». Don Rodrigo, che era rimasto fin allora tra la rabbia e la rabbia meraviglia, non trovando parole, quando sentì intonare quella predizione s’aggiunse in lui alla rabbia un lontano e misterioso spavento. Afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa, e, alzando la voce per troncare quella dell’infausto profeta, gridò: «Escimi di tra i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato». Così dicendo, additò, con un gesto imperioso, un uscio in faccia a quello per cui erano entrati; e il padre Cristoforo chinò il capo e se ne andò, lasciando don Rodrigo a misurare, a passi infuriati, il campo di battaglia. Il vecchio servitore. – Quando il frate ebbe chiuso l’uscio dietro a sé, vide nell’altra stanza, in cui entrava, un uomo ritirarsi pian piano, strisciando lungo il muro, come per non essere veduto dalla stanza del colloquio; e riconobbe il vecchio servitore, che era venuto a riceverlo alla porta di strada. Costui era in quella casa forse da quarant’anni, cioè prima che nascesse don Rodrigo, poiché vi era entrato al servizio del padre, il quale era stato tutt’altra cosa. Morto lui, il nuovo padrone, dando lo sfratto a tutta la famiglia, aveva trattenuta quel servitore, sia perché già vecchia, sia perché, sebbene di massime e di costume diversi, aveva un’alta opinione della dignità della casa e una gran pratica del cerimoniale. Il padre Cristoforo, passando, lo salutò; il vecchio gli si accostò misteriosamente, mise un dito sulla bocca, e, fatto cenno di seguirlo in un andito buio, gli disse che aveva sentito tutto, che sapeva molte cose, e che si sarebbe recato l’indomani al convento per riferirgli tutto ciò che avesse scoperto. Uscito fuori, e voltate le spalle a quella casaccia, padre Cristoforo respirò più liberamente, sebbene ancor tutto infuocato in volto per quello che aveva sentito e per quello che aveva detto. Ma quella così inaspettata esibizione del vecchio gli parve un filo che la Provvidenza gli mettesse nelle mani in quella casa medesima, senza che egli avesse sognato neppure di cercarlo. Allora, rimanendo ben poco del giorno, affrettò il passo, per poter portare un avviso, qual si fosse, ai suoi protetti, e arrivare al convento prima di notte, che era una delle leggi più precise e più severamente mantenute dal codice cappuccinesco. La proposta di Agnese. – Intanto nella casetta di Lucia, dopo la partenza del frate, Agnese aveva maturato ed esposto un suo progetto. Essa sapeva che, per fare un matrimonio, ci vuole bensì il curato, ma non è necessario che voglia, basta che ci sia. Occorrono due testimoni; si va dal curato, in modo da chiapparlo all’improvviso, che non abbia tempo di scappare; l’uomo dice: signor curato, questo è mio marito; se il curato sente, sei testimoni sentono, il matrimonio è bell’e fatto. Renzo accettò subito la proposta; ma Lucia, sentendo che non bisognava parlarne a padre Cristoforo, perché «i religiosi dicono che veramente è cosa che non istà bene», non ne fu molto convinta. Renzo in cerca di testimoni. - Renzo uscì in fretta per procurarsi i due testimoni. Le tribolazioni aguzzano il cervello, e il giovane, in questo caso, ne aveva immaginata una, da fare onore ad un giureconsulto. Andò alla casetta di un certo Tonio, che era lì poco distante, e lo trovò in cucina, che dimenava, col matterello ricurvo, una piccola polenta bigia, di grano saraceno. La madre, un fratello, la moglie, erano a tavola; e tre o quattro ragazzetti, ritti accanto al babbo, stavano aspettando, con gli occhi fissi al paiolo che venisse il momento di scodellare. Ma la mole della polenta era in ragione dell’annata, e non del numero e della buona voglia dei commensali. Renzo invitò Tonio ad andare a mangiare all’osteria, e la proposta fu accettata con entusiasmo da lui e da tutti i familiari, i quali non videro mal volentieri che si sottraesse alla polenta un concorrente, e il più formidabile. Giunti all’osteria del villaggio, e fatto portare quel poco che si trovava e un boccale di vino, Renzo propose a Tonio di pagargli un debito di venticinque lire, che egli aveva col curato per l’affitto di un campo, e che il curato gli ricordava tutte le volte e che lo vedeva; e Tonio, a sua volta, lieto di pagare il debito e di riavere la collana d’oro della moglie, che aveva barattata con tanta polenta, s’impegnò di venir a far da testimonio, portando con sé quel sempliciotto di suo fratello Gervaso. L’opposizione di Lucia. – Usciti dall’osteria, Tonio s’avviò verso casa, studiando la fandonia che avrebbe raccontato alle donne, e Renzo ritornò da Agnese e da Lucia per rendere loro conto dei concerti presi. Agnese s’incaricò di pensare a Perpetua, in modo da allontanarla dalla casa del curato; ma Lucia non si lasciava smuovere, perché non voleva sentir parlare di sotterfugi, di bugie, di finzioni. Mentre la disputa continuava, e non pareva vicina a finire, si sentì un calpestio affrettato di sandali e un rumore di tonaca sbattuta. Agnese ebbe appena il tempo di sussurrare all’orecchio di Lucia di non parlare del disegno da le proposto, che comparve padre Cristoforo. Padre Cristoforo ritorna alla casa di Lucia. – Padre Cristoforo giunse alla casa di Lucia, portando la triste notizia che non c’era nulla da sperare da quell’uomo. Le donne abbassarono il capo, ma nell’animo di Renzo l’ira prevalse sull’abbattimento, tanto più che, in quel momento, egli era esacerbato dalle ripulse di Lucia. Il frate tentò di calmarlo, raccomandando la fiducia in Dio; poi, rivolgesi a tutti, disse che sperava di aver in mano un filo per aiutarli: per questo motivo il giorno dopo non avrebbe potuto muoversi dal convento, ed essi avrebbero dovuto inviare da lui una persona fidata per sapere ciò che occorresse fare. Detto questo, uscì in fretta, correndo quasi a saltelloni giù per la viottola storta e sassosa, perché, se forre arrivato tardi al convento, avrebbe corso il rischio di buscarsi una penitenza, che gli avrebbe impedito il giorno dopo di trovarsi pronto a ciò che poteva richiedere il bisogno dei suoi protetti. Lucia acconsente al matrimonio per sorpresa. – Renzo, rimasto solo con le donne, uscì allora in aperte minacce di uccidere don Rodrigo. Lucia ne fu atterrita, e, per calmare l’ira del giovane, si affrettò a promettere che sarebbe andata la sera dopo dal curato per fare il matrimonio clandestino; né – osserva il Manzoni – si può dire se essa fosse, in tutto e per tutto, malcontenta di essere stata spinta ad acconsentire. Era intanto sopraggiunta la notte, e Renzo dovette congedarsi, poiché alle donne non pareva cosa conveniente che egli si trattenesse più a lungo a quell’ora. Ma l’indomani si fece vedere di buon’ora e concertò con Agnese la grande operazione della sera, proponendo e sciogliendo a vicenda le eventuali difficoltà. Agnese manda Menico da padre Cristoforo. – Agnese andò poi a una casa vicina per cercare Menico, un ragazzetto di circa dodici anni, che, per via di cugini e di cognati, veniva a essere un po’ suo nipote. Lo chiese ai parenti, come prestito, per tutto quel giorno, gli diede la colazione, e lo mandò al convento, da padre Cristoforo, facendogli molte raccomandazioni e promettendogli in premio alcune monete. I falsi mendicanti. – Nel rimanente di quella lunga mattinata si videro certe novità, che misero un poco in sospetto l’animo già conturbato delle donne. Prima fu un mendico, che aveva un non so che di oscuro e di sinistro nelle sembianze, il quale entrò a chiedere la carità, dando in qua e in là certe occhiate da spione, e si trattenne facendo molte domande, alle quali Agnese si affrettò a rispondere sempre il contrario di quello che era. Quando andò via, finse di sbagliare l’uscio, entrò in quello che metteva alla scala, e diede anche lì in fretta un’occhiata. Dopo costui continuarono a farsi vedere di tempo in tempo altre strane figure. Uno entrava col pretesto di farsi insegnare la strada; altri, passando davanti all’uscio, rallentavano il passo, come chi vuol vedere senza dare sospetto. Finalmente, verso mezzogiorno, quella fastidiosa processione finì; ma nelle due donne rimase una non so quale inquietudine, che levò loro, e principalmente a Lucia, una gran parte del coraggio, che avevano messo in serbo per la sera. Don Rodrigo medita il rapimento di Lucia. – Per sapere chi erano questi ronzatori misteriosi, bisogna ritrovare don Rodrigo, che abbiamo lasciato solo, in una sala del suo palazzotto, al partire del padre Cristoforo. Don Rodrigo, come abbiamo detto, misurava innanzi e indietro, a passi lunghi, quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia, di varie generazioni. Quando si trovava col viso a una parete, e voltava, si vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore dei nemici e dei suoi soldati; quando gli era arrivato sotto, e voltava, vedeva in faccia un altro antenato, magistrato, terrore dei litiganti e degli avvocati; di qua una matrona, terrore delle sue cameriere, di là un abate, terrore dei suoi monaci: tutta gente, insomma, che aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle tele. Alla presenza di tali memorie, don Rodrigo non poteva darsi pace che un frate avesse osato venirgli addosso. Formava un disegno di vendetta, l’abbandonava, pensava come soddisfare insieme alla passione e a ciò che chiamava onore; e talvolta, sentendosi fischiare ancora negli orecchi quell’esordio di profezia, si sentiva venire, come si dice, i bordoni, e stava quasi per deporre il pensiero delle due soddisfazioni. Finalmente, per far qualche cosa, si fece portar spada, cappa, cappello, ordinò sei persone di seguito per la passeggiata, e uscì più burbero, più superbioso, più accigliato del solito, dirigendosi verso Lecco. Per passare un poco la mattana, e per contrapporre all’immagine del frate immagini del tutto diverse, entrò quel giorno in una casa, dove andava per il solito molta gente, e dove fu ricevuto con quella rispettosa cordialità, che è riservata agli uomini che si fanno molto amare o molto temere; e a notte già fatta tornò al suo palazzotto. La mattina seguente, l’apprensione che quel verrà un giorno gli aveva messo in corpo, era svanita del tutto coi sogni della notte; e gli rimaneva soltanto la rabbia, esacerbata anche dalla vergogna di quella debolezza passeggera. Appena alzato, fece chiamare il Griso, il capo dei bravi, il fidatissimo del padrone, quello a cui si imponevano le imprese più rischiose e più inique. Dopo aver ammazzato uno, di giorno, in piazza, era andato ad implorare la protezione di don Rodrigo; e questo, vestendolo della sua livrea, l’aveva messo al coperto da ogni ricerca della giustizia. Don Rodrigo gli impose di rapire entro l’indomani Lucia, e di portargliela al palazzo, ma senza farle nulla di male. Il Griso promise che sarebbe fatto, e insieme concertarono la maniera di condurre a fine l’impresa, d’imporre silenzio alla povera Agnese, d’incutere a Renzo tale spavento, da fargli passare il dolore e il pensiero di ricorrere alla giustizia, e tutte le altre bricconerie necessarie alla riuscita della bricconeria principale. La mattina fu spesa in giri per riconoscere il paese. Quel falso pezzente, che s’era inoltrato a quel modo nella casetta, non era altro che il Griso, il quale veniva per levarne a occhio la pianta; i falsi viandanti erano i suoi ribaldi. Tornati poi al palazzotto, il Griso rese conto di quanto era stato fatto, fissò definitivamente il disegno dell’impresa, assegnò le parti e diede istruzioni. Il vecchio servitore avverte padre Cristoforo. – Tutto ciò non si poté fare, senza che quel vecchio servitore, che stava a occhi aperti, non s’accorgesse che si macchinava qualche gran cosa. Quando riuscì a venire in chiaro di ciò che si doveva eseguire quella notte, il povero vecchio, benché capisse che rischioso gioco giocava, si avviò in fretta al convento, per dare al padre Cristoforo l’avviso promesso. L’imboscata. – Intanto una piccola avanguardia di bravi era andata ad imboscarsi in un casolare diroccato, fuori del paese, poco distante dalla casetta di Lucia. Poco dopo altri bravi discesero alla spicciolata, per non parere una compagnia; venne infine il Griso, e non rimase indietro che una bussola (cioè una specie di portantina), che doveva essere portata al casolare a sera inoltrata. Radunati che furono in quel luogo, il Griso spedì tre dei suoi uomini all’osteria del paesetto, per spiare se qualcosa ci fosse da spiare; mentre egli, col grosso della truppa, rimase nell’agguato ad aspettare. Renzo con Tonio e Gervaso all’osteria. – Il povero vecchio servitore trottava ancora, i tre esploratori arrivavano al loro posto e il sole cadeva, quando Renzo entrò dalle donne per avvertirle che sarebbe andato all’osteria con Tonio e Gervaso a mangiare un boccone e che all’avemaria sarebbe venuto a prenderle. Quando Renzo e i due compagni giunsero all’osteria, vi trovarono uno degli uomini del Griso, già piantato in sentinella, che ingombrava il vano della porta come una cariatide; tanto che il giovane, intento a schivare ogni questione, dovette passare per isbieco, col fianco innanzi, e i due compagni dovettero fare la stessa evoluzione. Entrati, videro gli altri due bravacci, che giocavano alla morra, con un gran fiasco che era tra loro; e uno d’essi, tenendo una mano in aria, squadrò Renzo da capo a piedi, e diede un’occhiata al compagno e a quello dell’uscio, che rispose con un cenno del capo. Renzo insospettito e incerto, domandò all’oste chi fossero quei forestieri, ma l’oste non seppe o non volle dare una risposta precisa, limitandosi a dire che erano dei galantuomini. A sua volta il bravo, che aveva squadrato il nostro giovane, si accostò all’oste in cucina, e gli domandò informazioni su Renzo e i suoi compagni, e l’oste, in questo caso, fu molto più esplicito. La cena non fu molto allegra. I due convitati avrebbero voluto godersela con tutto loro comodo; ma Renzo, infastidito per lo strano contegno di quegli sconosciuti, non vedeva l’ora di andarsene. Appena uscito, s’accorse che i due, che aveva lasciati all’osteria, lo seguivano. Si fermò allora coi suoi compagni, come se dicesse: vediamo cosa vogliono da me costoro; ma i due, quando si accorsero di essere osservati, si parlarono sottovoce e tornarono indietro. Renzo, Tonio e Gervaso alla casetta di Lucia. – Cominciava intanto quel brulichio, quel ronzio, che si sente in un villaggio, sulla sera, e che, dopo pochi momenti, dà luogo alla quiete solenne della notte. Quando Renzo vide che i due indiscreti si erano ritirati, continuò la sua strada nelle tenebre crescenti, dando sottovoce ora un avvertimento, ora un altro ai due fratelli. Arrivarono alla casetta di Lucia che era già notte. Al picchiare sommesso di Renzo, Lucia fu assalita da tanto terrore, che avrebbe voluto in quel momento soffrire ogni cosa, piuttosto che eseguire quella risoluzione; ma quando Renzo si fu fatto vedere ed ebbe detto: «Son qui, andiamo», Lucia non ebbe tempo né forza di fare difficoltà, prese tremando un braccio della madre, un braccio del promesso sposo, e si mosse con la brigata avventuriera. Verso la casa di don Abbondio. – Zitti, zitti, nelle tenebre, evitando di attraversare il paese per non essere visti, si diressero, tra gli orti e i campi, verso la casa di don Abbondio. Qui giunti, si divisero. I due promessi rimasero nascosti dietro l’angolo della casa; Agnese rimase con loro, ma un po’ più innanzi, per accorrere in tempo a fermare Perpetua; Tonio e Gervaso picchiarono alla porta. Si affacciò alla finestra Perpetua, e Tonio le disse che aveva appena riscosso dei denari e che era venuto a saldare il suo debito, prima di mutar parere. Perpetua si diede a protestare che quella non era ora da cristiani, ma poi corse ad avvertire il curato. A questo punto Agnese, dopo aver fatto coraggio a Lucia, si riunì ai due fratelli davanti all’uscio, e si mise a ciarlare con Tonio, in modo che Perpetua, venendo ad aprire, dovesse credere che si fosse abbattuta lì a caso e che Tonio l’avesse trattenuta un momento Carneade. - «Carneade! Chi era costui?», ruminava tra sé don Abbondio, seduto sul seggiolone, con un libricciolo aperto davanti, quanto Perpetua entrò a portargli l’ambasciata. Bisogna sapere che don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno; e un curato suo vicino, che aveva un po’ di libreria, gli prestava un libro dopo l’altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento don Abbondio era un panegirico in onore di San Carlo, in cui il santo era paragonato, per l’amore dello studio, ad Archimede, e fin qui don Abbondio non trovava inciampo; ma, dopo Archimede, l’oratore chiamava a paragone anche Carneade, e lì il lettore era rimasto arenato. Proprio in quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio. Don Abbondio si meravigliò che l’ora indiscreta, ma persuaso che, se non prendeva quel momento per riscuotere il credito, chissà quando se ne sarebbe presentato un altro, disse di farlo entrare. Agnese trattiene Perpetua. – Perpetua scese ad aprire, ma, mentre Tonio entrava, venne avanti Agnese e salutò Perpetua per nome. Poi disse che veniva da un paesello vicino, dove aveva trovato una donna, la quale si ostinava ad affermare che Perpetua non si era mai maritata con Beppe Suolavecchia e Anselmo Lunghigna perché non l’avevano voluta, mentre era tutto il contrario. Questo argomento, che toccava un debole di Perpetua, suscitò naturalmente le ire e le esclamazioni della donna; e poiché di fronte alla casa di don Abbondio si apriva, tra due casupole, una stradetta che, finite quelle, voltava in un campo, Agnese vi si avviò come se volesse parlare più liberamente. Quando furono in luogo, dove non si poteva più vedere ciò che accadesse dinanzi alla casa di don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio, e tutt’e due in punta di piedi, zitti, zitti, entrarono nell’andito, dove erano i due fratelli ad aspettarli. Poi tutti salirono le scale, e, giunti sul pianerottolo, i due fratelli entrarono nella stanza del curato. Renzo e Lucia alla presenza di don Abbondio. – Don Abbondio, dopo aver rimproverato Tonio per l’ora, prese le venticinque berlinghe nuove, restituì la collana, che aveva nell’armadio e si accinse a scrivere la ricevuta. Frattanto i due fratelli si piantarono ritti davanti al tavolino, in modo d’impedire allo scrivente la vista dell’uscio; e, come per ozio, andavano stropicciando coi piedi il pavimento per far segno ai fidanzati di entrare, e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Renzo e Lucia entrarono pian piano e si nascosero dietro ai due fratelli. Quando don Abbondio, finito di scrivere, porse la ricevuta a Tonio, questi, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte; Gervaso, a un suo cenno, dall’altra; e nel mezzo, come al dividersi di una scena, apparvero Renzo e Lucia. Ma Renzo ebbe appena il tempo di dire: «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie», e Lucia ebbe appena il tempo di proferire: «E questo…», che don Abbondio, ghermito il tappeto del tavolino, lo buttò sulla testa di Lucia, per impedirle di pronunziare intera la formula. Le grida di don Abbondio. – Poi, gettata a terra la lucerna, che teneva nell’altra mano, si mise a gridare a squarciagola: «Perpetua! Perpetua! Tradimento! aiuto!», e, trovato a tastoni l’uscio che metteva a una stanza più interna, si rinchiuse in quella, continuando a chiamare. Intanto nell’altra stanza tutto era confusione. Renzo picchiava all’uscio, gridando: «Apra, apra; non faccia schiamazzo»; Lucia chiamava Renzo con voce fioca; Tonio, carponi, andava spazzando con le mani il pavimento, per vedere di raccapezzare la sua ricevuta; Gervaso gridava e saltellava, cercando l’uscio della scala. Don Abbondio, vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprì una finestra che dava sulla piazza della chiesa e si mise a gridare: «Aiuto! aiuto!». Il sacrestano suona a martello. – Ambrogio, il sacrestano, che dormiva in un bugigattolo contiguo alla chiesa, si svegliò a quel grido disordinato, mise fuori la testa, e, appreso da don Abbondio che aveva gente in casa, trovò subito un espediente per dare un aiuto al curato senza mettersi nel tafferuglio. Diede di piglio alle brache, che teneva sul letto; se le cacciò sotto il braccio, come un cappello di gala; e, precipitandosi nel campanile, afferrò la corda della campana più grossa, suonando a martello. I bravi nella casa di Lucia. – Ma quei rintocchi, ancor prima di ridestare il paese, giunsero agli orecchi di altre persone, che vegliavano non lontano, ritte e vestite: i bravi in un luogo, Agnese e Perpetua in un altro. Appena quei tre, che abbiamo lasciato all’osteria, si accorsero che nel paese non c’era più anima viva, si avviarono al casolare e fecero la loro relazione al Griso. Questi, indossato un abito da pellegrino, s’incamminò con tutta la sua truppa verso la casetta di Lucia. Visto che tutto era deserto e tranquillo, diede ordine ai due bravi di scalare il muro, che chiudeva il cortiletto, e di nascondersi in un angolo, dietro un folto fico. Ciò fatto, picchiò pian piano, con l’intenzione di dirsi un pellegrino smarrito, che chiedeva ricovero. Nessuno rispose: ripicchiò un po’ più forte; nemmeno uno zitto. Allora fece calare nel cortile un terzo malandrino, con l’ordine di sconficcare adagio il paletto, per aver libero l’ingresso e la ritirata. Entrò poi con gli altri bravi, che mandò a nascondersi accanto ai primi; accostò adagio adagio l’uscio di strada, ponendo due sentinelle di dentro; e picchiò all’uscio del piano terreno. Anche qui nessuno rispose. Sconficcò pian piano anche all’uscio, entrò nella stanza con quei due che aveva lasciato dietro il fico, accese un suo lanternino, entrò in un’altra stanza più interna, ma non trovò nessuno. Andò allora all’uscio di scala, si fece venir dietro il Grignapoco, che era un bravo del contrado di Bergamo e che col suo linguaggio avrebbe dovuto far credere che la spedizione veniva da quella parte, e salì il piano superiore. Spinse mollemente l’uscio che metteva alla prima stanza, vide un letto, ma vuoto; andò nell’altra stanza, ma trovò la stessa cosa. Il ritorno di Menico. – Mentre costoro erano in tali faccende, i due, che facevano la guardia all’uscio di strada, sentirono un calpestìo di passi frettolosi, che si fermarono appunto all’uscio. Era Menico, che veniva di corsa, mandato da padre Cristoforo ad avvertire le due donne che scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento. Appena egli mise il piede dentro, si sentì acchiappare per le braccia, mentre due voci gli dicevano in tono minaccioso: «Zitto! o sei morto». Il ragazzetto cacciò un urlo, ma tutto a un tratto, invece di lui, e con ben altro tono, si fece sentire quel primo tocco di campana, a cui seguì una tempesta di rintocchi in fila. I due furfanti, ai quali parve di sentire in quei tocchi il loro nome, cognome e soprannome, lasciarono andare le braccia a Menico, che si recò a gambe levate alla volta del campanile. Agli altri furfanti, che frugavano la casa, quei terribili tocchi fecero la stessa impressione. Ci volle tutta la superiorità del Griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Dopo averli brevemente biasimati per la loro paura, lasciò la casa, che era in fondo al villaggio, e tutti gli andarono dietro in buon ordine. Perpetua si libera da Agnese. – Agnese aveva cercato di tener a bada Perpetua il più che fosse possibile; e, fino a un certo punto, la cosa era andata bene. Ma tutt’a un tratto Perpetua si era ricordata dell’uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto seguirla, cercando però di trattenerla, ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto. Così, a corserelle e fermatine, erano giunte poco distante dalla casa del curato, quando, tutt’a un tratto si sentì, nell’ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di don Abbondio: «Aiuto! aiuto!». Perpetua prese la rincorsa, invano trattenuta da Agnese, quando più lontano, più acuto, più istantaneo, si sentì l’urlo di Menico, e, poco dopo, scoccò la campana. Perpetua, mentre spalancava l’uscio, si vide comparire sulla soglia Tonio, Gervaso, Renzo e Lucia, che correvano a mettersi in salvo, e, non ottenendo risposta alle sue domande di sorpresa, corse, come poteva al buio, verso la scala. Agnese, a sua volta, si trovò di fronte i due sposi, rimasti promessi, e tutti, prima che la gente accorresse, si avviarono affannati verso casa. Ma ecco arrivare Menico di corsa, che, ancor tutto tremante, gridò loro che vi era il diavolo in casa e che padre Cristoforo li voleva subito al convento. Così tutti e quattro, attraverso i campi, si incamminarono in fretta verso Pescarenico. Il popolo in piazza. – Intanto la gente cominciò ad accorrere sulla piazza. Quando il sacrestano fu assicurato dal ronzio che era accorso molto popolo, si mise in fretta l’arnese che aveva portato sotto il braccio, aprì la porta della chiesa, e disse che vi era gente in casa del curato. Tutti si volsero allora verso quella casa, ma, vedendo tutto quieto, cominciarono a chiamare a gran voce il curato. Don Abbondio, che in quel momento stava a bisticciare sotto voce con perpetua, che l’aveva lasciato solo in quell’imbroglio, dovette, quando si sentì chiamare a voce di popolo, affacciarsi alla finestra per ringraziare gli accorsi ed esortarli a ritornare a casa. Il popolo alla casetta di Lucia. – Già la gente si allontanava, quando arrivò uno tutto trafelato, il quale, abitando dirimpetto alle nostre donne, aveva visto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi, mentre il Griso si affannava a raccoglierli. Egli si mise a gridare che il diavolo era nella casa di Agnese, dove gente armata pareva volesse ammazzare un pellegrino. Poco dopo arrivò un altro, gridando anch’egli che dei ladri scappavano con un pellegrino. A questo avviso, tutti si mossero verso la casetta, dove trovarono le tracce dell’invasione fresche e manifeste. Alcuni proposero di inseguire i rapitori, ma uno gettò la voce che Agnese e Lucia si erano messe in un’altra casa. La voce ottenne credenza, e la folla si sparpagliò, andando ognuno a casa sua. Al mattino il console, mentre vangava nel suo campo, vide venirsi incontro due uomini, somigliantissimi a quei due che cinque giorni prima avevano affrontato don Abbondio, i quali gli intimarono che si guardasse bene dal far deposizione al podestà dell’accaduto, se aveva cara la speranza di morir di malattia. Verso il convento di Pescarenico. – I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto e in silenzio, nell’apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. Quando non sentirono più i rintocchi, rallentarono il passo, e domandarono a Menico cosa fosse quel diavolo in casa. Gli ascoltatori compresero più di quel che il ragazzo avesse saputo dire, e si guardarono in viso spaventati. Agnese, rammentandosi delle sue parpagliole promesse, se ne levò quattro di tasca; Renzo gli diede una berlina nuova, raccomandandogli molto di non dire nulla della commissione avuta dal frate; Lucia l’accarezzò di nuovo, e il ragazzo salutò tutti e tornò indietro. Quelli ripresero la loro strada, e poco dopo sboccarono sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento. Padre Cristoforo indirizza Lucia a Monza e Renzo a Milano. – Renzo sospinse la porta e gli apparve padre Cristoforo, che stava in aspettativa. Quando il padre vide i tre fuggiaschi, ringraziò Dio e li fece entrare, nonostante che fra Fazio, il laico sagrestano, si opponesse ad introdurre, contro la regola, delle donne in chiesa di notte. Ma padre Cristoforo gli troncò in bocca ogni osservazione con la frase latina: «Omnia munda mundis», che a quello, che non intendeva il latino, suonò tanto solenne quanto oscura. Padre Cristoforo spiegò ai fuggiaschi ciò che aveva fatto accennare dal piccolo messo, supponendo che Menico li avesse trovati tranquilli in casa, prima che arrivassero i malandrini. Nessuno di essi lo disingannò, nemmeno Lucia, poiché quella era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Poi il frate, rivolgendosi alle donne, disse che aveva trovato per esse un rifugio a Monza, e diede loro una lettera per il padre guardiano del convento di quella città; e, rivolgendosi a Renzo, gli consegnò una lettera per il padre Bonaventura da Lodi, nel convento dei cappuccini di Porta Orientale in Milano. Aggiunse loro di recarsi alla riva del lago, presso lo sbocco del Bione, dove avrebbero trovato una barca che li avrebbe portati all’altra riva, e, qui giunti, un baroccio che li avrebbe portati a destinazione. Prima di partire, il padre Cristoforo volle che tutti pregassero Dio, perché li assistesse nel viaggio e desse loro forza a sopportare ciò che Egli avesse voluto. Volle pure che pregassero per don Rodrigo, che li aveva condotti a quel passo. Dopo aver pregato, i viaggiatori uscirono di chiesa, s’avvicinarono alla riva che era stata loro indicata, entrarono nella barca, e presero il largo verso la riva opposta. Addio monti! – Non tirava un alito di vento. I passeggeri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grandi ombre. Lucia vide, rabbrividendo, il palazzotto di don Rodrigo, che sembrava vegliasse, meditando un delitto; scoprì la sua casetta, con la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile; e posando la fronte sul braccio, come per dormire, pianse segretamente. Essa diede un accorato addio ai suoi monti e alla sua terra, pur confidando che Dio non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. I fuggiaschi sull’altra riva. – I tre fuggiaschi, giunti sull’altra riva, resero tristemente grazie al barcaiolo, che ritirò la mano, quasi con ribrezzo, quando Renzo cercò di fargli sdrucciolare una parte dei denari che si trovava indosso, e che avrebbe voluto regalare a don Abbondio, dopo che questo, suo malgrado, avesse celebrato le nozze. Il baroccio era lì pronto, il conduttore li fece salire, diede una voce alla bestia, e si mosse. Arrivo a Monza. – I nostri viaggiatori arrivarono a Monza, poco dopo il levar del sole; il barocciaio entrò in un’osteria e fece assegnar loro una stanza; Renzo tentò di fargli ricevere del denaro, ma inutilmente. Fecero colazione come permetteva la penuria dei temi, i mezzi scarsi e il poco appetito, mentre passava ad essi per la mente il banchetto che due giorni prima aspettavano di fare. Renzo avrebbe voluto fermarsi lì, almeno tutto quel giorno; ma il padre aveva raccomandato alle donne di mandarlo subito per la sua strada, e il giovane a malincuore si risolvette di partire. Agnese e Lucia al convento dei cappuccini. – Agnese e Lucia si avviarono col barocciaio al convento dei cappuccini. Il barocciaio fece chiamare il padre guardiano e gli consegnò la lettera di padre Cristoforo. Il padre guardiano, nel leggerla, faceva di tanto in tanto atti di sorpresa e di indignazione; e, alzando gli occhi dal foglio, li fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e d’interesse. Finito ch’ebbe di leggere, disse che le avrebbe accompagnate dalla «Signora», che sola avrebbe potuto prendersi quell’impegno, e invitò le donne a seguirlo, ma ad alcuni passi di distanza, per evitare le chiacchiere della gente. Le donne domandarono allora al barocciaio chi fosse la signora, ed appresero che era una monaca, ma non una monaca come le altre, perché figlia del più grande signore di Monza, onde poteva far alto e basso nel monastero, e, quando prendeva un impegno, le riusciva anche di spuntarlo. Giunti al monastero, il padre guardiano pregò il barocciaio che tra un paio d’ore tornasse da lui a prendere la risposta per il padre Cristoforo; poi, dopo aver fatto entrare la madre e la figlia nelle camere della fattoressa, andò solo a chiedere la grazia. Trascorso qualche tempo, ricomparve giulivo, diede qualche avvertimento alle donne sul modo di portarsi con la signora, e le accompagnò nel parlatorio, dove videro, dietro una grata di ferro, una monaca ritta, che poteva mostrare venticinque anni. Le due donne alla presenza della Monaca di Monza. – L’aspetto della monaca faceva a prima vista un’impressione di bellezza, ma d’una bellezza sbattuta, sfiorita, e quasi scomposta. La fronte si raggrinziva spesso, come per una contrazione dolorosa; gli occhi neri si fissavano talora in viso alle persone con un’investigazione superba; le gote pallidissime sembravano come alterate da una lenta estenuazione: le labbra, appena tinte d’un roseo sbiadito, avevano moti subitanei, vivi, pieni di espressione e di mistero. Anche il modo di vestire annunziava una monaca singolare, poiché la vita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli. Il guardiano presentò le due donne, e spiegò alla signora che Lucia era stata costretta a partire di nascosto dal suo paese per sfuggire a un cavaliere prepotente, e che aveva bisogno per qualche tempo di un asilo sicuro. Allora la signora fece accostare Lucia, e le domandò, con una cert’aria di dubbio maligno, se quel cavaliere era un persecutore odioso; ma la povera ragazza balbettò appena qualche parola senza avere il coraggio di proseguire. Agnese si credette autorizzata a venirle in aiuto, ma la signora la interruppe bruscamente, biasimandola di parlare senza essere interrogata. Lucia confermò il racconto della madre, e la signora disse di crederle, ma che si riservava il piacere di sentirla da solo a solo. Poi aggiunse che, essendosi maritata l’ultima figlia della fattoressa, le due donne avrebbero potuto occupare la camera lasciata in libertà da quella e supplire a quei pochi servizi che faceva lei: licenziò Agnese, accomiatò il guardiano, e ritenne Lucia, cui fece strani discorsi. Storia della Monaca di Monza. – La signora era l’ultima figlia del principe ***, gran gentiluomo milanese, che, per l’alta opinione che aveva del suo titolo, temeva che le sue sostanze fossero appena sufficienti, anzi scarse, a sostenere il decoro. Aveva perciò destinato al chiostro tutti i cadetti dell’uno e dell’altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a continuar la famiglia. Quando nacque la nostra infelice, il principe, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l’idea del chiostro, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le diedero in mano; poi santini che rappresentavano monache. Quando i genitori e il fratello primogenito solevano lodare l’aspetto prosperoso della fanciullona, le dicevano: «Ce madre badessa!». Se qualche volta la Gertrude trascorreva a qualche atto un po’ arrogante e imperioso, le si diceva: «Queste maniere non ti convengono: quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso». A sei anni è rinchiusa nel monastero di Monza. – A sei anni Gertrude fu collocata, per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l’abbiamo veduta, perché il padre, essendo il feudatario di Monza, pensò che lì sua figlia sarebbe stata trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potessero più allettarla a scegliere quel monastero per la sua perpetua dimora. Né s’ingannava, poiché la badessa e alcune monache corrisposero pienamente elle intenzioni che il principe aveva lasciato trasparire. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata la signorina e fu fatta oggetto di attenzioni e di premure di ogni genere. Ma Gertrude non era la sola ragazza in quel monastero. Tra le sue compagne ve n’erano alcune che sapevano di essere destinate al matrimonio, e perciò, mentre Gertrude, nutrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, quelle contrapponevano le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, di villeggiatura, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti, messi davanti ad un alveare. Essa rispondeva che, alla fin dei conti, nessuno avrebbe potuto costringerla a farsi monaca senza il suo consenso e che anche lei poteva maritarsi. La supplica al vicario delle monache. – Era legge che una giovane non potesse venire accettata monaca, prima d’essere stata esaminata da un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, affinché fosse certo che si chiudeva nel monastero di sua libera scelta; e questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che essa avesse esposto a quel vicario il suo desiderio con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevano preso il tristo incarico di far che Gertrude si obbligasse per sempre, colsero un momento propizio per farle sottoscrivere una tal supplica, dicendole che si trattava (come si trattava di fatto) di una pura formalità. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancor giunta al suo destino, che Gertrude s’era pentita di averla sottoscritta. Il mese fuori dal monastero e la lettera al padre. – C’era poi un’altra legge, che una giovane non fosse ammessa a quell’esame della vocazione, se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori dal monastero, dove era stata in educazione. Anche Gertrude, trascorso l’anno da che la supplica era stata mandata, doveva essere levata dal monastero e condotta nella casa paterna, per rimanervi quel mese e far tutti i passi necessari al compimento dell’opera che aveva di fatto cominciata. Ma la giovane aveva tutt’altro in testa, e, in tali angustie, risolvette di aprirsi con una delle sue compagne, che le suggerì d’informare con una lettera il padre della sua nuova risoluzione. Ma Gertrude aspettò invano una risposta. Se non che, alcuni giorni dopo, la badessa la fece venire nella sua cella, e, con un contegno di mistero, le accennò oscuramente a una gran collera del principe per un fallo che essa doveva aver commesso, lasciandole però intendere che, portandosi bene, poteva sperare che tutto sarebbe dimenticato. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato, nel quale Gertrude dovette lasciare il monastero per ritornare temporaneamente nel palazzo paterno. I giorni passavano senza che il padre né altri le parlasse della supplica, né della ritrattazione. I parenti erano seri, tristi, burberi con lei, senza mai dire il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un’indegna. Se implorava un po’ d’amore, si sentiva subito toccare, in maniera indiretta ma chiara, quel tasto della scelta dello stato; le si faceva copertamente sentire che c’era un mezzo per riacquistare l’affetto della famiglia. Lo sciagurato biglietto al paggio. – Ma Gertrude si accorse che, mentre dalla servitù era trattata con noncuranza, accompagnata da un leggero ossequio di formalità, un paggio le portava un rispetto e sentiva per lei una compassione di un genere particolare. Essa mostrò un non so che di nuovo nelle sue maniere, così che le furono tenuti gli occhi addosso più che mai. Una mattina fu sorpresa da una cameriera, mentre stava piegando alla sfuggita una carta, sulla quale avrebbe fatto meglio a non scrivere nulla. La carta rimase nelle mani della donna, e da queste passò in quelle del principe, che, dopo poche ma terribili parole, le intimò di star chiusa in quella camera sotto la guardia della cameriera che aveva fatto la scoperta, e le minacciò un altro castigo oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso. Il paggio fu subito sfrattato, e fu minacciato anche lui di qualcosa di terribile se avesse osato parlare dell’accaduto. Gertrude implora il perdono del padre. – Gertrude rimase col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell’avvenire, e con la sola compagnia di quella donna che era stata cagione della sua disgrazia. Il solo castello, nel quale poteva immaginare un rifugio tranquillo e onorevole, e che non fosse in aria, era il monastero, quando si fosse risolta di entrarvi per sempre. Dopo quattro o cinque giorni di prigionia, essa, stuccata e invelenita all’eccesso per un dispetto della guardiana, sentì il bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, di essere trattata diversamente. Allora riprese quella penna fatale, scrisse al padre una lettera piena d’entusiasmo e d’abbattimento, d’afflizione e di speranza, implorando il perdono, e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo. |
||
| Le divisioni utilizzate sono quelle dei riassunti Bignami
Scritto con la partecipazione eccezionale di Mariantonietta |
||