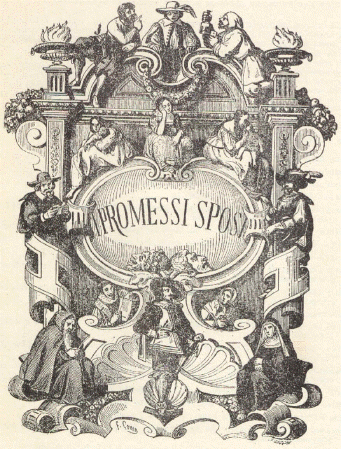|
|
 |
Il riassunto dei
Promessi Sposi
|
|
|
Il castello dell’Innominato. – Il castello dell’Innominato era a cavaliere di una valle angusta e uggiosa, sulla cima d’un poggio che sporgeva in fuori da un’aspra giogaia di monti. La parte che guardava la valle era la sola praticabile. Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all’intorno tutto lo spazio dove piede d’uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. Nel mezzo della valle, a piè del poggio, all’imboccatura di un erto e tortuoso sentiero, c’era una taverna, che era chiamata la Malanotte. Quando don Rodrigo vi giunse, smontò da cavallo, si levò lo schioppo (poiché sapeva che su quell’erta non era permesso procedere armati), diede alcuni scudi d’oro al capo dei bravi di guardia perché ne facesse parte ai suoi uomini, e, accompagnato dal solo Griso, cominciò a piedi la salita. Don Rodrigo s’incontra con l’Innominato. – Arrivato al castello, fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui, e per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole e di partigiane, e, dopo aver alquanto aspettato, fu ammesso in quella dove si trovava l’Innominato. Questi gli andò incontro, rendendogli il saluto. Era grande, bruno, calvo; bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia: a prima vista gli si sarebbe dato più di sessant’anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro, ma vivo degli occhi, indicavano una forza di corpo e d’animo, che sarebbe stata straordinaria in un giovane. Don Rodrigo disse che, trovandosi in un impegno difficile, dal quale il suo nome non gli permetteva di ritirarsi, s’era ricordato delle promesse di quell’uomo, che non prometteva mai troppo, né invano; e si fece ad esporre il suo scellerato imbroglio. Sapendo poi con chi parlava, si mise ad esagerare le difficoltà dell’impresa: la distanza del luogo, un monastero, la signora! A questo punto l’Innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore glielo avesse comandato, l’interruppe subitamente, dicendo che prendeva l’impresa sopra di sé. Prese l’appunto del nome di Lucia e licenziò don Rodrigo, assicurando che tra poco avrebbe ricevuto da lui l’avviso di quello che avrebbe dovuto fare. L’Innominato era infatti amico di quello sciagurato Egidio, che abitava accanto al monastero dove Lucia era stata ricoverata; e perciò egli aveva lasciato correre così prontamente e risolutamente la sua parola. L’Innominato si pente d’aver dato la sua parola. – Ma appena rimase solo, l’Innominato si trovò non pentito, ma indispettivo di averla data. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certa uggia delle sue scelleratezze. E, cosa notabile, l’immagine della morte, che, in un pericolo vicino, a fronte d’un nemico, soleva raddoppiare gli spiriti di quell’uomo, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Gli rinasceva ogni tanto nell’animo l’idea confusa, ma terribile, d’un giudizio invidiale, d’una ragione indipendente dall’esempio. Quel Dio, di cui aveva sentito parlare, ma che, da gran tempo, non si curava di negare, né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in certi momenti d’abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridare dentro di sé: Io sono però. Ma non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la mascherava con l’apparenza d’una più cupa ferocia. L’Innominato incarica il Nibbio di rapire Lucia. – Appena partito don Rodrigo, sentendo a poco a poco venirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancare a quella parola, chiamò il Nibbio, uno dei più destri ed arditi ministri delle sue enormità, e gli comandò di recarsi subito a Monza per informare Egidio dell’impegno contratto e per richiedere il suo aiuto. Il messo fu presto di ritorno con la risposta di Egidio: che l’impresa era facile e sicura; che gli si mandasse subito una carrozza, con due o tre bravi ben travestiti, e che lui prenderebbe la cura di tutto il resto e guiderebbe la cosa. A questo annunzio l’Innominato diede ordine in fretta al Nibbio, che disponesse tutto secondo quanto aveva detto Egidio e andasse con altri due bravi alla spedizione. Egidio impone la sua volontà a Gertrude. – Egidio aveva potuto rispondere a quel modo perché in quell’asilo stesso, dove pareva che tutto dovesse essere di ostacolo, aveva un mezzo noto a lui solo. Egli impose a Gertrude, con quella voce che aveva acquistato autorità dal delitto, il sacrificio dell’innocente che essa aveva in custodia. La sventurata tentò tutte le strade per esimersi dall’orribile comando, ma non osò ribellarsi interamente, e ubbidì. Il rapimento di Lucia. – Nel giorno stabilito, all’ora convenuta, Gertrude disse a Lucia che aveva bisogno di parlare subito con quel padre guardiano dei cappuccini, che l’aveva condotta al monastero, e che era necessario che nessuno sapesse che l’aveva mandata a chiamare lei, e che non aveva che essa per far segretamente l’ambasciata. Lucia fu atterrita per una tale richiesta e addusse subito, per disimpegnarsene, le ragioni che la signora avrebbe dovuto prevedere: senza la madre, senza nessuno, per una strada solitaria in un paese sconosciuto….. Ma Gertrude, ammaestrata a una scuola infernale, mostrò tanto dispiacere per una tale ritrosia, che la poverina finì per acconsentire. Quando Lucia mise piede sulla soglia, Gertrude, come sopraffatta da un sentimento irresistibile, la richiamò, ma, cinta subito da un altro pensiero avvezzo a predominare, fece vista di non essere contenta delle istruzioni già date, le spiegò di nuovo la strada che doveva tenere, e la licenziò. Lucia passò inosservata la porta del chiostro; prese la strada, con gli occhi bassi, rasente al muro; trovò la porta del borgo, si avviò per la strada maestra, e arrivò in pochi momenti a quella che conduceva al convento. La giovane, vedendola affatto solitaria, sentì crescere la paura e allungò il passo; ma poco dopo si rincuorò, nel vedere una carrozza da viaggio ferma, e accanato a quella, davanti allo sportello aperto, due viaggiatori che guardavano in qua e in là, come incerti della strada. Quando arrivò alla carrozza, uno di quei due le chiese la strada per Monza, ma, mentre essa si volgeva per indicare la giusta direzione, l’altro compagno (era il Nibbio) l’afferrò improvvisamente per la vita, l’alzò da terra e la mise per forza nella carrozza. Lucia verso il castello dell’Innominato. – Un bravo le si sedette dinanzi, un altro con un fazzoletto alla bocca le impedì di gridare, e la carrozza partì di carriera. Chi potrà descrivere il terrore, l’angoscia dell’infelice, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati e li richiudeva subito, per il ribrezzo e per il terrore di quei visacci; si torceva, ma era tenuta da tutte le parti; apriva la bocca per cacciare un urlo, ma il fazzoletto veniva a soffocarglielo in gola. Dopo qualche momento d’una lotta così angosciosa, allentò le braccia, lasciò cadere la testa all’indietro, le fuggì il colore dal viso, s’abbandonò e svenne. Quando aprì gli occhi, tentò ancora di buttarsi verso lo sportello, ricorse alle preghiere, ma, vedendo che tutto era inutile, si strinse nel canto della carrozza, tirò fuori la corona, e cominciò a dire il rosario con più fede e con più affetto che non avesse ancor fatto in vita sua. L’Innominato in attesa della carrozza di Lucia. – Intanto l’Innominato, da un’alta finestra del suo castellaccio, aspettava con un’inquietudine, con una sospensione d’animo insolita. Quando vide spuntare la carrozza, che veniva innanzi lentamente, avrebbe voluto liberarsi della giovane e ordinare al Nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di don Rodrigo. Ma un «no» imperioso, che gli risuonò nella mente, fece svanire quel disegno. Chiamò invece una vecchia donna, nata e vissuta in quel castello, e le ordinò di far allestire subito una bussola e di andar con essa alla Malanotte, incontro alla carrozza del Nibbio. Essa avrebbe dovuto prendere con sé la giovane, condurla nella sua camera e farle coraggio. Partita la vecchia, l’Innominato si fermò ancora alla finestra e con gli occhi fissi sulla carrozza, poi si ritirò e si mise a camminare innanzi e indietro per la stanza, con un passo di viaggiatore frettoloso. La vecchia va incontro a Lucia alla Malanotte. – La vecchia si recò subito alla Malanotte, e, appena arrivò la carrozza, uscì dalla bussola, riferì al Nibbio gli ordini del padrone, e invitò Lucia a venire con sé, dicendole che aveva ordine di trattarla bene e di farle coraggio. La poverina fu presa e messa nella bussola, mentre il Nibbio prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone. Il Nibbio riferisce all’Innominato. – Giunto alla presenza dell’Innominato, il Nibbio disse che tutto era andato a puntino, ma che avrebbe avuto più piacere che l’ordine fosse stato di dare una schioppettata nella schiena a quella giovane piuttosto che sentirla parlare e vederla in viso, perché gli aveva fatto troppa compassione. L’Innominato, udendo ciò, rimase stupito, si rimproverò di essere stato una bestia a impegnarsi, ordinò al Nibbio di recarsi in fretta da don Rodrigo per mandare a prendere la ragazza, ma un altro «no» interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire e mandò il bravo a dormire. L’Innominato visita Lucia. – Poi, ripensando fra sé a quella compassione che Lucia aveva destato nel cuore del Nibbio, si decise di andarla a vedere, e, d’una stanza in un’altra, trovò una scaletta e giunse alla camera della vecchia. Vide, al lume di una lanterna che ardeva su un tavolino, Lucia rannicchiata per terra, nel cantuccio più lontano dall’uscio; e, rimproverata la vecchia con un cipiglio iracondo, ordinò alla giovane di alzarsi. Lucia si rizzò in ginocchioni e supplicò che la riportassero da sua madre, poiché «Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia». L’Innominato, con una dolcezza che fece trasecolare la vecchia, esortò la prigioniera a farsi coraggio, poiché nessuno la farebbe del male; e le annunziò che sarebbe ritornato all’indomani e che una donna avrebbe portato da mangiare. Poco dopo venne una donna con un paniere di cibi, ma, per quanto la vecchia usasse le parole più efficaci, secondo lei, a far venire l’appetito, Lucia si rifiutò di mangiare. La vecchia insistette anche affinché Lucia si mettesse a letto, ma, non ottenendo nulla, ci si mise lei bell’e vestita. Il voto di Lucia. – Lucia stette immobile nel suo cantuccio, tutta in un gomitolo, col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né sveglia, ma una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Tutt’a un tratto si riscosse, come ad una chiamata interna, rammentò che poteva pregare, prese di nuovo la sua corona e incominciò a dire il rosario. Poi le passò per la mente un altro pensiero: che la sua orazione sarebbe stata più accettata e più certamente esaudita, se, nella sua desolazione, facesse qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro, e, postasi in ginocchio, tenendo giunte al petto le mani, dalle quali pendeva la corona, fece voto alla Vergine santissima di rinunziare per sempre a Renzo e di consacrarsi per sempre a Lei. Proferite queste parole, abbassò la testa, si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione, come un’armatura della nuova milizia a cui si era iscritta. Rimessasi a sedere in terra, sentì entrare nell’animo una certa tranquillità, una più larga fiducia, e finalmente, già vicino a giorno, s’addormentò d’un sonno perfetto e continuo. La notte dell’Innominato. – Anche l’Innominato avrebbe voluto fare altrettanto, ma non poteva. Partito, o quasi scappato da Lucia, si era chiuso in fretta in camera, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici, e, spogliatosi, era andato a letto. Ma l’immagine di Lucia, più che mai presente, pareva che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai. Si rammaricava di essere andato a vedere la giovane e di essersi lasciato commuovere; si richiamava alla memoria più d’un caso in cui né preghi né lamenti, non l’avevano punto smosso dal compiere le sue risoluzioni, ma le rimembranza di tali imprese destava nel suo animo una specie di terrore, una rabbia di pentimento. Poi pensava che tutti questi pensieri che gli passavano per la mente erano sciocchezze, ma, per quanto cercasse di liberarsene, non trovò mezzo alcuno. Se volle trovare un po’ di sollievo, dovette pensare che all’indomani avrebbe potuto lasciare in libertà quella poveretta; ma, d’altra parte, si ricordò di don Rodrigo e dell’impegno preso con lui. Ciò gli fornì l’occasione per ingolfarsi nell’esame di tutta la sua vita. Indietro indietro, d’anno in anno, d’impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza: e l’orrore, rinascente ad ognuna di quelle immagini, crebbe fino alla disperazione. S’alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, ma al momento di finire una vita divenuta insopportabile, gli balenò nella mente il pensiero di quell’altra vita, della quale gli era stato parlato quand’era ragazzo. Il dubbio che quest’altra vita ci fosse, gli mise addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva sfuggire, neppur con la morte. Lasciò cader l’arma, e stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutt’a un tratto gli tornarono in mente le parole che Lucia gli aveva detto poche ore prima: «Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia!». E non gli tornavano già con quell’accento d’umile preghiera, con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d’autorità, e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo: levò le mani dalle tempie, e, in un’attitudine più composta, fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole; e la vedeva non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, per sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita; s’immaginava di condurla lui stesso dalla madre. Lo scampanìo per la visita del cardinal Federigo. – Mentre era agitato da tali pensieri, sentì, sull’albeggiare, uno scampanìo a festa lontano, poi uno scampanìo più vicino, poi un altro ancora. Vestitosi a mezzo, corse ad aprire una finestra, e vide, in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case e s’avviava, tutti dalla stessa parte, tutti col vestito della festa, e con un’alacrità straordinaria. Curioso di sapere qualcosa, inviò un bravo, che dormiva nella stanza accanto, a prendere informazioni. L’Innominato si reca dal cardinal Federigo Borromeo. – Poco dopo il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinale Federigo Borromeo, arcivescovo di Milano, era arrivato a *** e ci sarebbe stato tutto quel giorno; e che la nuova di questo arrivo, sparsasi la sera nei paesi d’intorno, aveva invogliati tutti d’andare a vedere quell’uomo; e si scampanava più per allegria che per avvertire la gente. L’Innominato, rimasto solo, continuò a guardar nella valle, ancor più pensieroso, domandandosi che cosa avesse quell’uomo per rendere tanta gente allegra. Poi decise di recarsi anch’egli da lui, per vedere se avesse le parole che possono consolare. Presa questa risoluzione, finì in fretta di vestirsi; s’armò di due terzette, del pugnale e della carabina; ma prima di tutto volle recarsi nella camera dove aveva lasciata Lucia. Posò fuori la carabina vicino all’uscio, si fece aprire dalla vecchia, e, poiché vide Lucia dormire in un cantuccio per terra, rimproverò la donna, orinandole che, quando Lucia si fosse svegliata, avrebbe dovuto dirle che il padrone era partito per poco tempo, e, quando fosse tornato, avrebbe fatto tutto quello che essa avrebbe voluto. La vecchia rimase stupefatta, domandandosi se quella giovane fosse per caso una principessa. L’Innominato uscì, riprese la sua carabina, lasciò il castello, e, senza seguito di bravi, prese la scesa di corsa. Giunto al paese, si recò in casa del curato, dove si trovava il cardinale. Entrò in un cortiletto, dove c’erano molti preti, che lo guardarono con un’attenzione meravigliata e sospettosa. Si levò la carabina, l’appoggio, in un canto del cortile, e disse ad un prete che voleva parlare al cardinale. Il prete, che era forestiero, chiamò il cappellano crocifero, che, udita quella strana richiesta, balbettò vaghe parole e andò a malincorpo a far l’ambasciata. Vita del cardinal Federigo Borromeo. – A questo punto il Manzoni interrompe il racconto per darci ampie notizie intorno alla vita del cardinale. Federigo Borromeo, nato nel 1564, fu uno degli uomini rari in qualunque tempo, che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi di una grande opulenza, tutti i vantaggi di una condizione privilegiata, nella ricerca e nell’esercizio del meglio. Tra gli agi e le pompe, badò fin dalla puerizia a quelle parole d’abnegazione e d’umiltà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all’ingiustizia dell’orgoglio, alla vera dignità e ai veri beni, che, sentite o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all’altra, nel più elementare insegnamento della religione: le prese sul serio, le gustò e le trovò vere, e si propose di prenderle per norma delle sue azioni e dei suoi pensieri. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse rendere la sua utile e santa. Nel 1580 prende l’abito ecclesiastico. – Nel 1580, a soli sedici anni, prese l’abito ecclesiastico da quel suo cugino Carlo, che già la fama predicava santo. Entrò poco dopo nel collegio Borromeo di Pavia, ed ivi, oltre ad applicarsi alle occupazioni che vi trovò prescritte, volle dedicarsi all’insegnamento della dottrina cristiana ai più rozzi e derelitti del popolo, e visitare e soccorrere gli infermi, esercitando come un primato d’esempio. Volle anche una tavola piuttosto povera che frugale, usò un vestiario piuttosto povero e semplice; né mai mutò il tenore di vita e il contegno, per quanto alcuni congiunti gridassero e si lamentassero che avvilisse così la dignità della casa. Nel 1595 è nominato arcivescovo di Milano. – Federigo, persuaso che non vi è giusta superiorità di un uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio, temeva le dignità e cercava di scansarle. Perciò quando nel 1595 il papa Clemente VIII gli propose l’arcivescovado di Milano, apparve fortemente turbato e ricusò senza esitare. Cedette poi al comando espresso del Papa. Divenuto arcivescovo, poiché riteneva che le rendite ecclesiastiche sono patrimonio dei poveri, volle che il suo mantenimento e quello della sua servitù fosse a spese della sua cassa particolare. Fonda la Biblioteca Ambrosiana. – Fondò inoltre la Biblioteca Ambrosiana, nella quale con grande dispendio adunò trentamila volumi stampati e quattordicimila manoscritti, invitando otto uomini, dei più colti ed esperti, a farne incetta per l’Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano, a Gerusalemme. Unì alla biblioteca un collegio di dottori (che dapprima furono nove, e poi, non bastando le entrate ordinarie, furono ristretti a due), con l’obbligo di coltivare gli studi più vari e di pubblicare qualche lavoro sulla materia ad essi assegnata; vi aggiunse un collegio, detto trilingue, per lo studio della lingua greca, latina, italiana; e inoltre un collegio di alunni, una stamperia di lingue orientali, una galleria di quadri, una di statue, e una scuola delle tre principali arti del disegno. Prescrisse al bibliotecario che mantenesse rapporti con gli uomini più dotti d’Europa, per avere da loro notizie sullo stato delle scienze e dei migliori libri che venissero pubblicati; e ordinò, cosa singolare in quel tempo, che le opere della biblioteca fossero messe a disposizione degli studiosi, con comodità di carta, penna e calamaio. Sua carità. – Federigo teneva l’elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo. Avendo risaputo che un nobile, non possedendo quattromila scudi per dotare la figlia, voleva costringerla a farsi monaca, lo fece chiamare e gli diede la dote richiesta. Era di facile abbordo con tutti, specialmente con quelli che si chiamano di bassa condizione. Una volta, in un paese alpestre e selvatico, mentre istruiva e accarezzava certi poveri fanciulli, un tale l’avvertì che usasse più riguardo perché erano troppo sudici; ma il buon vescovo, non senza un certo risentimento, gli rispose che erano anime sue e che forse non avrebbero mai più visto la sua faccia. Ben raro però era il risentimento in lui, ammirato per la soavità dei suoi modi, per una pacatezza imperturbabile, che si sarebbe attribuita a una felicità straordinaria di temperamento, mentre era l’effetto di una disciplina costante sopra un’indole viva e risentita. Se qualche volta si mostrò severo, fu coi pastori suoi subordinati, che scoprisse rei di avarizia o di negligenza o di altre tracce, opposte allo spirito del loro nobile ministero. L’uomo dotto. – Con tanti altri e diversi titoli di lodi, Federigo ebbe anche, presso i suoi contemporanei, quello di uomo dotto. Egli lasciò circa cento opere, tra grandi e piccole, tra latine e italiane, tra stampate e manoscritte: trattati di morale, orazioni, dissertazioni di storia, di antichità sacra e profana, di letteratura, di arti e d’altro. Ma tutte queste opere, nonostante tanto ingegno, tanto studio, tanta pratica degli uomini e delle cose, tanto meditare, tanta passione per il buono e per il bello, tanto candore e tant’altre di quelle qualità che fanno il grande scrittore, sono cadute in oblio. Per quale ragione? Il Manzoni pone, ma non risolve il problema. L’Innominato alla presenza del cardinale. – Il cardinale Federigo, intanto che aspettava l’ora di andare in chiesa, stava studiando, come era solito fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano crocifero ad annunziargli la visita dell’Innominato, avvertendo che si trattava di un bandito, di un appaltatore di delitti, di un disperato… ma il cardinale, sorridendo, diede l’ordine di farlo entrare. Appena introdotto l’Innominato, Federigo gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e con le braccia aperte, come a una persona desiderata. I due stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi. L’Innominato era come straziato da due passioni opposte, il desiderio confuso di trovare un refrigerio al tormento interno e la vergogna di venir lì come un pentito, a confessarsi in colpa, a implorare un uomo. Il cardinale, abituato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri, lo ringraziò della preziosa visita, quantunque essa avesse per lui un po’ di rimprovero, poiché avrebbe egli dovuto andarlo a trovare. L’Innominato scoppia in un pianto dirotto. – L’Innominato, commosso ma sbalordito, stava in silenzio. Quando il cardinale gli chiese, ancor più affettuosamente, quale buona nuova avesse, egli rispose che aveva l’inferno nel cuore; ma il cardinale riprese pacatamente a dire che Dio gli aveva toccato il cuore e voleva fare di lui un segno della sua potenza e della sua bontà. A misura che le parole uscivano dal labbro del cardinale, la faccia del suo ascoltatore si componeva a una commozione profonda: i suoi occhi, che dall’infanzia non conoscevano più le lacrime, si gonfiarono, e, quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un pianto dirotto. Il cardinale, dopo aver ringraziato Dio di averlo fatto assistere a quella conversione, stese la mano a prender quella dell’Innominato. L’abbraccio del cardinale. – Questi cercò di schermirsi, ma Federigo prese la mano con amorevole violenza, dicendo che essa avrebbe riparato tanti torti, avrebbe sparso tante beneficenze e sollevato tanti afflitti. Poi stese le braccia al collo del pentito, che, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito un momento, cedette come vinto da quell’impeto di carità, abbracciò anch’egli il cardinale, e abbandonò sull’omero di lui il suo volto tremante e mutato. Le su lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo; e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portar l’armi della violenza e del tradimento. Quando l’Innominato si sciolse da quell’abbraccio, si coprì gli occhi con le mani, ringraziò Dio per la gioia presente, che non aveva mai provata in tutta la sua orribile vita, e raccontò con parole di esecrazione la prepotenza fatta a Lucia. Il cardinale dispone per la liberazione di Lucia. – Il cardinale, avendo appreso il paese della poveretta, fece tosto dal cappellano crocifero chiamare don Abbondio e il parroco della chiesa. Don Abbondio era così lontano dal credere che si chiedesse di lui, che dapprima non seppe se non trascinare un io? e poi ancora un me? Il cardinale disse in succinto al parroco di che si trattava, e se saprebbe trovar subito una buona donna che volesse andare in lettiga al castello a prender Lucia; poi incaricò don Abbondio di andare anche lui ad accompagnare quella donna, pensando che sarebbe stato bene che la povera giovane vedesse subito una faccia conosciuta, dopo tante ore di spasimo. Infine, avendo appreso da don Abbondio che nel paese di Lucia si trovava la madre di lei, Agnese, ordinò che fosse mandata una persona a cercarla per condurla a rivedere la figlia. Don Abbondio, che aveva una grande paura dell’Innominato, avrebbe voluto recarsi lui a prendere Agnese, che era una donna molto sensitiva….. ma il cardinale insistette ed egli dovette ubbidire. Il cardinale però scoprì facilmente nel viso di don Abbondio la paura di viaggiare con quell’uomo tremendo, e, volendo dissipare quell’ombra, si accostò all’Innominato con aria di spontanea confidenza, lo invitò a ritornare e a desinare con lui. Don Abbondio, a quelle dimostrazioni di affetto, stava come un ragazzo pauroso che veda accarezzar con sicurezza un cagnaccio grosso, rabbuffato, con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per spaventi, e senta dir dal padrone che quel cane è un buon bestione, quieto quieto. L’Innominato e don Abbondio verso il castello. – Il cardinale andò quindi in chiesa e i due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza. L’Innominato stava tutto ravvolto in sé, impaziente che venisse il momento di andar a liberare Lucia; don Abbondio almanaccando che cosa potesse dirgli e concludendo col non dirgli nulla. Giunse alfine il curato del paese, il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga; don Abbondio e l’Innominato salirono su due mule e la comitiva partì. Si doveva passare davanti alla chiesa piena zeppa di popolo. Già la gran nuova era corsa, e all’apparir di quell’uomo, oggetto ancor poche ore prima di terrore e d’esecrazione, si alzò nella folla un mormorio d’applauso. L’Innominato, passando davanti alla chiesa, si levò il cappello, chinò quella fronte tanto temuta fin sulla criniera della mula, tra il sussurro di cento voci che dicevano: Dio lo benedica! Don Abbondio si levò anche lui il cappello, ma sentendo il concerto solenne dei suoi confratelli che cantavano a distesa, provò un’invidia, una mesta tenerezza, un accoramento tale che durò fatica a tenere le lacrime. Il soliloquio di don Abbondio. – Fuori poi dall’abitato, nell’aperta campagna, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Se la prendeva coi santi, che come birboni hanno l’argento vivo addosso; se la prendeva con don Rodrigo, che avrebbe potuto andare in paradiso in carrozza, mentre voleva andare in casa del diavolo a piè zoppo; se la prendeva con l’Innominato, che, dopo aver messo sottosopra il mondo con le sue scelleratezze, lo metteva ora sottosopra con la sua conversione; se la prendeva infine col cardinale, che usava troppa precipitazione e si giocava la vita di un povero curato a pari e caffo. Entrò quindi in quella valle famosa, della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili; vide quei famosi uomini, il fiore della braveria d’Italia, che si chinavano sommessamente al signore, e che a don Abbondio pareva che volessero dire: «Fargli la festa e quel prete?». Dante non stava peggio nel mezzo di Malebolge. Giunti al castello, l’Innominato aiutò cortesemente don Abbondio a scendere, aprì l’uscio, entrò, fece entrare il curato e la donna, s’avviò davanti a loro alla scaletta, e tutti e tre salirono in silenzio. La liberazione di Lucia. – Lucia s’era risvegliata da poco e chiedeva del padrone alla vecchia, quando la comitiva fu all’uscio. L’Innominato fece entrare subito don Abbondio e la buona donna, mentre egli si fermò sulla soglia. Lucia, riconoscendo il proprio curato, rimase come incantata, mentre questi la esortava a farsi coraggio, poiché egli era venuto apposta a cavallo per condurla via…. La buona donna, a sua volta, guardandola pietosamente, cercava di confortarla, prendendole le mani, come per accarezzarla ed alzarla a un tempo. Apparve infine l’Innominato, che chiese perdono; e Lucia, vedendo bassa quella fronte, e atterrato e confuso quello sguardo, presa da un misto sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse: «oh! il mio signore! Dio le renda merito della sua misericordia!». Il ritorno al paese. – Poi tutti uscirono dalla camera. L’Innominato uscì il primo; Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava il braccio, gli andò dietro; don Abbondio in coda. Giunti nel cortile, l’Innominato andò alla lettiga, aprì lo sportello, e, con una gentilezza quasi timida, aiutò Lucia ad entrarvi, poi la buona donna. Slegò quindi la mula di don Abbondio, e aiutò anche lui a montare. La comitiva si mosse, quando l’Innominato fu anche lui a cavallo. Per don Abbondio questo ritorno non fu certo così angoscioso come l’andata di poco prima; ma non fu neppur esso un viaggio di piacere, come quando, sbarbato un grand’albero, il terreno rimane sgombro per qualche tempo, ma poi si copre tutto d’erbacce. Sentiva antitutto l’incomodo di quel modo di viaggiare, specialmente sul principio, nella discesa dal castello al fondo della valle, perché, nei luoghi più ripidi, tracollava sul davanti, e, per reggersi, doveva appuntellarsi con la mano sull’arcione; lamentava poi che la mula, dove la strada era sopra un ciglione, mettesse quasi per dispetto, secondo l’uso dei pari suoi, proprio le zampe sull’orlo, in modo che egli vedeva sotto di sé, a perpendicolo, un salto, o, come pensava lui, un precipizio; poi temeva che i bravi dell’Innominato, se avessero appresa la notizia della conversione del loro padrone, facessero un’insurrezione, e, immaginando che egli fosse venuto a fare il missionario, si vendicassero su di lui; poi pensava a quel bestione di don Rodrigo, che avrebbe certo voluto sfogarsi con qualcuno («I colpi cascano sempre all’ingiù; i cenci vanno all’aria»); e infine temeva di dover rendere conto al cardinale di tutto quell’imbroglio… La comitiva arrivò che le funzioni di chiesa non erano ancora terminate; passò per mezzo alla folla medesima non meno commossa della prima volta, e poi si divise. L’Innominato e don Abbondio voltarono sur una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco; la lettiga andò avanti verso quella della buona donna. La partenza di don Abbondio. – Ma don Abbondio, appena smontato, pensò bene di ritornare al suo paese. Fece i più sviscerati complimenti all’Innominato, pregandolo di vederlo scusare con monsignore, poiché egli doveva tornare alla parrocchia per affari urgenti. Andò a cercare quel che chiamava il suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato in un cantuccio del salotto, e s’incamminò. L’Innominato stette ad aspettare che il cardinale tornasse di chiesa. Lucia in casa del sarto. – Intanto Lucia, in casa della buona donna (che era la moglie del sarto), era oggetto delle attenzioni più delicate. La buona donna s’affacendò subito a prepararle qualcosa per ristorarla. Presto presto, rimettendo stipa sotto un calzerotto, dove nuotata un buon cappone, fece alzare il bollore al brodo, e, riempitane una scodella già guarnita di fette di pane, la presentò a Lucia. Lucia, essendole tornate alquanto le forze, si andava riassettando per un istinto di pulizia e di verecondia; ma mentre si raccomandava il fazzoletto sul seno e intorno al collo, le sue dita s’intrecciarono nella corona che vi aveva messa la notte avanti e le tornò improvvisa la memoria del voto. Il primo moto dell’animo fu di pentimento, ma poi si pentì di essersi pentita, e confermò e rinnovò il suo voto, chiedendo che le fosse concessa la forza di poterlo adempiere. La famigliola del sarto. – Tutt’a un tratto si sentì uno scalpiccio e un chiasso di voci allegre. Era la famigliola del sarto, che ritornava di chiesa. Due bimbette e un fanciullo entrarono saltando, diedero un’occhiata curiosa all’ospite e corsero a chiedere notizia alla mamma. Entrò poi, con un passo più quieto, il padrone di casa, un uomo che sapeva leggere, che aveva letto infatti più d’una volta il Leggendario dei Santi, il Guerrin Meschino e i Reali di Francia, e passava per un uomo di talento e di scienza. Con questo, la miglior pasta del mondo. Egli, essendosi trovato presente quando sua moglie era stata pregata dal curato di intraprendere quel viaggio caritatevole, le aveva dato la sua approvazione; ed ora, dopo la predica del cardinale, tornava a casa col desiderio ansioso di sapere come la cosa fosse riuscita e di trovare la povera innocente salvata. Appena la vide, le fece gran festa, dicendole che era la benedizione del cielo nella sua casa. La famigliola a tavola. – Poi la famiglia si mise a tavola. La padrona pose davanti a Lucia un’ala di quel cappone, e marito e moglie fecero coraggio all’ospite abbattuta e vergognosa, perché mangiasse. Il sarto cominciò, ai primi bocconi, a discorrere con grand’enfasi della conversione miracolosa, e soprattutto della predica del cardinale, mentre i ragazzi, che in verità aveva viste troppe cose straordinarie, lo interrompevano continuamente. Poi, ricordandosi che il cardinale aveva detto che chi ha più del necessario è obbligato di farne parte a chi patisce, mise insieme un piatto delle vivande che erano sulla tavola, e lo diede alla sua bimbetta maggiore perché portasse ogni cosa a Maria vedova e ai suoi figlioletti, ma con buona maniera e senza aver l’aria di far l’elemosina. L’arrivo di Agnese. – Qualche tempo dopo arrivò Agnese. E’ facile pensare come la povera donna fosse rimasta a quella notizia, necessariamente tronca e confusa, di un pericolo cessato, ma spaventoso. Dopo essersi cacciata le mani nei capelli, dopo aver gridato più volte: «Ah Signore! ah Madonna!», era entrata in fretta e furia nel baroccio, continuando per la strada ad esclamare e a interrogare, senza profitto. A un certo punto aveva incontrato don Abbondio che veniva adagio adagio, mettendo avanti ad ogni passo il suo bastone. Si erano ritirati in disparte, in un castagneto che costeggiava la strada, e don Abbondio l’aveva ragguagliata di ciò che aveva potuto sapere; poi aveva voluto entrare nel discorso sul modo di regolarsi con l’arcivescovo, se questo, come era probabile, avesse desiderato di parlare con lei e con la figliuola, e soprattutto che non conveniva far parola del matrimonio…. Ma Agnese, accorgendosi che il brav’uomo non parlava che per il proprio interesse, l’aveva piantato senza promettergli nulla e s’era rimessa in istrada. Quando il baroccio arrivò alla casa del sarto, madre e figlia si gettarono l’una nelle braccia dell’altra, versando lacrime di consolazione. Agnese volle sapere i casi di Lucia, e questa si mise affannosamente a raccontarli; ma tacque, per timore che la madre le desse dell’imprudente e della precipitosa, o per una certa vergogna a entrare in quella materia del voto che aveva fatto in quella notte angosciosa. La visita del cardinale. – Il discorso fu interrotto da una novità inaspettata; la visita del cardinale. Questi, tornato di chiesta, avendo sentito dall’Innominato che Lucia era arrivata sana e salva, era andato a tavola con lui, facendoselo sedere a destra, in mezzo a una corona di preti, che non potevano saziarsi di dare occhiate a quell’aspetto così ammansato. Finito di desinare, l’Innominato era partito per il suo castello; e il cardinale, seguito da gran folla, si era recato alla casa del sarto per far visita a Lucia. Le due donne, all’apparire del porporato, rimasero immobili e mute dalla sorpresa e dalla vergogna; ma Agnese, incoraggiata dall’aspetto e dalle parole di Federigo, si riebbe ben presto, e, prendendo l’occasione, si sfogò contro don Abbondio, che si era rifiutato di fare il suo dovere. Il cardinale promise che si sarebbe fatto render conto dal curato di questo fatto; ma Agnese osservò che non sarebbe servito a nulla, poiché don Abbondio era un uomo che, tornando il caso, avrebbe fatto lo stesso. Federigo domandò poi dove fosse il promesso sposo, e, sentendo da Agnese che era scappato dal suo paese, si meravigliò che un tal giovane avesse potuto essere in trattato di matrimonio con una ragazza così virtuosa; ma Lucia, pur facendo il viso rosso, prese subito le difese di colui che era stato il suo promesso, ed Agnese confermò le parole della figlia, soggiungendo, con tono di amara esperienza, che «i poveri ci vuol poco a farli comparire birboni». Il cardinale ringraziò poi i padroni di casa per l’ospitalità accordata alle donne, ma il sarto, nonostante lo sforzo di trovare qualche bella risposta non seppe dire che un «si figuri!», cosa della quale rimase poi sempre avvilito. Il cardinale pensò infine di ricompensare quell’uomo, che non doveva esser ricco, pagando tutti i debiti che i paesani poveri avevano con lui, e facendo a proprie spese rivestire quelli più poveri ancora, che non avevano potuto far debiti per mancanza di credito. L’Innominato parla ai suoi bravi. – Non si può però chiudere la storia di quella giornata, senza raccontar brevemente come la terminasse l’Innominato. Tornato al castello, dove la fama della sua conversione l’aveva preceduto, fece adunare tutti i suoi bravi nella sala grande. Egli annunciò loro la mutazione che era avvenuta in lui, annullò ogni ordine scellerato che aveva già impartito, e dichiarò di essere disposto a tenere ancora al suo servizio chi volesse imitarlo, mentre chi non volesse, doveva lasciare la sua casa per sempre. I bravi rimasero sbalorditi, ma nessuno di essi pensò che, per esser lui convertito, si potesse prendergli il sopravvento. Vedevano in lui un santo, ma uno di quei santi che si dipingono con la testa alta e con la spada in pugno. Quando l’Innominato, alla fine delle sue parole, alzò di nuovo quella mano imperiosa per accennare che se ne andassero, tutti quanti, come un branco di pecore, se la batterono quatti quatti. Uscì anche lui dietro a loro, e, quando vide che era tutto quieto, andò finalmente a dormire. Entrò in camera, s’accostò a quel letto in cui la notte avanti aveva trovato tante spine, vi s’inginocchiò accanto, e cominciò a recitare le preghiere che aveva imparato da bambino; poi si rizzò, andò a letto e s’addormentò immediatamente. Don Rodrigo parte per Milano. – Il giorno seguente, nel paesetto di Lucia e in tutto il territorio di Lecco, non si parlava che di lei, dell’Innominato, dell’arcivescovo e di don Rodrigo. Questi, fulminato da quella notizia così diversa dall’avviso che aspettava di giorno in giorno, stette per due giorni rintanato nel suo palazzotto, solo coi suoi bravi, a rodersi; il terzo giorno, avendo saputo che il cardinale veniva da quelle parti, partì per Milano come un fuggitivo, sbuffando e giurando di tornare ben presto a fare le sue vendette. Il cardinale nel paese di Lucia. – Intanto il cardinale veniva visitando le parrocchie del territorio di Lecco. Il giorno in cui doveva arrivare a quella di Lucia, gli abitanti andarono sulla strada ad incontrarlo, preceduti da don Abbondio, infastidito e per il fracasso che lo sbalordiva, e per il brulicare della gente innanzi e indietro, che, come andava ripetendo, gli faceva girare la testa, e per il rodìo segreto che le donne avessero potuto ciarlare e gli toccasse perciò di render conto del matrimonio. Quando si vide spuntare il cardinale, la gente si affrettò alla rinfusa; e don Abbondio, dopo aver detto tre o quattro volte: «Adagio; in fila; cosa fate?», si voltò indispettito; e seguitando a borbottare: «E’ una babilonia, è una babilonia», entrò in chiesa, intanto che era vuota; e stette lì ad aspettare. Il cardinale, entrato in chiesa, fece, secondo il suo solito, un piccolo discorso al popolo; poi, ritiratosi nella casa del parroco, tra gli altri discorsi, gli domandò informazioni di Renzo. Don Abbondio disse che era un giovane un po’ vivo, un po’ testardo, un po’ collerico; ma, a più particolari domande, dovette rispondere che era un galantuomo, e che anch’egli non sapeva capire come in Milano avesse potuto fare tutte quelle diavolerie che avevano detto. Il cardinale diede poi disposizioni perché Lucia tornasse alla sua casa, in attesa di metterla definitivamente al sicuro. Don Abbondio fu tutto contento che il cardinale gli avesse parlato dei due giovani, senza chiedergli conto del suo rifiuto per maritarli, poiché pensava che Agnese (miracolo!) fosse stata zitta; e non sapeva, il pover’uomo, che Federigo non era entrato in quell’argomento, perché intendeva di parlargliene più a lungo, in tempo più libero. Don Ferrante e donna Prassede. – Ma i pensieri del buon prelato per mettere Lucia al sicuro erano divenuti inutili. Poco distante dal paesetto, dov’era la casa del sarto, villeggiava una coppia d’alto affare: dono Ferrante e donna Prassede. Questa era una vecchia gentildonna, molto inclinata a far del bene, ma con molte idee storte, per cui le accadeva o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di servirsi come mezzi di cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta. Donna Prassede prende in casa Lucia. – Avendo sentito il gran caso di Lucia, e avendo appreso che il cardinale si era incaricato di trovare ad essa un ricovero, donna Prassede si esibì di prendere la giovane in casa, dove, senza essere addetta ad alcun servizio particolare, avrebbe potuto a piacer suo aiutare le altre donne nei loro lavori. Essa, oltre il bene chiaro e immediato che c’era in un’opera tale, se ne proponeva un altro, forse più considerabile, secondo lei: di raddrizzare un cervello, di mettere sulla buona strada chi ne aveva gran bisogno, perché, fin da quando aveva sentito per la prima volta parlar di Lucia, si era persuasa che una giovane, la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a un scampaforca, qualche magagna nascosta la doveva avere. Donna Prassede mandò una carrozza, con un vecchio braciere, a prender la madre e la figlia, e, quando queste furono alla sua presenza, fece loro grandi accoglienze e molte congratulazioni, offrendosi di ospitare Lucia. Le due donne si guardarono in viso, e, nella loro dolorosa necessità di dividersi, parve ad esse che l’offerta fosse da accettarsi, se non altro per essere quella villa così vicina al loro paesetto, per cui, alla peggio dei peggi, si sarebbero potute trovare insieme alla prossima villeggiatura. Don Ferrante scrive una lettera per il cardinale. – Partite le donne, donna Prassede si fece distendere da don Ferrante una lettera per avvertire il cardinale. Don Ferrante, che, essendo letterato, era, nelle occasioni d’importanza, come il segretario di donna Prassede, ci mise tutto il suo sapere, e, consegnando la minuta da copiare alla consorte, le raccomandò caldamente l’ortografia, che era una delle molte cose che aveva studiato, e delle poche sulle quali avesse lui il comando in casa. Il cardinale conosceva la casa di donna Prassede quanto bastasse per esser certo che Lucia c’era invitata con buona intenzione, e che lì sarebbe sicura dalle insidie e dalla violenza del suo persecutore. Probabilmente non era quella la persona che avrebbe scelta a un tale intento; ma non era suo costume di disfare le cose che toccavano a lui per rifarle meglio. Il cardinale rimprovera don Abbondio. – Terminate le funzioni, don Abbondio, che era corso a vedere se Perpetua aveva ben disposto ogni cosa per desinare, fu chiamato dal cardinale, il quale gli chiese per quale motivo non aveva unito in matrimonio Lucia con il suo promesso sposo. Don Abbondio comprese subito che Agnese e Lucia avevano vuotato il sacco, e dapprima cerò di dare risposte evasive, poi, messo alle strette, si decise a raccontare tutta la dolorosa storia. Il cardinale gli domandò se non avesse avuto altro motivo, e il povero curato rispose, a propria giustificazione, che sotto pena della vita gli avevano intimato di non far quel matrimonio; poi, alle parole di rimprovero del cardinale, rispose ancora che don Rodrigo era un signore con cui non si può né vincerla né impattarla; e infine, alle nuove parole di rimprovero, rispose che il coraggio uno non se lo può dare. Mentre il cardinale parlava, esaltando il ministero del sacerdozio, don Abbondio si sentiva come un pulcino tra gli arti del falco, che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta, in un’aria che non ha mai respirato; ma, fermo sui suoi principi, trovava strano che al cardinale stessero più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote. Il cardinale gli chiese infine che cosa avesse fatto per riparare al pericolo che sovrastava a due giovani della sua parrocchia. E tacque in atto di chi aspetta. Continua il colloquio del cardinale con don Abbondio. – A una siffatta domanda, don Abbondio restò lì senza articolar parola, mentre il cardinale continuò i suoi rimproveri, dicendo che egli aveva ubbidito all’iniquità, non curando ciò che il dovere gli prescriveva, e che aveva mendicato dei prestiti al suo rifiuto per non rivelarne il motivo. Il povero curato, pur pensando che il cardinale a quel satanasso dell’Innominato aveva gettato le braccia al collo, mentre a lui, per una mezza bugia, detta solo a fine di salvare la pelle, faceva tanto chiasso, rispose ad alta voce di aver mancato, ma chiese che cosa avrebbe dovuto fare in un frangente di quella sorte. Il cardinale gli disse che avrebbe dovuto unire, secondo la legge di Dio, ciò che l’uomo voleva separare, e, in ogni modo, avrebbe dovuto informare il suo vescovo dell’impedimento che un’infame violenza metteva all’esercizio del suo ministero. Don Abbondio, a queste parole, pensò stizzosamente ai pareri di Perpetua. Il cardinale proseguì ancora, rimproverandolo di aver trascurato ogni altra cosa di fronte al suo pericolo temporale; e don Abbondio si lasciò scappare che le aveva viste lui quelle facce, che le aveva sentite lui quelle parole, e che bisognava essere nei panni di un povero prete ed essersi trovato al punto. Appena detto ciò, si morse la lingua, e disse tra sé: - Ora viene la grandine; - ma, con sua grande sorpresa, il cardinale lo invitò a rimproverargli liberamente le sue debolezze, affinché essi potessero confondersi liberamente davanti a Dio per confidare insieme. Don Abbondio, pur pensando fra sé: - Oh che sant’uomo! ma che tormento! – rispose elogiando il petto forte e lo zelo imperterrito del cardinale, il quale si schermì, dicendo che non desiderava una lode che lo faceva tremare. Don Abbondio chiese infine al suo interlocutore se era venuto a conoscenza che i due promessi si erano introdotti a casa sua, a tradimento, per sorprenderlo e per fare un matrimonio contro le regole. Federigo rispose che si accorava, vedendo che egli pensava di scusarsi, accusando. Don Abbondio stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire, e, se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre (che quella stessa paura era sempre lì a far l’ufficio del difensore), sentiva però un certo dispiacere di sé, come lo stoppino umido e ammaccato di una candela, che, presentato alla fiamma di una grande torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol saper nulla, ma alla fine s’accende e bene o male brucia. Fine del colloquio. – Concludendo il suo discorso, il cardinale raccomandò a don Abbondio di non lasciarsi sfuggire l’occasione di far del bene a Renzo e a Lucia, aggiungendo che avrebbe desiderato tenere con lui tutt’altri discorsi. Don Abbondio promise che non avrebbe mancato davvero, con una voce che, in quel momento, veniva proprio dal cuore. Poi Federigo si mosse, e don Abbondio gli andò dietro. Lucia in casa di donna Prassede. – La mattina seguente venne donna Prassede, secondo il fissato, a prendere Lucia e a complimentare il cardinale, che gliela lodò e raccomandò caldamente. Lucia si staccò dalla madre piangendo, ma i congedi con essa non erano gli ultimi, perché donna Prassede si sarebbe fermata ancora qualche giorno in quella sua villa, che non era molto lontana, e Agnese promise alla figlia di andarla a trovare. L’Innominato fa pervenire ad Agnese cento scudi d’oro per Lucia. – Il cardinale era anche lui sulle mosse per continuare la sua visita, quando arrivò il curato della parrocchia, in cui era il castello dell’Innominato, con una lettera di quel signore, che pregava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d’oro per servir di dote alla giovane, o per quell’uso che ad essa sarebbe parso migliore; ed aggiungeva che se mai, in qualunque tempo, avessero creduto che egli potesse render loro qualche servizio, la povera giovane sapeva purtroppo dove stesse, e per lui quella sarebbe una delle fortune più desiderate. Il cardinale consegnò subito il rotolo ad Agnese, che lo prese senza far gran complimenti; andò a casa zitta zitta, si chiuse i camera, vide con ammirazione tutti in un mucchietto tanti di quei ruspi, dei quali forse non aveva mai visto più d’uno per volta e anche di rado, ne fece un involto, e, legatolo bene in giro con della cordellina, lo ficcò in un cantuccio del suo saccone. All’alba del giorno seguente s’alzò e s’incamminò subito verso la villa dov’era Lucia. Lucia rivela alla madre il segreto del voto. – Quando furono sole, Agnese raccontò alla figlia l’inaspettata fortuna e le propose, appena Renzo avesse data notizia di sé, di andarlo a raggiungere tutte e due a Milano. Ma Lucia, invece di animarsi, le gettò le braccia al collo, e piangendo le rivelò il voto fatto in quella notte tremenda. Agnese rimase stupefatta e costernata, e non seppe che lamentarsi di non esserne stata messa subito a parte. Lucia prega la madre di far sapere la cosa a Renzo. – Lucia pregò poi la madre affinché, appena fosse riuscita ad avere notizie di Renzo, gli facesse sapere com’era andata la cosa, e lo esortasse a mettere il cuore in pace; e la pregò, nello stesso tempo, di fargli avere la metà dei cento scudi d’oro, poiché, se quel poverino non avesse avuto la disgrazia di pensare a lei, non gli sarebbe accaduto ciò che gli era accaduto. Agnese promise che così avrebbe fatto, e Lucia ringraziò con una gratitudine, con un affetto, da far capire, a chi l’avesse osservata, che il suo cuore faceva ancora a mezzo con Renzo, forse più che la medesima non lo credesse. Renzo muta il proprio nome in quello di Antonio Rivolta. – Intanto cominciò a passar molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo. Anche il cardinal Federigo, che non aveva detto per cerimonia alle povere donne di voler prendere informazioni del giovane, aveva ricevuto come risposta che non si era potuto trovar recapito dell’indicato soggetto; che veramente era stato qualche tempo in casa di un suo parente, nel tal paese, ma una mattina era scomparso all’improvviso, e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato, e non poteva che ripetere certe voci in aria e contradditorie, essersi il giovane arruolato per il Levante, esser passato in Germania, esser perito nel guadare un fiume. Ma erano tutte ciarle: ecco il fatto. Il governatore di Milano, don Gonzalo Fernandez di Cordova, aveva fatto un gran fracasso col residente di Venezia in Milano, perché il famoso Lorenzo Tramaglino, malandrino, ladrone pubblico, promotore di saccheggio e d’omicidio, fosse stato accolto nel territorio bergamasco. Il residente aveva scritto a Venezia, ma il governo veneziano aveva per massima di secondare l’inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco, e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi, soprattutto la sicurezza. Perciò Bortolo fu avvisato in confidenza, non si sa da chi, che Renzo non stava bene in quel paese, e che avrebbe fatto meglio a entrare in qualche altra fabbrica, cambiando anche nome per qualche tempo. Bortolo corse a dir la cosa al cugino, e lo condusse a un altro filatoio, discosto da quello forse quindi miglia, e lo presentò al padrone, che era un suo antico conoscente, sotto il nome di Antonio Rivolta. Il padrone non ebbe che a lodarsi dell’acquisto; meno che, sul principio, gli parve che il giovane dovesse essere un po’ stordito, perché, quando si chiamava: Antonio! le più volte non rispondeva. Poco dopo venne un ordine da Venezia al capitano di Bergamo, che prendesse informazioni se nella sua giurisdizione, e segnatamente nel tal paese, si trovasse il tal soggetto; e il capitano, fatte le sue diligenze, come aveva capito che si volevano, trasmise la risposta negativa. Non mancavano poi i curiosi, che volevano sapere da Bortolo perché quel giovane non c’era più, e Bortolo rispondeva che era scomparso, e, per mandare in pace i più insistenti, aveva creduto bene di regalar loro le notizie sopra riferite; però come cose incerte, che aveva sentito dire anche lui, senza averne un riscontro positivo. Ma quando la domanda gli venne fatta per commissione del cardinale, senza nominarlo, ma lasciando capire che era il nome di un gran personaggio, Bortolo si insospettì ancor più, e diede in una volta tutte le notizie che aveva dato ad una ad una in quelle diverse occorrenze. Non si deve però credere che don Gonzalo l’avesse proprio col povero filatore di montagna. Ciò dipese dal fatto che Renzo, senza volerlo, si trovò impigliato, con un sottilissimo filo, a troppe e troppe gran cose, che si esporranno nel capitolo seguente. La guerra per la successione del ducato di Mantova e del Monferrato. – Già più di una volta si è fatto cenno della guerra, che allora bolliva, per la successione agli stati del duca Vincenzo Gonzaga. Alla morte di costui, il primo in linea di successione, Carlo Gonzaga, capo d’un ramo cadetto trapiantato in Francia, dove possedeva i ducati di Nevers e di Rhétel, era entrato, col favore del cardinale di Richelieu, dei Veneziani e del Papa, in possesso di Mantova e del Monferrato; ma la Spagna, che voleva ad ogni patto escludere da quei feudi il nuovo principe di Guastalla, su Mantova, e di Carlo Emanuele I, duca di Savoia, sul Monferrato. Don Gonzalo Fernandez di Cordova, governatore di Milano, interpretando le intenzioni della corte di Madrid, aveva concluso col duca di Savoia un trattato per la divisione del Monferrato, e aveva posto l’assedio a Casale, ma con scarso successo. Don Gonzalo si occupa di Renzo. – Mentre durava l’assedio di Casale, scoppiarono i tumulti di Milano, e don Gonzalo accorse di persona in questa città. Qui, avendo appreso che Renza si era rifugiato sul territorio di Bergamo, e sospettando che Venezia alzasse la cresta per la sommossa di Milano, volle mostrare che non aveva perso nulla dell’antica sicurezza; e perciò, essendosi incontrato col residente di Venezia, fece tutto quel fracasso a proposito di Renzo. Dopo, non s’occupò più di un affare così minuto; e quando più tardi gli arrivò la risposta al campo sopra Casale, dove aveva tutt’altri pensieri, alzò e dimenò la testa, come un baco da seta che cerchi la foglia; stette lì un momento, per farsi tornar vivo nella memoria quel fatto, ebbe un’idea fugace e confusa del personaggio, passò ad altro e non ci pensò più. Renzo riesce a far pervenire sue notizie ad Agnese. – Ma Renzo, che non supponeva una così benigna noncuranza, se ne stette un pezzo nascosto. Egli si struggeva di mandar le sue nuove alle donne e di avere le loro, ma doveva affrontar la duplice difficoltà di confidarsi a un segretario, perché non sapeva scrivere, mettendo in tal modo un terzo a parte dei suoi interessi; e di trovare un corriere, che andasse da quelle parti e si incaricasse di recapitare la lettera. Finalmente trovò modo di far pervenire una lettera ad Agnese; ed Agnese, a sua volta, avendo a segretario un suo cugino Alessio, residente a Maggianico, riuscì ad inviare la risposta. Si avviò insomma tra le due parti un carteggio, né rapido né regolare, ma pure continuato, nonostante tutti gli inconvenienti che nascono dalle necessità di tanti intermediari, e per lo scrivere e per il leggere. Renzo riceve i cinquanta scudi e la notizia del voto. – Un giorno Renzo ricevette da Agnese un rotolo di cinquanta scudi, con una lettera in cui il segretario di Agnese descriveva oscuramente la tremenda storia di «quella persona» (così diceva), e poi, per via di perifrasi, del voto e della necessità di mettere il cuore in pace. Renzo poco mancò che non se la prendesse col lettore interprete: tremò, inorridì, s’infuriò, si fece rileggere tre o quattro volte il terribile scritto; e fece immediatamente rispondere che il cuore in pace non lo voleva mettere e non lo metterebbe mai, che il denaro lo avrebbe tenuto in deposito per la dote della giovane, che egli aveva sempre sentito dire che la Madonna aiuta i tribolati, ma non fa mancar di parola, e cose simili. Donna Prassede cerca di far dimenticare Renzo a Lucia. – Lucia, quando la madre poté farle sapere che Renzo era vivo e in salvo, sentì un gran sollievo, e non desiderava più altro se non che egli si dimenticasse di lei. Dal canto suo, faceva cento volte al giorno una risoluzione simile riguardo a lui, cercando di occuparsi tutta in qualche lavoro; ma quell’immagine, proprio come se avesse avuto malizia, si introduceva di soppiatto nella sua mente, in modo che il non pensare a lui era impresa disperata. Vi era poi donna Prassede, che, tutta impegnata dal canto suo a levarle dall’animo colui, non aveva trovato miglior espediente che di parlargliene spesso, accennando al birbante venuto a Milano per rubare e scannare, e volendo farle confessare le bricconate che colui doveva aver fatte anche al suo paese. Lucia, con la voce tremante di vergogna e di dolore, assicurava che al suo paese quel poveretto non aveva mai fatto parlar di sé, altro che in bene; ma da queste apologie donna Prassede ricavava nuovi argomenti per convincere Lucia che il suo cuore era ancora perso dietro a lui. Carattere di donna Prassede. – Buon per lei che non era la sola a cui donna Prassede avesse a far del bene, sicché le baruffe non potevano essere così frequenti. Oltre il resto della servitù, tutti cervelli che avevano bisogno, più o meno, di essere raddrizzati e guidati, aveva anche cinque figlie, di cui tre monache e due maritate. Donna Prassede si trovava in tal modo ad avere tre monasteri e due case a cui soprintendere: impresa vasta e complicata, tanto più che due mariti, spalleggiati da padri, da madri, da fratelli, e tre badesse, fiancheggiate da altre dignità e da molte monache, non volevano accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi cinque guerre, scoperte, gentili, fino a un certo segno, ma vive e senza tregua. Dove il suo zelo poteva esercitarsi liberamente, era in casa: lì ogni persona era soggetta, in tutto e per tutto, alla sua autorità, fuorché don Ferrante, col quale le cose andavano in un modo tutto particolare. Carattere di don Ferrante. – Don Ferrante era un uomo di studio, a cui non piaceva né comandare né ubbidire. Che in tutte le cose di casa la signora moglie fosse la padrona, alla buon’ora; ma lui servo, no. Perciò donna Prassede brontolava spesso con lui, lo nominava uno schivafatica, un uomo fisso nelle sue idee, un letterato; titolo nel quale, insieme con la stizza, c’entrava anche un po’ di compiacenza. Don Ferrante passava grandi ore nel suo studio, dove aveva una raccolta di circa trecento volumi, tutta roba scelta, tutte opere delle più riputate, in varie materie, in ognuna delle quali era più o meno versato. Nell’astrologia era ritenuto, e con ragione, per più che un dilettante. Della filosofia antica aveva imparato quanto poteva bastare, e vi andava di continuo imparando di più. Siccome però, a voler essere filosofo, bisogna scegliere un autore, così egli aveva scelto Aristotele, il quale, come diceva lui, non è né antico né moderno, è il filosofo. Del rimanente, quantunque nel giudizio dei dotti passasse per un peripatetico consumato, a lui non pareva di saperne abbastanza; e più d’una volta disse, con gran modestia, che l’essenza, gli universali, l’anima del mondo e la natura delle cose non erano cose tanto chiare, quanto si potrebbe credere. Della filosofia naturale s’era fatto più un passatempo che uno studio. Le opere stesse di Aristotele su questa materia, e quelle di Plinio, le aveva piuttosto lette che studiate: ma tuttavia era in grado di descrivere esattamente le forme e le attitudini delle sirene e dell’unica fenice, sapeva spiegare come la salamandra stia nel fuoco senza bruciare, come la rèmora, quel pesciolino, abbia la forza di fermare di punto in bianco, in alto mare, qualunque nave, ed altre cose ancora. Negli studi di magia e di stregoneria si era internato di più, trattandosi di scienza molto più in voga e più necessaria, per potersi guardare e difendere dalle pessime arti dei maliardi. Ugualmente vaste e fondate erano le sue cognizioni in fatto di storia, specialmente universale; ma poiché la storia, secondo don Ferrante, non servirebbe a nulla senza la politica, c’era anche nei suoi scaffali un palchetto assegnato agli statisti tra i quali il Paruta, il Boccalini, e soprattutto il Machiavelli («mariolo sì, diceva don Ferrante, ma profondo»); e il Botero («galantuomo sì, diceva pure, ma acuto»); in ultimo però era il passato a dare il primato al libro di don Valeriano Castiglione. Ma se in tutte le scienze suddette don Ferrante poteva dirsi addottrinato, una ce n’era in cui meritava il titolo di professore: la scienza cavalleresca. Non solo ne ragionava con vero possesso, ma, pregato frequentemente di intervenire in affari d’onore, dava sempre qualche decisione. Aveva nella sua libreria, e si può dire in testa, le opere degli scrittori più riputati e l’autore degli autori, che era per lui il Birago. Agnese e Lucia non si ritrovano più insieme. – Fino all’autunno del 1629 tutti i nostri personaggi rimasero a un di presso nello stato in cui li abbiamo lasciati. Venne l’autunno, in cui Agnese e Lucia avevano fatto conto di ritrovarsi insieme, ma un grande avvenimento pubblico mandò quel conto all’aria. Conseguenze della sommossa di Milano. – Dopo la sedizione del giorno di san Martino e del seguente, parve che l’abbondanza fosse ritornata in Milano, come per miracolo. Pane in quantità da tutti i forni; il prezzo, come nelle annate migliori. La moltitudine, naturalmente, si diede ad assediare i fornai, investendo i denari in pane e farina, e rendendo in tal modo sempre più difficile la durata di quel buon mercato. Il governo ricorse allora alle grida, per proibire gli accaparramenti, per impedire l’uscita delle granaglie dalla città, per confiscare il risone da far entrare nel pane detto di mistura, e via dicendo. Così, alla fine dei conti, due furono i frutti principali della sommossa: guasto e perdita di viveri nella sommossa medesima; consumo, finché durò la tariffa, largo, spensierato, senza misura, a spese di quel poco grano, che pur doveva bastare fino alla nuova raccolta. Si aggiungano quattro disgraziati, impiccati come capi del tumulto: due davanti al forno delle grucce, due in cima della strada dov’era la casa del vicario di provvisione. La carestia a Milano. – Ed ecco, nell’inverno avanzato e nella primavera, quando la carestia cominciò ad operare senza ritegno, e con tutta la sua forza, il ritratto doloroso del paese, principalmente della città. Ad ogni passo botteghe chiuse; le fabbriche in gran parte deserte; le strade, un indicibile spettacolo, un corso incessante di miserie, un soggiorno perpetuo di patimenti. Gli accattoni di mestiere, diventati ora il minor numero, confusi e perduti in una nuova moltitudine, ridotti a litigar l’elemosina con quelli da cui in altri giorni l’avevano ricevuta. C’erano pure, e si conoscevano ai ciuffi arruffati e ai cenci sfarzosi, molti di quella genia dei bravi che, perduto quel loro pane scellerato, ne andavano chiedendo per carità. Ma forse il più brutto e insieme il più compassionevole spettacolo erano i contadini, scompagnati, a coppie, a famiglie intere; cacciati dalle loro terre o dalle soldatesche o dalle sterilità o dalle gravezze, più esorbitanti che mai per soddisfare a ciò che si chiamavano i bisogni della guerra, e venuti in città come ad ultimo asilo di ricchezza e di pia magnificenza. Qua e là per le strade, rasente ai muri delle case, si vedeva qualche po’ di paglia pesta, trita e mista d’immondo ciarpame. Una tal porcheria era però un dono e uno studio della carità; erano covili apprestati a qualcuno di quei meschini per posarci il capo la notte. Ogni tanto ci si vedeva, anche di giorno, giacere o sdraiarsi taluno, a cui la stanchezza o il digiuno aveva levate le forze e tronche le gambe; qualche volta quel tristo letto portava un cadavere; qualche volta si vedeva uno cadere come un cencio all’improvviso e rimanere cadavere sul selciato. L’opera del cardinal Federigo. – Il buon cardinale Federigo faceva del suo meglio per lenire tanta sciagura. Ogni mattina, per sua disposizione, tre coppie di preti, seguiti da facchini carichi di cibi e di vesti, giravano per la città venendo incontro ai più disperati bisogni. Aveva inoltre fatte gran compre di granaglie, e ne aveva spedite una buona parte ai luoghi della diocesi, che n’erano più scarsi; ed essendo il soccorso troppo inferiore al bisogno, mandò anche del sale, «con cui», dice, raccontando la cosa, il Ripamonti, «l’erbe del prato e le cortecce degli alberi si convertono in cibo». Nel palazzo arcivescovile, come attesta uno scrittore contemporaneo, il medico Alessandro Tadino, si distribuivano ogni mattina due mila scodelle di minestra di riso. Ma questi effetti di carità, che possiamo certamente chiamare grandiosi, quando si consideri che venivano da un sol uomo e dai suoi mezzi (giacché Federigo ricusava, per sistema, di farsi dispensatore delle liberalità altrui), erano ancora poca cosa in confronto del bisogno. Il Ripamonti dice di aver visto il cadavere di una povera donna, con la bocca piena d’erba mezza rosicchiata e con accanto un bambino che cercava piangendo il seno materno… Il Tribunale di Provvisione riunisce gli accattoni nel lazzaretto. – Così passò l’inverno e la primavera; e poiché il Tribunale della Sanità temeva il pericolo di un contagio per tanta miseria ammontata in ogni parte della città il Tribunale di Provvisione decise di radunare tutti gli accattoni, sani e infermi, nel lazzaretto, dove dovevano essere curati e mantenuti a spese pubbliche, contro il parere della Sanità, la quale opponeva che, in una così gran riunione, sarebbe cresciuto il pericolo a cui si voleva metter riparo. Il lazzaretto di Milano era un recinto quasi quadrato, fuori della città, a sinistra della porta detta Orientale. I due lati maggiori erano lunghi a un dipresso cinquecento passi; gli altri due, forse quindici meno; tutti, dalla parte esterna, divisi in piccole stanze da un piano solo: di dentro girava intorno a tre di essi un portico continuo a volta, sostenuto da piccole e magre colonne. Le stanzine erano duecentottantotto. Nel centro dello spazio interno c’era, e c’è tuttora, una piccola chiesa ottagonale. Molti accattoni vi concorsero volontariamente; tutti quelli che giacevano infermi per le strade e per le piazze ci vennero trasportati; in pochi giorni ce ne furono più di tremila. Ma molto più furono quelli che, non facendo conto dell’invito, restarono fuori. Visto ciò, si credé di passare alla forza, mandando in ronda birri, che cacciassero gli accattoni al lazzaretto o vi menassero legati quelli che vi resistevano, per ognuno dei quali fu assegnato il premio di dieci lire. La caccia fu tale che, in poco tempo, il numero dei ricoverati si accostò a diecimila. Come stessero poi tutti insieme di alloggio e di vitto, si potrebbe tristemente congetturarlo, quando non se ne avessero notizie positive. Dormivano ammontati a venti a trenta per ognuna di quelle cellette, o accovacciati sotto i portici, sopra un po’ di paglia putrida e fetente, o sulla nuda terra; il pane era alterato con sostanze pesanti e non nutrienti; l’acqua scarsa e inquinata. La mortalità nel lazzaretto. – A tutte queste cagioni di mortalità, che operavano sopra corpi ammalati o ammalazzati, si aggiunse una gran perversità della stagione: piogge ostinate, siccità ancor più ostinata, e con essa un caldo anticipato e violento. Non farà quindi stupore che la mortalità crescesse e regnasse in quel recinto fino ad assumere l’aspetto e, presso molti, nome di pestilenza. Il numero giornaliero dei morti oltrepassò in poco tempo il centinaio. Finalmente il Tribunale di Provvisione, per porre un riparo a tale situazione, pensò bene di disfare ciò che aveva fatto con tanto apparato, con tanta spesa, con tante vessazioni. Aprì il lazzaretto, licenziò tutti i poveri non ammalati che ci rimanevano, e fece trasportare gli infermi a Santa Maria della Stella, allora ospizio dei poveri, dove la più parte morivano. Il nuovo raccolto. – Intanto però cominciavano quei benedetti campi a imbiondire. Gli accattoni, venuti dal contado, se n’andarono, ognuno dalla sua parte, a quella tanto sospirata segatura. Il buon Federigo, con un ultimo atto di carità, fece dare a ciascuno di essi, che si fosse presentato all’arcivescovado, un giulio e una falce da mietere. Con la messe cessò la carestia; ma la mortalità, pur scemando di giorno in giorno, si prolungò fin nell’autunno. Era sul finire, quand’ecco un nuovo flagello. L’esercito dell’imperatore cala nel Milanese. – Il re Luigi XIII di Francia, spinto dal cardinale Richelieu, era calato in Italia, alla testa di un esercito, per portare aiuto al duca di Nevers, e, dopo aver sconfitto il duca di Savoia, che gli aveva negato il passo verso il Monferrato, aveva costretto don Gonzalo a levare l’assedio del Casale. Fu anzi in questa occasione che l’Achillini scrisse al re Luigi quel suo famoso sonetto: L’imperatore Ferdinando a sua volta, dopo aver intimato invano al duca di Nevers di abbandonare i suoi stati e di metterli in mano dell’imperatore, inviò un esercito, sotto il comando del conte Rambaldo di Collalto, che, attraverso i Grigioni e la Valtellina, si accinse a calare nel Milanese. Esso, oltre ai danni che si potevano temere da un tale passaggio, covava – per espressi avvisi giunti al Tribunale della Sanità – la peste; ed Alessandro Tadino, uno dei conservatori della Sanità, era stato incaricato dal detto Tribunale di rappresentare al governatore lo spaventoso pericolo che sovrastava al paese; ma il governatore rispose che non sapeva cosa farci, e che i motivi d’interesse e di reputazione, per i quali quell’esercito s’era mosso, pesavano di più che il pericolo rappresentato. La partenza di don Gonzalo. – Quanto a don Gonzalo, poco dopo quella risposta, se ne andò da Milano, perché rimosso per i cattivi successi della guerra e perché incolpato dal popolo della fame sofferta sotto il suo governo. Quando uscì in carrozza da viaggio dal palazzo di corte, con due trombetti a cavallo davanti, fu accolto con gran fischiare dai ragazzi che erano radunati sulla piazza del duomo e che gli andarono dietro alla rinfusa. Entrato nella strada che conduce a Porta Ticinese, si trovò in mezzo a una folla di gente che gridava: «La va via la carestia, va via il sangue dei poveri», e peggio. Quando fu vicino alla porta, cominciarono anche a tirar sassi, mattoni, torsoli, bucce d’ogni sorta, la munizione solita di queste spedizioni. In luogo di don Gonzalo fu mandato il marchese Ambrogio Spinola, il cui nome aveva già acquistato, nelle guerre di Fiandra, quella celebrità militare che ancora gli rimane. L’esercito imperiale mette a sacco paesi e villaggi. – L’esercito alemanno aveva intanto l’ordine di portarsi all’impresa di Mantova ed era entrato nel ducato di Milano. La milizia, in quei tempi, era ancora composta in gran parte da soldati di ventura, i quali, più che dalle paghe, erano attirati a quel mestiere dalle speranze del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza. L’esercito, di cui parliamo, era composto di ventotto mila fanti e sette mila cavalli, e, scendendo dalla Valtellina per portarsi nel Mantovano, doveva seguire tutto il corso che fa l’Adda per due rami del lago, e poi di nuovo come fiume fino al suo sbocco in Po, e, infine, un buon tratto di questo fiume: in tutto otto giornate nel ducato di Milano. Una gran parte degli abitanti si rifugiarono su per i monti, portandosi quel che avevano di meglio. Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata, si spandeva subito per quello e per i circonvicini, e li metteva a sacco: ciò che c’era da godere o da portar via, spariva; il rimanente, lo distruggevano o lo rovinavano, i mobili diventavano legna, le case stalle: senza contare le busse e le ferite. Quando finalmente se n’erano andati, si udiva, dopo alcune ore di una quiete spaventosa, un nuovo maledetto batter di cassa, un nuovo maledetto suono di trombe, che annunziavano un’altra squadra. Questa, non trovando più da far preda, con tanto più furore faceva sperpero del resto, dando fuoco alle case e maltrattando le persone. E così di peggio in peggio, per venti giorni: ché in tante squadre era diviso l’esercito. Colico fu la prima terra del ducato, che invasero quei demoni; si gettarono poi sopra Bellano; di là entrarono nella Valsassina, da dove sboccarono nel territorio di Lecco. Don Abbondio si prepara a fuggire. – Chi non ha visto don Abbondio, il giorno che si sparsero le notizie della calata dell’esercito e del suo avvicinarsi, non sa bene cosa sia impiccio o spavento. Risoluto di fuggire prima di tutti e più di tutti, vedeva però, in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. Il pover’uomo correva, stralunato e mezzo fuor di sé, per la casa; andava dietro a Perpetua, per concertare una risoluzione con lei; ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta o in altri bugigattoli, passava di corsa, con le mani o con le braccia piene, e rispondeva: «Or ora finisco di mettere questa roba al sicuro, e poi faremo anche noi come fanno gli altri». Con questa o con simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per un braccio, come un ragazzo, e di trascinarlo su per una montagna. Don Abbondio, lasciato così solo, si affacciava alla finestra, e vedendo passare i suoi parrocchiani, implorava aiuto con una voce mezza di pianto e mezza di rimprovero; ma quelli, passando curvi sotto il peso della loro povera roba, tiravano di lungo senza rispondere né guardare in su. Intanto Perpetua, fattosi dare dal padrone il suo peculietto, lo sotterrò nell’orto, ai piedi del fico. Poi mise in un paniere delle munizioni da bocca, collocò in una piccola gerla un po’ di biancheria e si accinse a scendere in strada. Agnese propone di recarsi dall’Innominato. – In quel momento entrò Agnese con una merletta sulle spalle. Risoluta anche lei di non aspettare ospiti di quella sorte, sola in casa e con ancora un po’ di quell’oro dell’Innominato, si rammentò che questi le aveva mandate le più larghe profferte di servizi, e propose a don Abbondio e a Perpetua di andare tutti insieme a cercar rifugio presso di lui. La proposta parve a Perpetua un’ispirazione del cielo, e sebbene don Abbondio temesse che l’Innominato non si fosse convertito davvero, e che in ogni modo si sarebbero cacciati in una gabbia, la serva lo persuase a prendere il breviario e il cappello e a porsi in cammino. Tutti e tre presero per i campi, zitti zitti, pensando ognuno ai casi suoi, e guardandosi intorno, specialmente don Abbondio, se apparisse qualche figura sospetta, qualcosa di straordinario. Dopo un po’ di strada, don Abbondio cominciò a sospirare, poi si lasciò scappare qualche interiezione, infine prese a brontolare più di seguito. Se la prendeva col duca di Nevers, che avrebbe potuto stare in Francia a godersela; con l’imperatore, che avrebbe dovuto aver giudizio più degli altri; e principalmente col governatore, che avrebbe dovuto tener lontani i flagelli dal paese, mentre era lui che li attirava per il gusto di fare la guerra. Ma Perpetua aveva altro per la testa, poiché pensava a quello che non aveva nascosto o non aveva nascosto bene, suscitando i rimproveri del suo padrone. Agnese interrompeva quei contrasti, entrando anche lei a parlare dei suoi guai, principalmente di vedere svanita la speranza di riabbracciare presto la sua Lucia, poiché donna Prassede non sarebbe venuta quell’autunno a villeggiare da quelle parti, in tali circostanze. Usciti dai sentieri, presero la strada pubblica e giunsero al paese del sarto. La sosta presso la casa del sarto. – Agnese propose di fare una visita presso la casa del sarto, dove furono ricevuti a braccia aperte. Poiché era l’ora del desinare, dopo un po’ di cerimonie da una parte e dall’altra, si venne a patti d’accozzar, come si dice, il pentolino e di desinare in compagnia. Il sarto ordinò a una bambina (quella che aveva portato quel boccone a Maria vedova) che andasse a diricciare quattro castagne primaticce e le mettesse ad arrostire; disse a un ragazzo di andare nell’orto a dare una scossa al pesco, e ad un altro di cogliere quattro fichi dei più maturi. Lui, andò a spillare una sua botticina, la donna a prendere un po’ di biancheria da tavola. Desinarono, se non con grande allegria, almeno con molta più che nessuno dei commensali si fosse aspettato di averne in quella giornata. Mentre desinavano, il sarto si mise a parlare di quello scombussolamento, del buon ricovero che si erano scelto (dove già si era rifugiata molta gente), della santa vita dell’Innominato, del suo castello che era diventato come una Tebaide. Alzati poi da tavola, il sarto mostrò ad Agnese una stampa rappresentante il cardinale, che teneva attaccata a un battente dell’uscio, in venerazione del personaggio, ed anche per poter dire, a chiunque capitasse, che non era somigliante; poiché lui aveva potuto esaminare da vicino e con comodo il cardinale in persona, in quella medesima stanza. Ma don Abbondio faceva fretta. Il sarto trovò il baroccio per farli condurre ai piedi della salita, e in tal modo poterono principiare, con un po’ d0agio e di tranquillità, la seconda metà del viaggio. La vita dell’Innominato dopo la conversione. – Il sarto aveva detto la verità a don Abbondio intorno all’Innominato. Infatti, dal giorno della conversione, aveva sempre continuato a fare ciò che allora si era proposto: compensar danni, chieder pace, soccorrere poveri, sempre del bene in somma. Andava sempre solo e senz’armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse. Con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate, per la sua sicurezza, tante braccia. La rimembranza dell’antica ferocia e la vista della mansuetudine presente cospiravano a procacciargli un’ammirazione, che gli serviva di salvaguardia. Queste medesime ed altre cagioni allontanavano pure da lui le vendette della forza pubblica, e gli procuravano, che da questa parte, la sicurezza della quale non si dava pensiero. Così quell’uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero accorsi a gara grandi e piccoli a calpestarlo, messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti e inchinato da molti. Anche la più parte degli sgherri di casa, che non avevano potuto accomodarsi alla nuova disciplina, se n’erano andati. Quelli che si erano potuti avvezzare, per lo più nativi della valle, erano tornati ai campi, o ai mestieri imparati nella prima età; i forestieri erano rimasti nel castello come servitori. L’Innominato accoglie nel suo castello i fuggiaschi dei paesi invasi. – Quando, al calar delle bande alemanne, alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chieder ricovero, l’Innominato accolse quegli sbandati, con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia; fece sparger la voce che la sua casa era aperta a chiunque ci si volesse rifugiare; e mise in stato di difesa la valle e il castello, semmai lanzichenecchi o cappelletti volessero provarci di venirci a far delle loro. Armò i servitori che gli erano rimasti; fece dire ai suoi contadini e affittuari, che chiunque si sentiva, venisse con armi al castello; stabilì posti di guardia e turni di vigilanza. Nello stesso tempo fece preparare nel castello alloggio a quante persone fosse possibile; fece venire provvisioni abbondanti; mentre egli non istava mai fermo, mantenendo l’ordine con le parole, con gli occhi, con la presenza. Verso il castello dell’Innominato. – Quantunque il concorso maggiore non fosse dalla parte per cui i nostri tre fuggitivi si avvicinavano alla valle, ma all’imboccatura opposta, tuttavia essi cominciarono a trovar compagni di viaggio e di sventura, che da traverse e viottole erano sboccati o sboccavano nella strada. Ma questo fatto non rallegrava don Abbondio, poiché temeva che il radunarsi di tanta gente in un luogo attirasse i soldati per forza, e, in tal modo, avrebbe potuto trovarsi nel mezzo di una battaglia. Quando, all’entrata della valle, vide un buon posto d’armati, si chiese se l’Innominato volesse far la guerra; e poiché Perpetua mostrava fiducia in quegli apprestamenti difensivi, egli borbottò che il mestiere dei soldati è quello di prender le fortezze, e che per loro dare un assalto è come andare a nozze, perché tutto quello che trovano è per loro e passano la gente a fil di spada. Alla Malanotte trovarono un altro picchetto di armati, ai quali don Abbondio fece una scappellata, benché provasse l’impressione di essere capitato in un accampamento. Qui il baroccio si fermò e i tre iniziarono a piedi la salita. L’Innominato accoglie i tre fuggitivi. – Ad un tratto apparve l’Innominato, che riconosciuto don Abbondio, andò incontro ai tre fuggitivi, facendo loro le più liete accoglienze. Don Abbondio gli presentò Agnese, come una donna alla quale egli aveva già fatto del bene e madre di Lucia; e l’Innominato esclamò a testa bassa: «Del bene, io! Dio immortale! Voi, mi fate del bene a venir qui…. Da me… in questa casa siate la benvenuta. Voi ci portate la benedizione». Poi domandò premurosamente notizie di Lucia, e, sapute che l’ebbe, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti. Entrati nel castello, il signore fece condurre Agnese e Perpetua in una stanza del quartiere assegnato alle donne, e don Abbondio in una camera del quartiere degli uomini, destinata agli ecclesiastici. I tre si trattengono nel castello circa un mese. – I nostri fuggitivi si trattennero nel castello ventitré o ventiquattro giorni, senza che accadesse nulla di straordinario. Non passò forse giorno che si desse all’armi; ma l’Innominato mandava uomini ad esplorare, e, se faceva bisogno, prendeva con sé della gente e andava con essa dalla parte dov’era indicato il pericolo. Le più volte non erano che foraggieri e saccheggiatori sbandati, che si ritiravano prima di essere sorpresi. Ma una volta, avendo appreso che un paesetto vicino era messo a sacco, vi arrivò di sorpresa, e i ribaldi, che avevano creduto di non andare che alla preda, lasciarono il saccheggio a mezzo e fuggirono in fretta. Agnese e Perpetua, per non mangiare il pane a ufo, avevano voluto essere impiegate nei servizi che richiedeva una così grande ospitalità, e in questi spendevano una buona parte della giornata; il resto nel chiacchierare con certe amiche che s’erano fatte e col povero don Abbondio. Questi non aveva nulla da fare, ma non s’annoiava, poiché la paura gli teneva compagnia. In tutto il tempo che stette in quell’asilo, non se ne discostò mai quanto un tiro di schioppo, né mai mise piede sulla discesa: l’unica sua passeggiata era d’uscire sulla spianata, e d’andare, quando da una parte e quando dall’altra del castello, a guardar giù per le balze e per i burroni, per studiare se ci fosse qualche passo un po’ praticabile, qualche po’ di sentiero, per dove cercare un nascondiglio in caso di serra serra. I tre lasciano il castello. – Frattanto si cercava di avere informazioni sui reggimenti che passavano di mano in mano il ponte di Lecco, poiché quelli si potevano considerare come andati, e fuori veramente dal paese. Finalmente, quando piacque al cielo, passarono anche i reggimenti di Galasso, che fu l’ultimo. Già quelli delle terre invase per prime erano partiti dal castello, e ogni giorno ne partivano, come, dopo un temporale d’autunno, si vede dai palchi fronzuti di un grande albero uscire da ogni parte gli uccelli che ci si erano riparati. I nostri furono forse gli ultimi ad andarsene, e ciò per volere di don Abbondio, il quale temeva, se si fosse tornati subito a casa, di trovare ancora in giro lanzichenecchi rimasti indietro sbrancati; mentre Perpetua insisteva a dire che, quanto più s’indugiava, tanto più si dava agio ai birboni del paese di entrare in casa a portare via il resto. Il giorno fissato per la partenza l’Innominato fece trovare pronta alla Malanotte una carrozza, nella quale aveva già fatto mettere un corredo di biancheria per Agnese. E tiratala in disparte, le fece anche accettare un gruppetto di scudi, per riparare al guasto che avrebbe trovato in casa, quantunque essa, battendo le mani sul petto, andasse ripetendo che ne aveva lì ancora dei vecchi. Volle accompagnare tutti e tre gli ospiti fino alla carrozza, dove ricevette i ringraziamenti umili e sviscerati di don Abbondio e i complimenti di Perpetua. Una fermatina dal sarto. – Durante il ritorno fecero, secondo il fissato, una fermatina, ma senza neppur mettersi a sedere, nella casa del sarto, dove sentirono raccontare cento cose del passaggio: la solita storia di ruberie, di percosse, di sperpero, di sporcizia; ma lì, per buona sorte, non si erano visti lanzichenecchi. Il ritorno al paese. – Quando giunsero al paese, trovarono quello che si aspettavano. Agnese fece posare i fagotti in un canto del cortiletto che era rimasto il luogo più pulito della casa; ma guardando, capo per capo, la biancheria regalata, e contando quei nuovi ruspi, diceva tra sé di essere caduta in piedi. Don Abbondio e Perpetua, invece, entrarono in casa senza aiuto di chiavi; ogni passo che facevano nell’andito, sentivano crescere un tanfo, un veleno, una peste, che li respingevano indietro; con la mano al naso, andarono all’uscio di cucina; entrarono in punta di piedi, studiando dove metterli, per scansare la porcheria che copriva il pavimento. Non c’era nulla d’intero: piume e penne delle galline di Perpetua, pezzi di biancheria, fogli dei calendari di don Abbondio, cocci di pentole e di piatti. I guastatori avevano anche scarabocchiati i muri di figuracce, ingegnandosi, con certe berrettine o con certe chieriche, di farne dei preti orribili e ridicoli. Don Abbondio e Perpetua, per un altro uscio, si recarono difilato nell’orto, ma già prima di aggiungere al fico, videro la terra smossa, e, invece del morto, la buca aperta. Qui nacquero dei guai, perché don Abbondio cominciò a prendersela con Perpetua, che non aveva nascosto bene, mentre questa, naturalmente, non rimase zitta. Come se ciò non bastasse, quel disastro fu una semenza d’altre questioni molto noiose, perché Perpetua, a forza di chiedere e domandare, venne a sapere che alcune masserizie del suo padrone, credute preda dei soldati, erano invece sane e salve in casa di gente del paese; e tempestava il padrone che si facesse sentire e richiedesse il suo. Ma tasto più odioso non si poteva toccare per don Abbondio, poiché la sua roba era in mano di birboni, cioè di quella specie di persone con cui gli premeva più di stare in pace. Questi terrori non erano ancora cessati, che uno nuovo ne sopraggiunse. E questa volta si trattava ben altro che d’un disastro passeggero. La peste. – La peste, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel Milanese, c’era entrata davvero; e non si fermò qui ma invase e spopolò una buona parte d’Italia. Per tutta la striscia di territorio percorsa dall’esercito, si era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi. C’erano soltanto alcuni a cui non riuscirono nuovi, cioè quei pochi che potevano ricordarsi della peste precedente, infierita nel 1576, che aveva desolato buona parte d’Italia, e che nel Milanese fu chiamata la peste di san Carlo per l’eroica carità spiegata in quella circostanza da quel grande arcivescovo. Tra essi era il protofisico Lodovico Settala, ormai ottuagenario, il quale riferì il 20 ottobre al Tribunale della Sanità che nella terra di Chiuso (l’ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco) era scoppiato indubitatamente il contagio. Sopraggiunsero poi avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il Tribunale inviò dapprima un commissario e un medico a visitare i luoghi indicati, ma tutti e due, o per ignoranza o per altro, si lasciarono persuadere da un barbiere che non si trattava di peste, ma dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli imperiali. Più tardi, arrivando senza posa altre notizie di morti, inviò il medico Tadino e un auditore del Tribunale, i quali non poterono fare a meno di denunciare il flagello, ormai troppo evidente ed esteso. Essi furono incaricati di esporre lo stato delle cose al governatore Ambrogio Spinola, il quale rispose di provarne molto dispiacere, ma che i pensieri della guerra erano più pressanti: sed helli graviores esse curas (Ripamonti). Anche la popolazione di Milano credeva poco alla peste e attribuiva quella mortalità alla carestia dell’anno precedente, alle angherie delle soldatesche e alle afflizioni dell’animo. Un soldato porta la peste a Milano. – Il Tadino e il Ripamonti dicono che il primo che portò la peste a Milano fu un soldato al servizio della Spagna, il quale, verso i primi di novembre del 1629, entrato in città con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni, si fermò in una casa di suoi parenti, nel borgo di Porta Orientale; ma, appena arrivato, si ammalò, fu portato all’ospedale, dove gli si scoprì un bubbone sotto l’ascella, e il quarto giorno morì. Il soldato lasciò un semino che non tardò a germogliare. Il padrone di casa e tutti i pigionali furono, d’ordine della Sanità, condotti al lazzaretto, dove i più s’ammalarono e alcuni morirono. Il contagio si propagò lentamente per tutto il resto dell’anno e nei primi mesi del seguente 1630; ma la moltitudine, per la radezza dei casi, si confermava sempre più nella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, e faceva di tutto per sfuggire il lazzaretto e per evitare la confisca e la distruzione delle robe infette o sospette. Avvenne perfino che il protofisico Lodovico Settala, chiaro per scienza e nobiltà di vita, un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, fu fatto oggetto agli insulti della gente, che gridava esser lui il capo di coloro che volevano che ci fosse la peste. La peste si diffonde sempre più. – Ma sul finire del mese di marzo cominciarono, prima nel borgo di Porta Orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni. Nel lazzaretto, dove la popolazione andava ogni giorno crescendo, era un’ardua impresa quella di assicurare il servizio e la subordinazione. Il Tribunale della Sanità e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensarono di rivolgersi ai cappuccini, i quali misero a disposizione un padre Felice Casati, uomo d’età matura, ma che godeva una gran fama di carità e di attività, a quel che il seguito fece vedere, ben meritata. Di mano in mano, poiché la miserabile, radunanza andò crescendo, vi accorsero altri cappuccini, infermieri, cucinieri, guardarobieri, lavandai, tutto ciò che occorresse. La maggior parte di essi lasciarono la vita e tutti con allegrezza. Gli untori. – Anche nel pubblico quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo, di mano in mano che il morbo si diffondeva per via del contatto e della pratica: ma allora la caparbietà convinta, lungi dal riconoscere il proprio torto, andò cercando qualche altra causa, che non fosse la naturale: arti venefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a sparger la peste per mezzo di veleni contagiosi e di malie. Alcuni credettero di vedere, la sera del 17 maggio persone in duomo che ungevano un assito che serviva a dividere gli spazi assegnati ai due sessi; e quantunque il presidente della Sanità, accorso a far la visita, non trovasse nulla che potesse confermare quel sospetto, l’assito e una quantità di panche rinchiuse in quello furono portati fuori dalla chiesa. La mattina seguente un nuovo e più strano spettacolo colpì gli occhi e la mente dei cittadini. In ogni parte della città si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrisi di una sudiceria giallognola, biancastra, che vi era stata sparsa sopra come con delle spugne. La città già agitata, ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, Abbruciacchiavano gli spazi unti: i passeggeri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. Si fecero interrogatori, esami, d’arrestati, di testimoni, ma non si trovò reo nessuno. Mentre il Tribunale cercava, molti del pubblico, come accadde, avevano già trovato: chi voleva che fosse una vendetta di don Gonzalo Fernandez de Cordova per gli insulti ricevuti nella sua partenza: chi un ritrovato del cardinale di Richielieu per spopolare Milano e impadronirsene senza fatica; chi ne voleva autore il conte di Collalto, e via dicendo. Il popolo crede finalmente alla peste. – C’era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. Per levare ogni dubbio il Tribunale della Sanità trovò un espediente proporzionato al bisogno. In una delle feste della Pentecoste, in cui i cittadini usavano concorrere al cimitero di san Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregare per i morti dell’altro contagio, fece portare su un carro scoperto i cadaveri ignudi di un’intera famiglia morta di contagio, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. La peste fu più creduta; ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni giorno di più; e quella riunione medesima non dovette servir poco a propagarla. I decurioni si rivolgono per aiuto al governatore. – Divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza, furono inviati due decurioni al governatore, affinché, per leggi e consuetudini non interrotte, il fisco si assumesse le spese della peste; ma il governatore diede una risposta evasiva e inconcludente. Qualche tempo dopo, nel colmo della peste, trasferì con lettere patenti, la sua autorità a Ferrer, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. La quale guerra, sia detto incidentalmente, dopo aver portato via un milione di persone, a dir poco, per mezzo del contagio, finì col riconoscimento del nuovo duca, per escludere il quale la guerra era stata intrapresa. I decurioni si rivolgono al cardinal Federigo. – Nello stesso tempo i decurioni pregarono il cardinal Federigo che si facesse una processione solenne, portando per la città il corpo di san Carlo. Il buon prelato rifiutò, sia perché temeva che quella fiducia in un mezzo arbitrario, se l’effetto non avesse corrisposto, si cambiasse in scandalo; sia perché pensava che il radunarsi di tanta gente favorisse il perverso lavoro degli untori, o, se questi non esistevano, la diffusione del contagio. Il sospetto delle unzioni si era infatti ridestato più generale e più famoso di prima. Si diceva che tale veleno fosse composto di rospi, di serpenti, di bava e di materia d’appestati, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovare di sozzo e di atroce. Un giorno, nella chiesa di sant’Antonio, un vecchio più che ottuagenario che, volendo mettersi a sedere, aveva spolverato la panca con la cappa, fu creduto untore, e fu trascinato con pugni e calci in prigione. Tre giovani francesi, venuti per vedere l’Italia, essendosi accostati a non so quale parte esterna del duomo, come per accertarsi che era marmo, stesero la mano a toccare. Furono circondati, afferrati, malmenati, spinti a furia di percosse alle carceri. Per buona sorte il palazzo di giustizia era poco lontano dal duomo; e, per una sorte ancor più felice, furono trovato innocenti e rilasciati. Ma i decurioni, non disanimati dal rifiuto del savio prelato, replicarono le loro istanze; e Federigo, dopo aver resistito ancora qualche tempo, acconsentì che si facesse la processione, e, inoltre, che la cassa dove erano rinchiuse le reliquie di san Carlo rimanesse per otto giorni sull’altare maggiore del duomo. Cresce la furia del contagio. – Il giorno seguente la processione, le morti crebbero in ogni parte della città, e, in poco tempo, non ci fu quasi più casa che non fosse toccata. La popolazione del lazzaretto salì presto da duemila a dodicimila, e più tardi fino a sedicimila; la mortalità giornaliera arrivò, secondo il calcolo più comune a milleduecento, a millecinquecento, e, secondo il Tadino, a più di tremilacinquecento. La popolazione, che, prima della peste, passava le duecentocinquantamila anime, dopo la peste fu ridotta a poco più di sessantaquattromila. Commissari, apparitori, monatti. – Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni. Bisognava ogni giorno sostituire o aumentare serventi pubblici di varie specie: commissari, apparitori, monatti. I commissari regolavano gli apparitori e i monatti, secondo gli ordini immediati del Tribunale della Sanità. Gli apparitori dovevano precedere i carri, avvertendo col suono di un campanello i passeggeri che si ritirassero; i monatti (forse, essendo quegli uomini arruolati la più parte nella Svizzera e nei Grigioni, dal tedesco monathlich, mensuale, cioè stipendiato per un mese) erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza, come levar dalle case i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare al lazzaretto gli infermi, bruciare la roba infetta e sospetta. Esempi di carità. – Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza fu negli ecclesiastici. Più di sessanta parroci, gli otto non all’incirca, morirono di contagio. Il cardinale Federigo dava a tutti incitamento ed esempio, e sebbene tutti insistessero affinché si allontanasse dal pericolo, non volle abbandonare la città. Visitava i lazzaretti, per dar consolazione agli infermi e per animare i serventi; scorreva la città, portando soccorso ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usci, sotto le finestre, ad ascoltare i loro lamenti, a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò insomma nel mezzo della pestilenza, meravigliato anche lui alla fine di uscirne illeso. Esempi di perversità. – Ma di fronte a queste sublimazioni di virtù non mancò, come d’ordinario nei pubblici infortuni, un aumento ben più generale di perversità. I monatti e gli apparitori erano generalmente uomini, sui quali l’attrattiva delle rapine e della licenza poteva più che il terrore del contagio. Costoro erano sottoposti a strettissime regole e a severissime pene; ma, crescendo ogni giorno il numero di quelli che morivano, non ebbero quasi più nessuno che li tenesse a freno, e divennero gli arbitri di ogni cosa. Entravano da padroni nelle case, e, senza parlare dei rubamenti, e del modo con cui trattavano gli infermi, mettevano le loro mani infette e scellerate sui sani, figliuoli, parenti, mogli, mariti, minacciando di trascinarli al lazzaretto se non si riscattavano con denari. Altre volte mettevano a prezzo i loro servizi, ricusando di portar via i cadaveri già putrefatti, a meno di tanti scudi. Si disse persino che monatti e apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette, per propagare e mantenere la pestilenza, divenuta per essi un’entrata, un regno, una festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede, com’era prescritto a quelli, s’introducevano nelle case a farne di tutte le sorti. Esempi di pazzia. – Del pari con la perversità crebbe la pazzia, rinforzando e ingrandendo la paura speciale delle unzioni. Si raccontava, ad esempio, che un tale, in tal giorno, aveva visto arrivare sulla piazza del duomo un tiro a sei, e dentro un gran personaggio, con una faccia fosca e infuocata, con gli occhi accesi, coi capelli ritti, e il labbro atteggiato a minacce. Quel tale era stato invitato a salire, e dopo diversi rigiri era entrato in un palazzo, dove aveva trovato amenità e orrori, deserti e giardini, caverne e sale, e in esse fantasmi seduti a consiglio. Finalmente gli erano state fatte vedere gran casse di denaro, e gli era stato detto che ne prendesse quanto gli fosse piaciuto, purché accettasse un vasetto d’unguento e andasse con esse ungendo la città. Ma, non avendo voluto acconsentire, si era trovato, in un batter d’occhio, nel medesimo luogo dove era stato preso. D’ugual valore, se non in tutto d’ugual natura, erano i sogni dei dotti. La più parte di essi vedeva la ragione dei guai in una cometa apparsa nel 1628, e in una congiunzione di Saturno con Giove. Citavano cento autori, che avevano trattato dottrinalmente di veleni, di malie, di unti, di polveri; e specialmente quel funesto Delrio, che con le sue Disquisizioni magiche, fu, per più d’un secolo, norma e impulso potente di legali, orribili, non interrotte carneficine. Perfino i medici, che fin da principio avevano creduto alla peste, tra i quali lo stesso Tadino, si piegarono alla credenza degli untori; perfino Federigo ebbe qualche dubbio. Solo alcuni pensarono che tutto fosse immaginazione, ma non furono così arditi da manifestare un tale sentimento: il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. I processi contro gli untori. – I magistrati, sempre più smarriti e confusi, si diedero a cercare questi untori. Una lettera del gran cancelliere, conservata nell’archivio di san Fedele, informa il governatore che in una casa di campagna dei fratelli Gerolamo e Giulio Monti, milanesi, si componeva veleno in gran quantità, con l’assistenza di quattro cavalieri bresciani, i quali facevano venire i materiali dal Veneto; ma che uno dei fratelli, avvertito a tempo aveva potuto trafugare gli indizi del delitto. La cosa dovette finire in nulla, ma purtroppo in altre occasioni si credette di aver trovato. I processi che ne vennero in conseguenza non furono i primi di tal genere, e non si possono neppur considerare una rarità nella storia della giurisprudenza. Ma l’affare delle così dette unzioni di Milano fu certamente il più celebre, e, poiché sono rimasti documenti più circostanziati e più autentici, anche il più osservabile. Perciò il Manzoni promette di trattarne per esteso in un altro suo scritto (che fu la Storia della colonna infame). Don Rodrigo è colto dalla peste. – Una notte, verso la fine di agosto, proprio nel colmo della peste, tornava don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l’uno dei tre o quattro bravi, che, di tutta la famiglia, gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d’amici, soliti a straviziare insieme, per passare la malinconia di quel tempo. Quel giorno don Rodrigo era stato uno dei più allegri; e tra l’altre cose aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d’elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste due giorni prima. Camminando, però, sentiva un malessere, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un’arsione interna, che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Appena a casa, ordinò al Griso che gli facesse lume per andare in camera, e poiché questo, intuendo la vera natura di quel malessere, gli stava alla lontana, lo rassicurò dicendo che stava benone, ma che aveva bevuto forse un po’ troppo. Il sogno di don Rodrigo. – Quando fu a letto, le coperte gli parvero una montagna, e, sebbene le buttasse via, sentì crescere il caldo e la smania. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente si addormentò, e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. A un tratto gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in mezzo a una folla dai visi gialli, distrutti, con gli occhi incantati e le labbra spenzolare, con certi vestiti che cascavano a pezzi e che lasciavano intravedere macchie e bubboni. Egli chiedeva loro di far largo, per poter raggiungere la porta, ma quegli insensati, invece di scostarsi gli stavano più addosso, e soprattutto gli pareva che qualcuno di loro, con i loro gomiti o con altro, lo pigiasse a sinistra, tra il cuore e l’ascella, dove sentiva una punta dolorosa. Infuriato, volle metter mano alla spada, ma gli parve appunto che, per la calca, questa gli fosse andata su, e il pomo di essa lo premesse in quel luogo. Avrebbe voluto gridare, ma gli parve a un tratto che tutti quei visi si volgessero verso il pulpito, da cui spuntava un cranio lucido, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto fino alla cintola, fra Cristoforo. Questi, fulminato uno sguardo in giro su tutto l’uditorio, parve a don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano, nell’attitudine appunto che aveva presa in quella sala e terreno del suo palazzotto. Tentò allora di afferrare quella mano, cacciò un grand’urlo e si destò. Quando si fu raccapezzato, tutto era sparito, fuorché quel dolore dalla parte sinistra. Esitò qualche momento, prima di guardare dove aveva il dolore; finalmente vi diede un’occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d’un livido paonazzo. Il tradimento del Griso. – L’uomo si vide perduto: il terrore della morte l’invase, e, più forte ancora, quello di diventar preda dei monatti, di esser portato al lazzaretto. Chiamò il Griso e lo pregò di chiamare il Chiodo chirurgo, un galantuomo che, a pagarlo bene, teneva segreti gli ammalati. Uscito il Griso, don Rodrigo l’accompagnò con l’immaginazione alla casa del Chiodo, contò i passi, calcolò il tempo. Ad un tratto sentì uno squillo lontano, ma che pareva venire dalle stanze, non dalla strada. Gli passò per la testa un orrendo sospetto, balzò a sedere e vide apparire due monatti, mentre il Griso, nascosto dietro un battente socchiuso, rimaneva lì a spiare. Cacciò allora una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, ma uno dei monatti gli fu subito addosso, lo disarmò, lo buttò a giacere; mentre l’altro monatto e il Griso si misero a scassinare lo scrigno. Don Rodrigo cerò di divincolarsi, lanciando imprecazioni contro il Griso; ma poi, esaurito dagli sforzi, ricadde rifinito e stupido. I monatti lo posero su una barella e lo portarono via. La morte del Griso. – Il Griso fece un fagotto di quello che poté portar via, ma, nella furia del frugare, prese, vicino al letto, i panni del padrone e li scosse per vedere se ci fosse denaro. Il giorno dopo, mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi, gli s’abbuiarono gli occhi e cascò. Abbandonato dai compagni, andò in mano dei monatti, che, spogliatolo di quanto aveva indosso, lo gettarono su un carro, dove spirò prima di arrivare al lazzaretto. Renzo torna al suo paese. – Frattanto Renzo era rimasto nel nuovo filatoio, sotto il nome di Antonio Rivolta, cinque o sei mesi; poi, dichiarata l’inimicizia fra Venezia e il re di Spagna, e cessato quindi ogni timore di ricerche, il cugino Bortolo l’aveva ripreso con sé. Più d’una volta, specialmente dopo aver ricevuta qualcuna di quelle benedette lettere da parte di Agnese, gli era saltato il grillo di farsi soldato, ma Bortolo, con buone maniere, aveva sempre saputo smuoverlo da quella risoluzione. Altre volte voleva ritornare di nascosto al paese, travestito e con nome finto, ma Bortolo seppe anche da questo svolgerlo con buone maniere. Scoppiata la peste, anche Renzo ne fu colpito, ma la buona complessione vinse la forza del male e in pochi giorni si trovò fuori di pericolo. Sentì allora più che mai il desiderio di rivedere Lucia, e, approfittando della confusione provocata dalla peste, decise di recarsi a Milano. Si diresse però prima verso Lecco, volendo passar dal paese, dove sperava di trovare Agnese e sapere da lei qualcuna delle tante cose che si struggeva di sapere. L’incontro con Tonio e con don Abbondio. – Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque vi fosse preparato, si sentì dare come una stretta al cuore, e un turbamento ancor più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa. A un tratto vide un uomo in camicia, seduto in terra, con le spalle appoggiate a una siepe, in attitudine d’insensato. Gli parve di raffigurare quel povero mezzo scemo di Gervaso, che era venuto come testimonio alla sciagurata spedizione; ma essendoglisi avvicinato, dovette accertarsi che era invece il fratello Tonio, il quale, avendo perduto per la peste il vigore del corpo e della mente, non sapeva dir altro che «A chi tocca, la tocca», con un certo sorriso. Più oltre, vide spuntare da una colonnata e venire avanti una cosa nera, che riconobbe subito per don Abbondio. Camminava adagio adagio, appoggiato a un bastone, e, di mano in mano che si avvicinava, si poteva sempre più riconoscere nel suo volto pallido e smunto che anche lui doveva aver passato la sua burrasca. Renzo gli andò incontro, allungando il passo, e gli fece una riverenza: ché, sebbene si fossero lasciati come sapete, era sempre il suo curato. Il giovane gli chiese subito di Lucia e apprese che era a Milano; gli chiese poi di Agnese, e seppe che era andata nella Vasassina, da certi suoi parenti, a Pasturo; gli chiese infine di padre Cristoforo, ma sentì che non era più tornato da quelle parti. Don Abbondio, a sua volta, temendo che Renzo potesse dargli ancora delle noie, gli ricordò la cattura, e lo esortò a tornare da dove era venuto; poi aggiunse che aveva avuto la peste e, cominciando da Perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere che erano morte dello stesso male. Presso un amico. – Renzo, addolorato per tali notizie, si congedò dal curato, e pensò di passar quella sera presso un suo compagno d’infanzia, che, dall’enumerazione dei morti fattagli da don Abbondio, risultava scampato al contagio. Passò davanti alla sua vigna, che trovò piena di erbacce; mise piede sulla soglia di casa, ma la trovò piena di topi, di sudiciume e di ragnatele. Se ne andò via con le mani nei capelli, e arrivò, mentre gli faceva buio, alla casa dell’amico. L’amico era sull’uscio, e dapprima scambiò Renzo per Paolin dei morti, che lo tormentava sempre perché lo aiutasse a sotterrare; poi lo riconobbe e gli fece un’accoglienza festosa. Renzo apprese da lui che don Rodrigo se n’era andato con la coda tra le gambe e non s’era più veduto da quelle parti; seppe anche il casato di don Ferrante, che era per lui l’unico filo per andar in cerca di Lucia. Renzo si reca a Milano alla ricerca di Lucia. – Decise perciò di andare prima di tutto a Milano per avere notizie della sua promessa sposa, e poi di recarsi a Pasturo per riferire ad Agnese. Allo spuntar del giorno, lasciato presso l’ospite il fagottino dei suoi panni per andar più lesto, si mise in cammino. Passando per Monza comprò due pani da un fornaio, che gli porse su una pala una scodelletta, con dentro acqua e aceto, dicendogli che buttasse lì i danari, e poi, con certe molle, gli porse l’uno dopo l’altro i due pani. Verso sera fu a Greco, dove passò la notte su un fienile, poiché con osterie non si voleva impiccare. All’alba si rimise in cammino, prendendo per stella polare il duomo, e, dopo un breve tratto, venne a sbucare sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova. Renzo riesce a entrare in Milano da Porta Nuova. – Per evitare il contagio, le autorità avevano dato ordini severissimi di non lasciare entrare nessuno in Milano senza bulletta di sanità; ma Renzo aveva sentito che ci si entrava benissimo, se appena ci si sapesse un po’ aiutare e cogliere il momento. Arrivato sotto le mura, prese la diritta, alla ventura, andando, senza saperlo, verso Porta Nuova, che era nascosta alla sua vista da un baluardo. Vi giunse mentre i monatti portavano via il capo dei gabellieri, a cui poco prima s’era scoperta la peste. Renzo si fermò aspettando che il convoglio partisse poi, non venendo nessuno a richiudere il cancello, ci si avviò in fretta. Una guardia, che stava dinanzi a un casotto di legno, appoggiandosi a un moschetto con una cert’aria stracca e trascurata, gli gridò «olà!», ma egli tirò fuori un mezzo ducatone, e quello, o che avesse già avuta la peste, o che la temesse meno di quel che amava i mezzi ducatoni, gli fece cenno che glielo buttasse, sussurrando: «và innanzi presto». Renzo non se lo fece dire due volte, se non che, quando ebbe fatti forse quaranta passi, sentì un altro «olà», che un gabelliere gli gridava dietro. Questa volta fece le viste di non sentire, e, senza voltarsi nemmeno, allungò il passo, mentre quello, non essendo ubbidito, alzò le spalle, come persona a cui premesse più di non accostarsi troppo ai passeggeri che d’informarsi dei fatti loro. Un cittadino lo scambia per un untore. – Renzo prese la strada che andava diritta fino al canale detto il Naviglio, e, vedendo un cittadino che veniva verso di lui, pensò di farsi insegnare la strada che conduceva alla casa di don Ferrante. Quando fu poco distante, si levò il cappello, e, tenendolo con la sinistra, mise l’altra mano nel cocuzzolo; ma quello, stralunando gli occhi, fece un passo indietro, alzò un nodoso bastone, e voltata la punta di ferro alla vita di Renzo, gridò: «via! via! via!». Poi tirò avanti per la sua strada, tutto fremente, e, arrivato a casa, raccontò che gli si era accostato un untore, con aria umile e mansueta, e con scatolino dell’unto, o l’involtino della polvere (non era ben certo quale dei due), nel cocuzzolo del cappello. Una povera donna con una nidiata di bambini intorno. – Renzo, pensando che quello sconosciuto doveva essere un mezzo matto, proseguì il suo cammino, e, giunto nella strada di san Marco, si sentì chiamare da una povera donna, che stava sul terrazzino di una cosuccia isolata, con una nidiata di bambini intorno. Essa lo supplicò di avvertire qualche commissario che erano stati dimenticati e correvano il pericolo di morire di fame, poiché, essendo morto il marito di peste, avevano inchiodato l’uscio e nessuno era poi venuto a portar da mangiare. Renzo, commosso, tirò fuori i due pani che aveva comprato a Monza, e, fattosi calare un paniere, ve li mise dentro, pensando che era quello il modo migliore di restituire i pani che aveva trovati presso la croce di san Dionigi, nell’altra sua entrata in Milano. Poi domandò alla donna dove fosse la casa di don Ferrante, ma questa non gli seppe dare un’indicazione precisa. La macchina della tortura e il triste convoglio dei carri funebri. – Proseguendo il cammino, giunse nella pizza di san Marco, dove la prima cosa che gli diede nell’occhio fu l’abbominevole macchina della tortura, che era stata rizzata in quel luogo, e in tutte le piazze e le strade più spaziose, affinché i deputati d’ogni quartiere potessero punire nel modo più sbrigativo chiunque paresse loro meritevole di pena. Mentre guardava quello strumento, vide spuntare dalla cantonata un uomo che scuoteva un campanello, e dietro a lui un triste convoglio di carri carichi di cadaveri, guidati e scortati da monatti. Il giovane pregò per quei morti sconosciuti, mentre gli balenò per la mente l’atroce pensiero che tra quei morti potesse trovarsi Lucia. Il prete in farsetto. – Proseguendo ancora il cammino, riuscì in Borgo Nuovo, dove notò un prete in farsetto, che, ritto vicino a un uscio socchiuso, finiva di confessare qualcuno. Pensò che quello fosse l’uomo che facesse per lui, e, quando gli fu vicino, si levò il cappello e gli accennò che desiderava parlargli, fermandosi nello stesso tempo in modo da fargli intendere che non si sarebbe accostato di più. Anche quello si fermò, puntando però in terra un bastoncino davanti a sé, come per farsene un baluardo. Renzo espose la sua domanda, e il prete non solo gli disse il nome della strada dove la casa era situata, ma gli diede anche un po’ d’itinerario. Poi il giovane gli raccomandò la povera donna dimenticata. Lo spettacolo di Milano appestata. – Inoltrandosi sempre più nella città, giunse al carrobio di Porta Nuova, che, per la furia del contagio, era stato abbandonato da tutti gli abitanti; e poco oltre riuscì in un luogo che poteva dirsi città di viventi, ma quale città ancora e quali viventi! Serrati, per sospetto e per terrore, tutti gli usci di strada; altri inchiodati, per esser nelle case morta o ammalata gente di peste: altri segnati con una croce fatta col carbone, per indicare ai monatti che vi erano dei morti da portar via. Per tutto cenci, e, più ributtanti dei cenci, fascie marciose, strame ammorbato, talvolta cadaveri lasciati lì fin che passasse un carro da portarli via. Ovunque un silenzio di morte, interrotto all’alba, a mezzogiorno, a sera, da una campana del duomo, che dava il segno di recitar certe preci assegnate dall’arcivescovo. Inutili precauzioni contro la peste. – Morti a quell’ora forse i due terzi dei cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto, non si sarebbe incontrato uno, dei pochi che andavano in giro, in cui non si vedesse qualcosa di strano. Si vedevano gli uomini più ragguardevoli senza cappa né mantello, i preti senza sottana e anche i religiosi in farsetto, per timore che gli svolazzi toccassero zone infette o dessero agio agli untori. Lunghe le barbe, e lunghe e arruffate le capigliature, perché erano divenuti sospetti i barbieri, dopo che uno di loro, Giangiacomo Mora, era stato preso e condannato come un untore. I più tenevano in una mano un bastone, alcuni anche una pistola, per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo; altri portavano spugne inzuppate d’aceti medicati, che di tanto in tanto avvicinavano al naso o ce lo tenevano di continuo; altri portavano al collo una boccetta con dentro un po’ d’argento vivo, persuasi che avesse la virtù d’assorbire ogni esalazione pestilenziale. La madre di Cecilia. – Renzo aveva già fatto una buona parte del cammino, quando, in mezzo a una strada, vide quattro carri, sui quali i monatti non facevano che ammucchiar cadaveri. Egli allungò il passo, cercando di scansar quegli ingombri; quando il suo sguardo s’incontrò in una scena di singolare pietà. Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, ancor giovane e bella, ma di una bellezza velata e offuscata da una grande passione e da un languore mortale. I suoi occhi non davano lacrime, ma portavano segno di averne sparse tante. C’era nel suo dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Portava essa in collo una bambina di forse nove anni, morta; ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data in premio. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria; ma quella, tirandosi indietro, lasciò cadere una borsa nella mano del monatto, e, dato un bacio in fronte alla morticina, la volle accomodare essa stessa sul carro, dicendole le ultime parole di addio. Poi si rivolse al monatto, e lo pregò di passare verso sera per prendere anche le, e non lei sola. Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. Una moltitudine di ammalati condotti al lazzaretto. – Renzo si era appena riavuto da quella commozione straordinaria, quando gli si presentò un altro triste spettacolo. Era una moltitudine di ammalati, che venivano condotti al lazzaretto: alcuni, spinti a forza, resistevano invano, gridando che volevano morire sul loro letto; altri camminavano in silenzio, senza mostrare dolore, né alcun altro sentimento. Passata tutta la comitiva, Renzo domandò a un monatto della strada e della casa di don Ferrante, ma ebbe per risposta «In malora, tanghero»; si rivolse allora a un commissario, che veniva in coda al convoglio, ed ebbe l’indicazione desiderata. Renzo alla casa di Don Ferrante. – Renzo prese da quella parte e in breve fu alla casa di don Ferrante. Si accostò al portone, che era chiuso, mise la mano sul martello, e, dopo un momento di esitazione, diede un picchio risoluto. Una donna, affacciatasi alla finestra, gli disse che Lucia si trovava al lazzaretto con la peste, e, a più precise richieste, gli chiuse la finestra in faccia. E’ preso un’altra volta per un untore. – Il giovane, afflitto per quella notizia, e arrabbiato per la maniera con cui era stato accolto, afferrò allora il martello per picchiar di nuovo alla disperata; ma una vecchia, distante da lui forse un venti passi, lo prese per un untore e cominciò a gridare: «L’untore! dagli! dagli! dagli all’untore!». Allo strillar della vecchia, accorse gente di qua e di là; e anche la donna sgarbata di prima, riaffacciatasi alla finestra, si mise a gridare: «Pigliatelo, pigliatelo; che dev’essere uno di que’ birboni che vanno in giro a unger le porte de’ galantuomini». Si salva saltando su un carro funebre. – Renzo non istette lì a pensare: si aprì la strada a urtoni e punzoni, e via di galoppo col pugno in aria, pronto per qualunque gli fosse venuto tra i piedi. La strada avanti era libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio e, più forti del calpestio, quelle grida amare: «Dagli! dagli! all’untore!». Si fermò allora sui due piedi, mise mano al suo coltellaccio, e col braccio teso gridò: «Chi ha cuore, venga avanti, canaglia! che l’ungerò io davvero con questo». Ma, con meraviglia, vide che i persecutori si erano già fermati, e, pur seguitando ad urlare, facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati e gente che veniva dall’altro capo della strada, e che avrebbe anch’essa voluto dare addosso all’untore, ma era impedita da un convoglio di carri funebri, che si avanzava. Renzo, vistosi tra due fuochi, pensò che ciò che era di terrore a coloro, poteva essere a lui di salvezza, e, rimesso il coltellaccio nel fodero, prese la rincorsa verso i cari, passò il primo, e, adocchiato nel secondo un buon spazio vuoto, spiccò un salto su di esso, tra le esclamazioni di «bravo! bravo!» dei monatti. Gli inseguitori, all’avvicinarsi del convoglio, voltarono le spalle; ma poiché qualcuno si ritirava più adagio, facendo versacci e gesti di minaccia, uno dei monatti, strappato da un cadavere un laido cencio, fece l’atto di scagliarlo, provocando una foga generale. Poi i compagni, passandosi un gran fiasco di mano in mano, fecero un brindisi alla morìa e intonarono una canzonaccia. Giunge al lazzaretto. – Renzo, frattanto, stava all’erta per liberarsi dei suoi liberatori. Tutt’a un tratto riconobbe il corso di Porta Orientale, che, come ricordava dalla sua prima venuta a Milano, portava diritto al lazzaretto. In quel punto venne incontro ai carri un commissario, che gridò ai monatti di fermare, iniziando un diverbio rumoroso. Renzo, approfittando della fermata, si buttò giù dal carro, ringraziando i monatti, mentre uno di essi gli diceva: «Và, và, povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano». Il giovane si trovò in breve dinanzi al lazzaretto, che già all’esterno brulicava di ammalati: un meschino, seduto tranquillamente in fondo al fossato, cantava una canzone contadinesca d’amore gaio e scherzevole; un frenetico, balzato in groppa a un cavallaccio non guardato, passò di gran carriera, inseguito da monatti urlanti. Così, già sbalordito e stanco di veder miserie, il giovane arrivò alla porta di quel luogo, dove ce n’erano adunate forse più che non ne fossero sparse in tutto lo spazio che gli era toccato di percorrere. Renzo al lazzaretto. – Il lazzaretto era un recinto popolato da sedicimila appestati e pieno di capanne, di baracche, di carri, di gente, Renzo, dalla porta dove s’era fermato, fino alla cappella del mezzo, vide un viale sgombro di capanne, e in quello un tramenìo di carri, un portar via roba per far luogo; e cappuccini e secolari che dirigevano quell’operazione, e insieme mandavano via chi non ci avesse che fare. Il giovane, temendo d’esser anche lui messo fuori in quella maniera, si cacciò tra le capanne, facendo capolino in ognuna, se mai gli venisse fatto di trovare Lucia, ma, non vedendo nessuna donna, s’immaginò che le donne dovessero essere in un luogo separato, e si dispose a cercarlo. L’aria e il cielo accrescono l’orrore del luogo. – L’aria e il cielo accrescevano, se qualche cosa poteva accrescerlo, l’orrore del luogo. La nebbia s’era a poco a poco addensata e accavallata in nuvolosi, tra i quali la sfera del sole spargeva un barlume fioco e sfumato. Ogni tanto si sentiva un borbottar di tuoni profondo, come tronco e irresoluto. Nelle campagne d’intorno non si vedeva muoversi un ramo d’albero, né uccello andarvisi a posare o staccarsene. Era uno di quei tempi forieri della burrasca, in cui la natura, come immota al di fuori, e agitata da un travaglio interno, par che opprima ogni vivente. L’uomo, già alle prese col male, soccombeva alla nuova oppressione; si vedevano centinaia e centinaia peggiorar precipitosamente; né forse su quel luogo di miserie era ancora passata un’ora crudele al par di questa. Bimbi, balie e capre. – Già aveva il giovane girato un bel pezzo, e senza frutto, quando arrivò a un assito scheggiato e sconnesso, dal quale veniva un misto singolare di vagiti e di belati. Mise l’occhio a un largo spiraglio, e vide un recinto di capanne sparse, e dentro ad esse bambinelli che giacevano sopra materassini o guanciali, e balie e altre donne in faccende, e, ciò che più di tutto attraeva lo sguardo, capre mescolate con quelle e fatte loro aiutanti. Era una cosa singolare vedere alcune di quelle bestie, ritte e quiete sopra questo o quel bambino, dargli la poppa; e qualche altra accorrere a un vagito, come con senso materno, e fermarsi presso il piccolo allievo, e procurar d’accomodarcisi sopra, e belare e dimenarsi, quasi chiamando chi venisse in aiuto a tutt’e due. Qua e là erano sedute balie con bambini al petto; alcune in tal atto d’amore, da far nascere il dubbio se fossero state attirate in quel luogo dalla paga o dalla carità. Renzo incontra padre Cristoforo. – Mentre Renzo guardava innanzi per studiare la strada, vide, a un cento passi di distanza, un cappuccino che aveva tutto l’andare, tutto il fare, tutta la forma di padre Cristoforo. Corse verso quella parte, e lo rivide che, scostandosi da una caldaia, andava con una scodella in mano, verso una capanna; poi lo vide sedersi sull’uscio di quella, fare un segno di croce sulla scodella che teneva dinanzi, e mettersi a mangiare. Era proprio il padre Cristoforo, che da Rimini, scoppiata la peste, aveva richiesto di venire a Milano per assistere e servire gli appestati. Il conte zio era morto; e del resto c’era più bisogno di infermieri che di politici, cosicché fu esaudito senza difficoltà. Ma la consolazione di Renzo nel ritrovare il suo buon frate fu amareggiata dal vederlo tanto mutato. Il portamento curvo e stentato; il viso scarno e smorto; in tutto si vedeva una natura esausta, una carne rotta e cadente, che si aiutava e si sorreggeva, ogni momento, con uno sforzo d’animo. Soltanto l’occhio era quello di prima, come se la carità, esultante di sentirsi vicina al suo principio, ci rimettesse un fuoco più ardente e più puro di e quello che l’infermità andava a poco a poco spegnendo. Renzo si fece riconoscere e fu accolto con molto affetto. Il frate pregò un giovane cappuccino, padre Vittore, di sostituirlo per qualche istante; offrì a Renzo una scodella di minestra e un bicchiere di vino; poi riprese la sua scodella e si pose a sedere accanto a lui. Renzo, tra una cucchiaiata e l’altra, si mise a raccontare la storia di Lucia, poi la propria, ed espose il motivo che lo aveva sospinto in quel luogo. Il buon padre, a sua volta, gli indicò il reparto che era destinato alle donne, ma, poiché era proibito di entrare agli uomini che non vi avessero qualche incombenza, consigliò al giovane di recarsi prima alla chiesa, che sorgeva nel centro dell’edificio, dove il padre Felice, che era il presidente del lazzaretto, avrebbe radunato tra poco i pochi guariti per uscire in processione. Se non avesse tra essi trovato Lucia, avrebbe potuto recarsi in quel reparto, dichiarando, se qualcuno gli avesse fatto ostacolo, che padre Cristoforo lo conosceva e avrebbe reso conto per lui. Gli raccomandò infine fiducia e….. rassegnazione, poiché non era poco quello che egli era venuto a cercare: una persona viva al lazzaretto. Renzo vuol farsi giustizia da sé. – Renzo, a quest’ultime parole, si cambiò in viso, e, stravolgendo gli occhi per la rabbia, dichiarò che, se non avesse trovato Lucia, avrebbe trovato anche a casa del diavolo quel furfante che li aveva separati, e l’avrebbe fatta lui giustizia. Padre Cristoforo, udendo queste parole di odio e di vendetta, lo rimproverò aspramente, e, mentre con una mano gli stringeva e scuoteva forte il braccio, gli additava con l’altra la dolorosa scena all’intorno, che esprimeva la terribile potenza di Dio, che solo può castigare o perdonare. Poi respinse il giovane, movendo verso una capanna d’infermi. Renzo allora, subitamente pentito, dichiarò di aver parlato da bestia e non da cristiano, e di perdonare di cuore. Renzo dinanzi a don Rodrigo morente. – Padre Cristoforo, accertatosi che quel pentimento era proprio sincero, afferrò la mano del giovane e lo condusse entro una capanna, che sorgeva lì presso. Renzo, tra gli altri infermi, ne vide uno su una materassa, con una cappa signorile indosso, a guisa di coperta, e riconobbe don Rodrigo. Stava l’infelice immoto; spalancati gli occhi, ma senza sguardo; pallido il viso e sparso di macchie nere; nere ed enfiate le labbra: si sarebbe detto il viso di un cadavere, se una contrazione violenta non avesse reso testimonio d’una vita tenace. Il frate, dopo aver dichiarato, con voce bassa e grave, che l’agonia di don Rodrigo poteva essere un castigo o una misericordia di Dio, esortò Renzo a pregare per quell’infelice, e, giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò. Renzo fece lo stesso. I due si separarono: uno tornò donde era venuto, l’altro si avviò alla cappella, che non era lontana più d’un cento passi. Renzo assiste alla predica di padre Felice. – Renzo s’avviò verso la cappella del lazzaretto, che sorgeva al centro di esso, e che era aperta da tutti i lati, in modo che l’altare, eretto nel centro, poteva essere veduto da ogni punto del campo. Egli vide il padre Felice, che aveva cominciato la predica, e dinanzi a lui un folto, quasi un selciato di teste. Nel mezzo ce n’era un certo numero coperto di fazzoletti o di veli; ma, per quanto ficcasse in quella parte più attentamente lo sguardo, non arrivò a scoprire Lucia. Alzò allora anch’egli gli occhi, dove tutti tenevano fissi i loro, ed ascoltò commosso il solenne sermone del padre, che esortava i suoi uditori a ringraziare il Signore, a far buon uso della vita così miracolosamente serbata, a non abbandonarsi a una gioia rumorosa, a iniziare subito un’esistenza tutta di carità. Infine il mirabile frate, dopo aver chiesto umilmente perdono, per sé e per i suoi compagni, se non avevano degnamente adempiuto al gran ministero d’amore, benedisse la folla, prese una gran croce e s’avviò per mettersi alla testa della processione. Renzo, postosi di fianco a una capanna, stette a guardare la sfilata; ma, per quanto osservasse attentamente il gruppo delle donne, non trovò Lucia. Svanita quella cara speranza, non ci poteva ormai esser di meglio che trovare Lucia ammalata. Il poverino si attaccò con tutte le forze dell’animo a quel tristo e debole filo, andò a inginocchiarsi sull’ultimo scalino della cappella, e fece a Dio una preghiera, o, per dir meglio, una confusione di parole arruffate, di frasi interrotte, d’esclamazioni, d’istanze, di lamenti, di promesse. S’alzò quindi più rincuorato ed entrò nel quartiere delle donne. Renzo entra nel quartiere delle donne: il campanello. – Quasi al primo passo che fece, vide in terra un campanello, di quelli che i monatti portavano a un piede, e, pensando che un tale strumento avrebbe potuto servirgli come di passaporto là dentro, lo prese e se lo legò come usavano quelli. Aveva già fatta molta strada senza frutto e senza accidenti, quando un commissario, avendolo scambiato per un monatto, gli gridò di andare ad aiutare in certe stanze; ma Renzo, dopo aver fatto replicatamene e in fretta un cenno del capo, come per dire che aveva inteso si levò dalla sua vista, cacciandosi tra le capanne. Renzo trova Lucia, ma ne è respinto. – Si chinò per levarsi il campanello, ma mentre stava col capo appoggiato alla parete di paglia d’una delle capanne, gli venne da quella all’orecchio una voce…… quella di Lucia! In tre salti girò la capanna, fu sull’uscio, e vide Lucia chinata sopra un lettuccio. Dopo le prime rotte esclamazioni di Renzo, e le parole di sorpresa di Lucia, che ricordò il voto fatto alla Vergine, Renzo le disse apertamente che egli non credeva alla legittimità del voto, perché la Madonna non poteva voler promesse in danno del prossimo, e perché esso poteva benissimo essere sostituito con la promessa di metter nome Maria alla prima figlia che sarebbe nata dal loro matrimonio. Ma Lucia, per quanto sentisse di amare ancora quel giovane, si scostò impetuosamente da lui, tornando verso il lettuccio, in cui si trovava ammalata una brava donna. Renzo, vedendo che essa tentava di sfuggirgli, le parlò allora di padre Cristoforo, che aveva incontrato al lazzaretto e che aveva trovato così malandato in salute; le descrisse la visita fatta a don Rodrigo e le comunicò l’esortazione del frate affinché pregassero insieme («Insieme! avete inteso?») per l’anima di quel meschino; e aggiunse che questi non sarebbe stato bene nel mondo di là, se di qua non si fosse accomodata la cosa, se non si fosse disfatto il male che egli aveva fatto. Ma Lucia lo esortò nuovamente a dimenticarla, a recarsi dal padre Cristoforo, perché gli mettesse il cuore in pace. Renzo, dopo aver esclamato che il cuore in pace non l’avrebbe messo mai, e che sarebbe tornato anche se si fosse trovato in capo al mondo, si allontanò dalla capanna; mentre Lucia andò a sedersi accanto all’inferma, piangendo dirottamente. La mercantessa. – La donna che stava nel lettuccio era un’agiata mercantessa, di forse trent’anni, che nello spazio di pochi giorni si era vista morire in casa il marito e tutti i figliuoli, e che di lì a poco, venuta la peste anche a lei, era stata trasportata al lazzaretto e messa in quella capannuccia, nel tempo che Lucia, dopo aver superato la furia del male, cominciava a riaversi. Essa era stata perciò amorosamente assistita e aiutata da Lucia, in modo che le due donne erano in poco tempo divenute intrinseche ed avevano stabilito di vivere insieme. Renzo torna da padre Cristoforo. – Renzo intanto trottava verso il quartiere del buon frate. Lo trovò in una capanna che, piegato a terra, stava confortando un moribondo. Il giovane gli disse di aver trovato Lucia e lo mise al corrente dell’imbroglio del voto; e il frate, dopo essersi fatto nuovamente sostituire da padre Vittore, si fece accompagnare alla capanna di Lucia. Essa, appena vide il suo antico confessore, gli corse incontro, non nascondendo la sua meraviglia di trovarlo in pessime condizioni di salute. Padre Cristoforo scioglie Lucia dal voto. – Padre Cristoforo, tratta Lucia in un canto, la interrogò sul voto, osservando che essa non avrebbe potuto offrire la volontà di un altro, al quale si era già obbligata, e che, se non ci fosse stato un altro motivo per mantenere la promessa, egli avrebbe potuto scioglierla da ogni obbligazione che avesse potuto contrarre. Lucia allora, con un volto non turbato più che di pudore, chiese di essere sciolta dal voto, e il padre Cristoforo la esaudì all’istante. Poi il buon frate, dopo aver esortato i due giovani a ringraziare il cielo, che li aveva condotti in quello stato, non per mezzo delle allegrezze turbolente e passeggere, ma coi travagli e tra le miserie, per disporli a un’allegrezza raccolta e tranquilla, diede a Lucia una scatoletta di legno, che conteneva il resto di quel pane che aveva chiesto per carità alla famiglia dell’ucciso, raccomandando ad entrambi di serbarlo e di farlo vedere ai figli che sarebbero nati da loro, affinché perdonassero sempre e pregassero per lui. Fu infine lieto di apprendere che la mercantessa, uscendo dal lazzaretto, avrebbe presa con sé Lucia, e avrebbe pensato lei ad accompagnarla dalla madre e a prepararle il corredo per le prossime nozze. Il congedo di padre Cristoforo. – Padre Cristoforo si congedò quindi da Lucia, che non sapeva rassegnarsi all’idea di doversi staccare per sempre da lui, e uscì con Renzo dalla capanna. Il frate offrì al giovane di ospitarlo per quella notte presso di sé, ma questi, che voleva andare il più presto possibile in cerca di Agnese, rifiutò cortesemente l’offerta. Il padre Cristoforo lo benedisse, e poiché il giovane gli domandò, con animo angosciato quando si sarebbero rivisti, rispose serenamente «Lassù, spero», e si staccò da lui, che stette lì a guardarlo finché non l’ebbe perso di vista. La pioggia purificatrice. – Appena Renzo ebbe varcata la soglia del lazzaretto, cominciò una grandine di goccioloni radi e impetuosi, che preso si tramutò in una pioggia dirotta. Renzo, invece di inquietarsene, ci guazzava dentro allegramente, sentendo quasi in quel risolvimento della natura quel che s’era fatto nel suo destino; e ancor più se ne sarebbe rallegrato, se avesse potuto prevedere che quell’acqua avrebbe portato via, come di fatto avvenne, il contagio. Renzo verso il suo paese sotto la pioggia. – Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né come, né quando si sarebbe fermato, col solo pensiero di arrivar presto al suo paese e di rimettersi poi in cammino per Pasturo, in cerca di Agnese. Mentre andava, veniva sempre a galla un pensiero: l’ho trovata; è guarita; è mia! E allora faceva uno sgambetto o si fregava le mani. Arrivò a Sesto, sulla sera, ma non si fermò; e poiché la sola cosa che l’incomodasse era un grande appetito, comprò due pani da un fornaio, e avanti. Quando passò per Monza era notte fatta; e benché la strada, affondata tra due rive, si fosse quasi trasformata in un letto di fiume, continuò ad andar sempre, finché sull’alba si trovò alla riva dell’Adda. Vide all’intorno i suoi monti, il Resegone vicino, il territorio di Lecco, e quel che sentì a quella vista non si potrebbe spiegare. Giunse a Pescate, costeggiò quell’ultimo tratto dell’Adda, dando però un’occhiata malinconica a Pescarenico; passò il ponte, e, attraverso strade e campi, arrivò alla casa dell’ospite amico. A casa dell’ospite amico. – L’amico, che s’era levato allora allora, e stava sull’uscio a guardare il tempo, fu sorpreso di vedere quella figura così infangata, ma così viva e disinvolta; e fu lieto di apprendere che Lucia era stata trovata e che era guarita. Poi accese una bella fiammata, mentre Renzo toglieva i panni, fradici di pioggia, e si rivestiva con quelli che aveva lasciati nel fagottino, quando si era recato a Milano; preparò una buona polenta, mentre Renzo incominciava a raccontare le gran cose che aveva viste a Milano; e, poiché tutto quel giorno continuò a piovigginare, stette sempre accanto all’amico, attendendo a certi lavoracci in preparazione della vendemmia. Renzo non poté però tenersi di fare una scappatine alla casa di Agnese, per rivedere una certa finestra, e per darsi anche lì una fregatina di mani. A Pasturo, dove trova Agnese. – Il mattino seguente s’alzò prima che facesse giorno, e, vedendo cessata l’acqua, si mise in cammino per Pasturo. Era ancor presto quando ci arrivò. Cercò di Agnese, sentì che stava bene, e gli fu indicata una cosuccia isolata. Ci andò la chiamò dalla strada, essa s’affacciò di corsa alla finestra, e, prima che potesse aprir bocca, il giovane le gridò che Lucia era guarita e che presto sarebbe venuta. Renzo, per timore del contagio, non volle che Agnese lo accogliesse in casa, e perciò entrambi si recarono in un orto che era dietro la casa, dove erano due panche, una di fronte all’altra. Il lettore, informato com’è delle cose antecedenti, può indovinare da sé la loro conversazione. La conclusione fu che si sarebbe messa su casa tutti insieme in quel paese del bergamasco, dove Renzo aveva già un buon avviamento; appena cessato il pericolo, Agnese tornerebbe a casa, ad aspettarvi Lucia, o Lucia ve l’aspetterebbe; intanto Renzo farebbe qualche altra corsa a Pasturo per tenere informata Agnese di quel che potesse accadere. Nel paese adottivo. – Renzo tornò poi al paese, passò la notte in casa dell’amico, e il giorno dopo si mise nuovamente in viaggio verso il paese adottivo. Trovò Bortolo in buona salute e la peste quasi scomparsa; gli promise di rimettersi al lavoro quando si sarebbe stabilito con Lucia nel paese; e intanto prese in affitto una casa più grande, e la fornì di mobili e di attrezzi, intaccando questa volta il tesoro, ma senza farci un gran buco, perché tutto era a buon mercato, essendoci molta più roba che gente che la comprasse. Ancora nel paese nativo, insieme ad Agnese. – Dopo alquanti giorni ritornò al paese nativo, e poi subito trottò a Pasturo per riportare Agnese a casa. La buona donna, lieta di trovare ogni cosa come l’aveva lasciata, si preoccupò di preparare alla mercantessa e a Lucia l’alloggio il più decente che potesse; mentre Renzo, dal canto suo, parte aiutava il suo ospite nei lavori di campagna, parte coltivata, anzi dissodava l’orticello di Agnese, del tutto trasandato nell’assenza di lei. In quanto al suo podere, non se ne occupava punto, dicendo che era una parrucca troppo arruffata, e già aveva preso il partito di disfarsi di ogni cosa, e di impiegare nella nuova patria quel tanto che ne potrebbe ricavare. Lucia e la mercantessa escono dal lazzaretto. – Qualche girono dopo la visita di Renzo al lazzaretto, Lucia ne uscì con la buona vedova; fece la quarantina nella casa di lei, attendendo ad allestire il suo corredo; e, terminata la quarantina, si fecero i preparativi per il viaggio. In questo tempo, essendo caduto il discorso sulla signora di Monza, Lucia apprese dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto di atrocissimi fatti, era stata, per ordine del cardinale, trasportata in un monastero di Milano, dove si era ravveduta e aveva iniziato una vita di severa espiazione. Apprese anche, dai cappuccini del lazzaretto, che padre Cristoforo era morto di peste; e infine che donna Prassede e don Ferrante erano stati anch’essi portati via dal contagio. Il destino di don Ferrante. – Anzi per don Ferrante, che era stato un dotto, l’anonimo ha creduto bene di dare qualche particolare. Egli dice che, al primo parlar che si fece di peste, quel brav’uomo fu uno dei più risoluti a negarla, sostenendo la sua opinione con ragionamenti, ai quali non mancava la concatenazione. Diceva che in natura non vi possono essere che sostanze o accidenti. Ma la peste non poteva essere sostanza, perché le sostanze sono quattro: aerea, acquea, ignea e terrea; e la peste non è sostanza aerea, perché, se fosse tale, invece di passare da un corpo all’altro, volerebbe alla sua sfera; non è sostanza acquea, perché bagnerebbe e verrebbe asciugata dai venti; non è sostanza ignea, perché brucerebbe; non è sostanza terrea, perché sarebbe visibile. D’altra parte la peste non può essere accidente, perché un accidente non può passare da un soggetto all’altro. La vera cagione della peste si doveva invece cercare in una maligna congiunzione di Saturno con Giove, contro la quale non c’era rimedio alcuno. His fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese alcuna precauzione contro la peste, ed andò a letto a morire, come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle. Lucia ritorna al paese. – Una sera, Agnese sentì fermarsi un legno all’uscio. Era Lucia, con la buona vedova, che ritornava al paese, e il lettore può facilmente immaginare le vicendevoli accoglienze. Il mattino seguente capitò anche Renzo, che non sapeva nulla, e anche qui è facile immaginare la gioia del giovane. Unica nota triste fu l’annuncio della morte di padre Cristoforo, morte che non era nota né ad Agnese, né a Renzo. Renzo si reca da don Abbondio, che si rifiuta nuovamente di celebrare le nozze. – Renzo, dopo essersi intrattenuto con le donne, si recò da don Abbondio, a prendere gli accordi per la celebrazione delle nozze. Don Abbondio non disse di no, ma cominciò a tentennare, a trovare altre scuse, insinuando che non era prudente mettersi in piazza con quella cattura addosso, e la cosa poteva farsi ugualmente dove sarebbero andati a stabilirsi. Renzo, comprendendo che don Abbondio aveva sempre il timore di don Rodrigo, lo rassicurò che aveva visto costui in condizioni disperate, ma il curato gli rispose che fin che c’è fiato c’è speranza. Dopo qualche altra botta e risposta, né più né meno concludenti, Renzo, per non perdere la pazienza e per non mancargli di rispetto, strisciò una bella riverenza e se ne tornò alla sua compagnia. Le donne rinnovano il tentativo, ma inutilmente. – Le donne, su proposta della vedova, decisero allora di fare esse un’altra prova, per vedere se ad esse riuscisse meglio. Dopo aver desinato, mentre Renzo se n’andò senza dir dove, esse mossero all’assalto del curato. Don Abbondio, intuendo il motivo della visita, fece faccia tosta: gran congratulazioni a Lucia, saluti ad Agnese, complimenti alla forestiera, tirando le cose in lungo. Finalmente, quando una d’esse ruppe il ghiaccio, venne di nuovo fuori col pretesto della cattura, ripetendo le stesse cose che aveva già dette a Renzo. Renzo annuncia l’arrivo del marchese, erede di don Rodrigo. – Mentre ferveva la discussione, entrò Renzo, con passo risoluto, annunciando che era arrivato il signor marchese, erede di don Rodrigo, e bravo signore davvero. Don Abbondio non depose per questo i suoi dubbi («Ma che sia proprio vero….?»); e solo quando Ambrogio, il sagrestano, confermò la cosa in tutto e per tutto, tirò un gran respiro, ringraziò la provvidenza, che arrivava alla fine certa gente; benedisse la peste, che era stata un gran flagello, ma anche una scopa per spazzar via i cattivi soggetti; si rallegrò di esser vivo, mentre quello non avrebbe più ormai mandato certe ambasciate ai galantuomini. Dichiarò poi che era disposto a fare gli annunzi in chiesa per la prossima domenica, e voleva darne parte subito a Sua Eminenza (e lì a spiegare come il papa avesse ordinato di dare ai cardinali dell’eminenza e non più dell’illustrissimo), e che voleva chiedere dispensa dalle altre due pubblicazioni matrimoniali per fare più in fretta. Si mise poi a scherzare sul gran numero di matrimoni che si celebravano in quei tempi, dicendo che Perpetua aveva fatto uno sproposito a morire, poiché era il momento che avrebbe trovato l’avventore anche lei; domandò alla vedova se anche a lei non avessero principiato a ronzare intorno dei mosconi; e aggiunse che anche Agnese avrebbe potuto trovare da rimaritarsi. Insomma quella notizia gli aveva dato una disinvoltura, una parlantina insolita da gran tempo, tanto che più di una volta ritenne la compagnia che voleva andarsene, e la fermò poi ancora un pochino sull’uscio di strada, sempre a parlar di bubbole. Il marchese acquista la casetta di Agnese e quella di Renzo. – Il giorno seguente il marchese, di cui s’era parlato, si recò a far visita a don Abbondio, gli portò i saluti del cardinale arcivescovo, e gli disse che, avendogli questi parlato di due fidanzati, che avevano sofferto per causa di don Rodrigo, desiderava far loro del bene. Don Abbondio gli propose di acquistare le case di quei poverini, che volevano trasferirsi altrove, e che avrebbero certo dovuto dare quella roba a qualche furbo per un pezzo di pane. Il marchese lodò molto il suggerimento, e pregò il curato di essere arbitro del prezzo e di fissarlo alto bene, proponendo di andar subito insieme a casa della sposa. Per la strada don Abbondio, tutto gongolante, ne pensò un’altra. Pregò il marchese di interessarsi perché a Renzo fosse tolta di dosso la cattura; e il marchese, sentito che non c’erano impegni forti contro il giovane, promise di interessarsi. A casa di Lucia trovarono le tre donne e Renzo, che, come rimanessero, si può facilmente immaginare. Il marchese stesso avviò la conversazione, e, venuto alla proposta dell’acquisto, pregò nuovamente don Abbondio di fissare il prezzo. Questi proferì, a parer suo, uno sproposito; ma il compratore, come se avesse frainteso, ripeté il doppio, non volle sentir rettificazioni, e concluse ogni discorso invitando la compagnia a desinare, per il giorno dopo le nozze, al suo palazzo, dove si farebbe l’istrumento in regola. Renzo e Lucia sposi per bocca di don Abbondio. – Venne la dispensa, venne l’assolutoria, venne quel benedetto giorno: i due promessi andarono, con sicurezza trionfale, proprio a quella chiesa, dove, proprio per bocca di don Abbondio, furono sposi. Un altro trionfo fu l’andare a quel palazzotto, dove il marchese fece loro gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e la mercantessa; e prima di ritirarsi a pranzare altrove con don Abbondio, volle star lì un poco a far compagnia agli invitati; e aiutò anche a servirli. Dopo il pranzo, fu steso il contratto per mano di un dottore, che non fu l’Azzecca-garbugli, morto anch’egli di peste. Gli sposi nel nuovo paese. – Non si pensò ormai più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio. Tenero fu il distacco dalla vedova, e tenero anche quello da don Abbondio, perché quelle buone creature avevano sempre conservato un certo attaccamento rispettoso per il loro curato, e questo, in fondo, aveva sempre voluto bene a loro. Sono quei benedetti affari, che imbrogliano gli affetti. Purtroppo, arrivati nel nuovo paese, Renzo ci trovò dei disgusti bell’e preparati. Tutti, avendo sentito parlare della giovane sposa e delle vicende di Renzo, credevano di veder arrivare un miracolo di bellezza; ma quando l’ebbero vista, cominciarono a dire che non c’era nulla di straordinario e che era una contadina come tante altre. Ci furono perfino di quelli che la trovarono brutta. Renzo, venuto a conoscenza di queste critiche, ne fu tocco sul viso, e cominciò ad essere sgarbato con tutti. Renzo acquista un filatoio alle porte di Bergamo. – Ma una buona occasione accomodò ogni cosa. La peste aveva portato via il padrone di un filatoio, quasi alle porte di Bergamo; e l’erede, giovane scapestrato, aveva deciso di venderlo, anche a metà presso. Bortolo, venuto a conoscenza di ciò, ne contrattò l’acquisto, ma, non avendo i denari sufficienti, propose a Renzo di fare l’affare a mezzo. Il giovane fu ben lieto di accettare e si trasferì con Lucia nella nuova località. Qui, non essendo Lucia aspettata, non andò soggetta a critiche, e anzi più d’uno ebbe a dire: «Avete veduto quella bella baggiana che c’è venuta?». Vita agiata e tranquilla degli sposi. – Non si creda però che non ci fosse qualche fastidiuccio anche lì, perché l’uomo, finché sia in questo mondo, è un infermo che si trova in un letto più o meno scomodo, e che, vedendo attorno a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, si figura che ci si deve star benone; ma poi, se gli riesce di cambiare, si trova a un dipresso nelle condizioni di prima. Gli affari tuttavia andarono d’incanto. Prima che finisse l’anno del matrimonio, venne alla luce una bella bambina, a cui fu posto il nome di Maria. Ne vennero poi col tempo non so quanti altri, dell’uno e dell’altro sesso. Agnese era tutta affaccendata a portarli in qua e là, chiamandoli cattivacci, e stampando loro in viso certi bacioni, che vi lasciavano il bianco per qualche tempo. Renzo, dal canto suo, volle che tutti imparassero a leggere e scrivere, dicendo che, giacché vi era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro. Renzo racconta le cose che ha imparato nelle sue avventure. – Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure, e finiva sempre col dire le gran cose che aveva imparate, per governarsi meglio nella vita: a non mettersi nei tumulti, a non predicare in piazza, a non alzar troppo il gomito, a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è intorno gente che ha la testa calda, a non attaccarsi un campanello al piede prima d’aver pensato quel che ne possa nascere. Lucia però, a forza di sentir ripetere la stessa canzone, disse un giorno al suo moralista: «E io, cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai, sono loro che sono venuti a cercare me». Il sugo di tutta la storia. – Renzo alla prima rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, sembrò al Manzoni così giusta che la volle porre alla fine del romanzo, come il sugo di tutta la storia. |
|
| Le divisioni utilizzate sono quelle dei riassunti Bignami
Scritto con la partecipazione eccezionale di Mariantonietta |
|