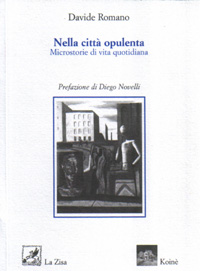[formazione]
[esperienze di lavoro] [pubblicazioni]
[e inoltre...] [links] [contatti] [home]
|
Prefazione di Diego Novelli
|
nella città
opulenta microstorie di vita quotidiana
Diego Novelli
Sono trascorsi oltre trent’anni da un mio lungo soggiorno in Sicilia, inviato dal mio giornale, l’Unità, per una inchiesta “di largo respiro” – così mi aveva detto il direttore al momento della partenza – nell’isola dei limoni. Al rientro a Torino, dopo avere inviato ben quaranta servizi nell’arco di tre mesi, pensai di raccogliere sotto forma di diario quell’esaltante esperienza che mi aveva visto girovagare tra le grandi città capoluogo, così come nei piccoli centri contadini, nel cuore dell’isola dove la povertà mi era apparsa più nera della pece. Nell’aprile del 1971 così iniziavo il mio diario: « L’impatto con la realtà siciliana è stato piuttosto brusco. Il quadro della situazione, così come si presenta agli occhi del continentale “sbarcato” con l’intenzione di conoscerla, è drammatico, al limite traumatizzante. Da qualsiasi parte mi rigiri ho la sensazione di sprofondare in una sorta di palude senza fondo. Mi rendo conto subito di avere di fronte una società sfilacciata sino allo sgretolamento, una società diretta da gruppi di potere che ciecamente perseguono i loro egoistici obiettivi sulla pelle di centinaia di migliaia di poveri cristi; una società in cui i valori dell’uomo, della personalità, dell’individuo, della dignità dell’essere sono stati, con caparbio cinismo, sacrificati sull’altare del profitto, della speculazione senza alcun tentennamento, senza esitazioni o ripensamenti, sino a ricorrere all’uso della più brutale violenza attraverso l’intimidazione, la paura, il terrore e, se necessario, alla lupara o alle raffiche di mitra». Mi scuso di questa lunga autocitazione, ma dopo la lettura delle pagine di Davide Romano sono rimasto profondamente colpito non solo dalla drammaticità di queste microstorie di vita quotidiana che lui, con tanta sensibilità, ha raccolto, ma soprattutto dalle analogie con le storie con cui mi ero incontrato trent’anni prima, quasi che il tempo nella realtà siciliana non esista, si sia fermato. Davide Romano è un giornalista nato nell’anno in cui io mi avventuravo nell’isola per raccogliere le informazioni che dovevo trasmettere ai miei lettori. Sconvolgente è il fatto che le storie di oggi potrebbero essere datate trent’anni prima, oppure le mie note di diario postdatate di trent’anni. Davide non è un giornalista che cerca il sensazionale, oppure il “colore”, tantomeno abusa dell’aggettivazione. Del nostro mestiere preferisce la cronaca, i fatti, la realtà: è un cronista nel senso più completo del significato di questo termine. Come tutti i cronisti di razza è un curioso, non un pettegolo: gli piace conoscere, approfondire, scavare, mai pago di quanto ha appreso. Le sue microstorie non possono essere considerate dei casi limite, quindi, se non trascurabili, sicuramente di scarso peso nella realtà viva di una società vista nel suo insieme. Da tempo le ideologie oscillano tra una valutazione della società nella quale viene, per così dire, negata la possibilità di sommare gli individui in modo da ottenere un totale, e una visione del totale nella quale gli individui tendono in un certo senso a sparire e ad essere cancellati dalla somma, quasi che una somma di zero fosse ancora un numero e non una semplice e vuota espressione aritmetica. E per poter fare la somma occorre che le singole cifre vengano considerate e trattate come unità. Né d’altra parte queste unità, cioè gli individui, esistono nel vuoto e possono conservare la loro identità e la loro autonomia in cieca opposizione al principio della loro articolazione in grandezze via via maggiori. L’osservazione potrebbe essere ovvia se non avessimo tutti la sensazione di quanto oggi sia turbato il rapporto tra l’individuo e la società, tra il particolare e il generale; turbato nella vita quotidiana, nel comportamento e, direi, soprattutto nella cultura. Non so, anzi non mi sento di esprimere un giudizio sulla specificità di Palermo da questo punto di vista del rapporto tra l’individuo e la società. Anche se Palermo vive le contraddizioni, le mode, i gusti, i drammi che vivono città come Roma, Milano, Torino, Parigi, Londra. Il dramma di un disoccupato che vuole buttarsi dal cornicione di un palazzo è lo stesso in qualsiasi parte del mondo. Diverso, forse, è il contesto. Diverse – ci fa capire l’autore di questo volumetto – sono le reazioni delle persone. E ce le fa capire lasciando parlare gli uomini e le donne di questa sua amata e odiata città, dando voce ai più deboli, schierandosi dalla loro parte, dalla parte degli ultimi, nella speranza di poter concorrere a riparare ad una cronica ingiustizia, quella della città opulenta verso i suoi fratelli meno fortunati. Diego Novelli Torino, 21 luglio 2003 Sono un cronista d’asfalto. Credo infatti che questo lavoro vada svolto consumando le suole delle scarpe. O almeno così mi hanno insegnato coloro che reputo ancora miei maestri in questa professione. Ed è per questo che mi sono sempre più appassionato alle testimonianze di vita raccolte direttamente da coloro che le hanno vissute in prima persona, piuttosto che ai comunicati ufficiali o alle conferenze stampa con quel poco o tanto di artefatto che di solito fa ad essi da cornice. Ho cercato di raccontare la vita, quella vera, − che scorre per le vie della mia città, ma non solo − attraverso le “storie” apparentemente minori di gente destinata a non fare Storia. Provando a mettere a frutto la lezione del buon giornalismo, quello che s’indigna davanti alla sopraffazione e all’ingiustizia, che non sta mai alla corte dei potenti e che, se necessario, è disponibile per questo a pagarne pure il prezzo. Non nascondiamocela questa verità: nelle nostre città opulente lo scandalo rimane ancora oggi quello della povertà e delle condizioni di emarginazione dei troppi che una minoranza di benpensanti vorrebbe nascondere arrivando sino al punto di negare ai derelitti la parola. Perché non c’è oggi scandalo maggiore della sofferenza inflitta con arroganza dal potere, di qualunque tipo, che spesso chiede anche il complice silenzio della vittima, oltre a quello solidale, e per questo ancora più scandaloso, della colpevole indifferenza delle maggioranze silenziose. Un potere che di volta in volta veste i panni anonimi della burocrazia o quelli sacri del pastore di anime o del politicante di turno. Con i miei articoli e le mie inchieste ho cercato di fare solo questo, secondo le mie possibilità. Ho tentato di descrivere ciò che osservavo: una città dolente, la mia, Palermo. Una città come tante altre del Sud in cui la miseria, caratterizzata sovente dalla mancanza di speranza, ha anche tratti grotteschi. Come nel caso del bambino che fa gesti sconci alle signore che passeggiano ben vestite, o del giovane che riesce a non pagare il pizzo per il “buon cuore” del boss mafioso del quartiere, o del mendicante che chiede soldi cambiando la sua immagine secondo una sua personale visione delle regole del “mercato”, o di coloro che investono tempo e capitali nella disperata ricerca di un posto fisso che non arriva, o ancora dei due innamorati che riescono a rimanere tali solo parlandosi al citofono. Sono tutte storie che partono da un fatto, pur se trasfigurato dal racconto. Mi è capitato, talvolta, di gettare lo sguardo al di fuori della mia città − come nel caso dell’eremita delle Madonie o dello scultore che crea forme splendide con l’unico braccio che gli è rimasto, il sinistro − e di allargarlo alla realtà regionale, come nell’inchiesta sui preti sposati. I testi raccolti in questo libro sono usciti negli anni scorsi su testate locali, nazionali e uno anche sul mensile tedesco “Adesso”. Sono stati deliberatamente lasciati così com’erano, le uniche variazioni riguardano talune ovvie correzioni che vi avrei apportato anche nell’originale, se non fossi stato incalzato dai tempi necessariamente troppo stretti delle redazioni. Per renderne più godibile la lettura, ho talora accorpato articoli sullo stesso argomento pubblicati anche a distanza di tempo l’uno dall’altro. Ho comunque sempre indicato la data di pubblicazione, onde il lettore possa meglio inquadrarli nel loro contesto. Devo molto a molti. Ma per questo libro desidero innanzitutto ringraziare l’amico Luigi Gerbino, senza il cui interessamento queste pagine non avrebbero mai visto la luce. E i numerosi colleghi e maestri che in questi anni mi hanno incoraggiato e dai quali ho tanto imparato. Non posso infatti non ricordare Angelo Meli, a cui devo l’aver iniziato e perseverato in questa professione e la cui affettuosa amicizia mi ha sempre accompagnato; Giosuè Calaciura, mio primo e indimenticato caposervizio al quotidiano “il Mediterraneo”; Salvo Palazzolo, straordinario cronista delle vicende della nostra terra; Giustino Fabrizio, capo della redazione siciliana di “la Repubblica”, che mi ha pazientemente insegnato molte delle regole di questo mestiere; Diego Novelli, maestro di giornalismo delle passate generazioni e di tante altre a venire; e Mathilde Schwabeneder, inviata della televisione pubblica austriaca, che mi ha fatto intravedere nuovi e stimolanti orizzonti professionali. E ancora, un grazie di cuore a Beppe Lumia, il quale mi ha fatto comprendere che nella vita vi sono ideali, progetti e battaglie per i quali spendersi pienamente, qualunque sia il prezzo da pagare per essi. E infine, ma non per ultimo, un grazie all’amico Salvo Insenga, mio attento ed inesausto lettore. D. R.
5 Aprile 2002. I poveri di Palermo sono tanti. Troppi per una città del mondo cosiddetto evoluto. Troppi per una città che fa bella mostra della sua ostentata opulenza. C’è chi lo è quasi per “eredità”, per condizione genetica, come se la miseria fosse una tara ereditaria che passa da padre in figlio e chi invece vi è arrivato all’improvviso e ancora non se ne fa una ragione. Poi vi sono i disperati di ogni parte del mondo approdati in Sicilia come su una zattera di salvataggio sognando l’America e finiti a vendere oggetti artigianali sotto i portici del centro o assoldati dalla criminalità organizzata. Un esercito di sofferenti annidato nel ventre molle della città e dei quali la cronaca non si occupa mai se non per fatti di sangue. I poveri, si sa, non comprano i giornali ma, per la gente che li legge, sono spesso una minaccia o un oggetto di esercitazione retorica. Secondo alcune stime, elaborate dalle associazioni di volontariato impegnate sul campo, sarebbero nel solo capoluogo siciliano almeno 10 mila le famiglie che vivono in miseria e 5 mila quelle che vanno avanti a furia di stenti, ritenute socialmente irrecuperabili. Ma al di là delle improbabili statistiche o dell’asettico scorrere delle cifre, la miseria a Palermo ha l’aspetto di gente dalle guance scavate, i vestiti troppo leggeri per i primi rigori invernali, gli occhi bassi e le facce tristi, quasi sempre. Volti che alle volte s’illuminano quando vedono una mano tesa, soprattutto se piena, un orecchio attento e ascoltano una parola rassicurante che li incoraggia ad andare avanti, nonostante tutto. Ma anche gli angeli dei poveri sono tanti. Spesso, gente comune come fratello Franco, la cui storia – che è anche quella dei suoi poveri – e il cui impegno raccontiamo in queste pagine. A pochi passi dal centro scintillante di vetrine assediate dai pedoni, alla Noce, un antico e popolare quartiere, una fila di gente attende, sotto una pioggerellina fitta fitta, che un portone si apra. Nelle mani hanno ciotole, tegami, sacchetti di plastica. Dall’altra parte del marciapiede la parrocchia del “Sacro Cuore di Gesù” vomita gli ultimi fedeli della messa prefestiva. È un tardo pomeriggio di un sabato qualunque. Intorno a loro, nella città più “azzurra” d’Italia, dove il Polo ha stravinto uno dopo l’altra tutte le ultime tornate elettorali, la gente si prepara per il rito collettivo della libera uscita generale. Ma loro rimarranno lì ad aspettare che quella porta si apra, dietro un cartello che recita: “Asfabi, Associazione famiglie bisognose”, e subito sotto, “Per la spesa cruda se Dio la manda tutte le mattine, per il pasto caldo la sera alle 21”. Mancano ancora tre ore e la fila s’ingrossa lentamente sempre di più, straripa dal marciapiede e invade la strada. La porta si apre, c’è un momento di concitazione. Qualcuno si spintona, qualche altro comincia a gridare. Poi un uomo si fa avanti e tutti tacciono. Si segna e comincia a pregare. Si chiama Franco Pitari, o solo “fratello Franco” – come lo chiama la gente –, è vestito di nero, gli occhi color nocciola, una croce di legno al collo e una barba lunga e folta da padre cappuccino. Calabrese, ha quarantanove anni e una storia che sembra come riemersa dai secoli passati, quasi manzoniana. Maresciallo in pensione dell’arma dei carabinieri, a quarantadue anni, mentre osserva il crocifisso dell’altare della cattedrale di Palermo, si sente come squarciare il petto. Esce dalla chiesa e vomita una sostanza gialla: è un infarto. Durante il ricovero gli viene diagnosticato anche un tumore. I medici ritengono ormai inutile anche l’operazione. «Che lo apriamo a fare, combinato così fra non molto se ne va. Non si salva», ricorda di aver sentito dire da un medico. «Ma non potevo morire – racconta – la mia famiglia aveva bisogno di me. Mia moglie è invalida dal 1978. Non ci vede da un occhio e l’altro le dà parecchi problemi. Come potevo lasciarla sola con due ragazzi?». Disperando degli uomini ormai, si rivolge a Dio. Ricorda che un frate gli aveva regalato una immaginetta di Padre Pio. Lo prega di fargli il miracolo. «Durante la degenza, un giorno è successa una cosa che mi fa venire ancora i brividi quando ci penso. Ho sognato di essere in un posto bellissimo. Ero sotto un cielo con delle stelle di una luminosità mai vista. Davanti a me c’era una donna. Io non sapevo chi era perché il suo volto era talmente splendente che non riuscivo a fissarlo. Ricordo solo che mi ha detto una cosa che non ho compreso e ha allungato la sua mano verso di me. In quel momento mi sono svegliato». I medici lo informano che ha appena subito un arresto cardiaco, ma che il suo tumore è improvvisamente scomparso. Potenza della fede, direbbe qualcuno. Misteri della natura, gli risponderebbe qualcun altro. Nel 1995 viene messo in pensione dall’Arma. «Ho capito che Dio mi aveva ridato la vita e che io dovevo donarla per gli altri». I poveri li aveva già scoperti qualche tempo prima, adesso decide di dedicarsi esclusivamente a loro. Affitta un piccolo magazzino in via Noce 141 e fonda l’Asfabi per assistere gli indigenti. «Non abbiamo mai ricevuto contributi da nessuno – spiega amaro –, la Curia ci ha sbattuto più volte la porta in faccia, l’arcivescovo di Palermo il cardinale Salvatore De Giorgi, che organizza ogni anno a Natale un grande pranzo per i poveri della città, non mi ha mai voluto nemmeno ricevere. I miei poveri, si vede, non gli interessano. Le spese le paghiamo io e mia moglie con la pensione e fabbricando di notte crocifissi di legno che poi vendiamo. Come facciamo? Con la provvidenza e con quello che ci passa il Banco alimentare. Ma non basta». Non solo. Franco Pitari, infatti, ogni mattina comincia alle 7 e 30 il suo giro per caserme, carceri, bar e ospedali e raccoglie tutto il cibo avanzato. Ma sottobanco perché la legge non consentirebbe passaggi ufficiali di questo tipo. «Una legge assurda e inumana – commenta – che consente di buttare il mangiare mentre la gente muore di fame. L’ho visto io stesso che molte persone cercano nei cassonetti qualcosa per riempirsi lo stomaco, che ci sono mamme che allungano il latte per i propri bambini e tutto questo in una città opulenta che organizza anche convegni sui poveri». Rientrando, aiutato da una trentina di volontari che si alternano, riempie i sacchetti con la spesa da distribuire alle famiglie e comincia la preparazione del pasto della sera. «Assistiamo più di ottocento nuclei familiari», continua. E la pena diventa rabbia: «Ho bussato a tutte le porte degli enti locali, ma nessuno mi ha mai aperto. I miserabili non sono un partito e una lobby. Per questo tutti li usano e se ne fregano. I politici poi vengono solo in periodo elettorale, comprano voti con i pacchi di pasta, si servono dei poveri e poi spariscono. Si vergognino!». Mentre parla il viso gli si accende di rosso e gli occhi diventano di fuoco. Stringe i pugni e inizia ad essere scosso da fremiti. Ma nella stanza dove parliamo entra una ragazza dagli occhi color smeraldo, ha vent’anni o poco più. Barbara Prestigiacomo è una volontaria che divide il suo tempo fra lo studio e il servizio nell’associazione. Il suo sorriso mite ha il potere di distrarci. «Ci sono delle persone fuori che ti vogliono parlare», dice rivolta a “fratello Franco”. Lui si dirige verso alcuni visi emaciati di giovani donne. Io seguo la ragazza che torna alla distribuzione del pasto caldo della sera. Davanti a noi sfilano tutte le contraddizioni di una società sazia e indifferente. Pietro Costadura ha sessant’anni ed è una vecchia conoscenza dei volontari dell’Asfabi. Lava le scale dei palazzi signorili ed ha tre figli disoccupati «con tanto di diplomi appesi al muro. Concorsi ne hanno fatti tanti, ma… A casa ho anche mia figlia – racconta – che ha avuto un bambino e dopo si è separata. Ho un’ernia al disco e per lavorare la mattina prendo due bustine di Mesulid per non sentire il dolore. Se no non riesco nemmeno ad alzarmi. Speranze? Per me non ne ho, ormai sono vecchio. Penso ai giovani. Mia moglie è malata di diabete cronico. Al mese spendo più di 400 mila lire di medicinali perché la Asl non li passa. Franco è un santo. Quando non ha roba da dare, mette i soldi di tasca propria». Dietro di lui qualcuno borbotta. Nella fila si sono inseriti pure un paio di africani. «Perché non se ne stanno a casa propria?», si sente dire. «Anche loro hanno diritto, hanno fame come noi». A parlare è Paolo Gugliuzza. L’aspetto distinto, curato. Mentre racconta la sua storia abbassa lo sguardo. Si vergogna. La voce gli trema. Ha trentasei anni e due figli. Viene dall’altro capo della città. Anche lui lava le scale per tirare avanti. Ha due figli e una moglie. Quando ne parla, due gocce gli scendono sul viso: «È una donna meravigliosa, bellissima. Che vita le sto facendo fare…». E si gira dall’altra parte, la mano sugli occhi. Cerca di trattenere i singhiozzi e si allontana dalla fila. Un uomo dal volto saraceno lo segue, gli mette una mano sulla spalla, gli sussurra all’orecchio alcune parole. Si chiama Gaetano Campanella ed è un volontario. Un “compagno” che vota Ds. Crede in Dio e nell’uomo, sussurrano alcuni. «Sono in pensione da poco tempo – dice –, un giorno ho visto la gente in fila e mi sono fermato per curiosità. Da allora cerco di dare una mano anch’io. Non si può essere felici da soli». Il suo posto alla distribuzione della minestra calda lo prende un altro volontario. È Franco Orlando, il viso scurito dal sole e la barba di alcuni giorni. Ha tre figli, fa il posteggiatore abusivo e si arrangia con alcuni lavoretti “onesti”, ci tiene a precisare. «Ringrazio il Signore che mi dà le forze. Essere poveri è una umiliazione continua. Io cerco di aiutare la gente come me. Qui ogni tanto c’è chi perde la testa e fa qualche “minchiata”. Ma bisogna capire tutti: la fame fa perdere la ragione a volte. Io lo so». La gente sfila silenziosa. Un sorriso imbarazzato, un “grazie” quasi sussurrato e via. È un’interminabile corte dei miracoli. Ognuno con la sua storia di quotidiana miseria, ognuno con la sua sofferenza. Rosalia Brugnano è una pensionata di sessantasette anni dall’aspetto dimesso e gentile. Prende 350 mila al mese e abita in una casa popolare con il figlio di trentaquattro anni malato di mente e violento. Quando torna in casa, lascia il cibo sul tavolo della cucina per farlo mangiare e poi si chiude in camera. La sua paura è che un giorno suo figlio, in un raptus, la possa uccidere. Santa D’Aleo, invece, aveva un panificio. «Il locale l’avevamo in affitto, quando è morto mio marito mi sono trovata in mezzo a una strada. Ora prendo 700 mila di pensione al mese. Vivo con mia madre di novant’anni che prende la minima e così riusciamo a pagare almeno l’affitto e la luce. E basta», sorride. Dell’antica prosperità le è rimasta una certa contagiosa allegria e un distacco dalle sue vicende che racconta così come fra amiche si parlerebbe di frivolezze. «A domani», saluta. Dietro di lei un’altra storia. Giovanni Lauria è affetto da distrofia muscolare, ha trent’anni e un bambino. La pensione non gliel’hanno ancora data. «Sto facendo le carte, ma mi hanno detto che ci vuole tempo». Da quando lo stadio della malattia è avanzato, fino a rendergli difficili anche i movimenti più elementari, non riesce più a lavorare. Il corpo deformato come un ulivo centenario, vive in un piccolissimo appartamento senza luce. La moglie lo accompagna e sembra quasi lo sorregga. Ha una gonna a fiori estiva, alla quale è attaccato un bambino che la guarda estasiato. Grazia, invece, ha la mano destra offesa. Prende una pensione di 400 mila lire al mese. Il marito lavorava. Poi la fabbrica ha chiuso e tutti a casa. Abita in una casa popolare con una figlia che ha una bambina di quattro anni che non ha mai camminato. «L’assistente sociale ci ha detto che è normale e che era meglio che non parlavamo sennò ce la toglievano pure». C’è anche chi proprio non ce la fa ad andare a mendicare il cibo per sé e per la propria famiglia. Nessuno sa come si chiami quel ragazzino che ogni sera si presenta con le ciotole in mano e chiede “qualcosina” per quattro persone. Si sa solamente che fa tre chilometri a piedi per venire e che suo padre è uno dei nuovi disoccupati, di quei signori di mezza età espulsi all’improvviso dal mondo del lavoro senza la speranza di potervi più rientrare. Il ragazzo è ben vestito, mette tutto in un sacchetto, a mezza bocca dice qualcosa che nessuno comprende e si allontana rapido. Altro volto altra storia. Girolama Cusimano è una ragazza madre di trentacinque anni. I figli glieli hanno levati tutti. Non sa a chi li abbiano dati, ma scoppia in lacrime quando dice che vorrebbe vedere la sua bambina che ormai ha vent’anni. Vive, e non per amore, con un invalido anziano fuori di testa che le passa qualche lira. «Vengo qui, oltre che per il cibo, anche perché sono le uniche persone che non mi guardano da buttana e non si vive di solo pane», dice. «Se non ci fosse Franco, come piangeremmo!», le fa eco una donna dal volto smagrito, le ossa del corpo in evidenza sotto i vestiti troppo grandi. Si chiama Anna Beone, suo marito è in carcere per piccoli reati. Una ladro di galline, in fondo. Vive con tre bambine di undici, nove e quattro anni, dagli occhi di cobalto, in una casa pericolante alla Vucciria, un quartiere molto popolare abitato ormai soprattutto da extracomunitari. Ogni tanto la polizia le intima di sfollare. Lei allora si allontana per alcuni giorni. Occupa abusivamente un altro appartamento e poi ritorna. «Come siete belle», le dice allungandogli delle caramelle Franco che ci ha raggiunti. Sorridono mostrandoci le prime finestrelle fra i dentini. «Quando è venuta qui – mi confida – piangeva. Mi diceva che voleva farla finita. Solo si preoccupava per le bambine». «Non sapevo dove andare – racconta la donna – due parrocchie mi avevano sbattuto la porta in faccia. Padre Franco (così lo chiama) mi ha dato il coraggio di andare avanti». Sono le undici, la fila è ancora lunga. La pioggia è divenuta più insistente. Sulla strada le auto sfrecciano assordanti. La gente si spintona per ripararsi. Prima di andarmene, ho solo il tempo di registrare sul mio taccuino un’altra storia. Marilena Aliotta, ventisette anni, è una splendida ragazza dai capelli mossi color del grano maturo e due occhi acquosi. Vive coi genitori pensionati col minimo e ha un bambino di pochi mesi. Il padre non si è assunto le sue responsabilità, mi dicono. «Non riesco a trovare lavoro e mi servono latte, pannolini e vestiti per mio figlio. I miei fratelli lavorano saltuariamente ma non basta». Un volontario mi racconta che fratello Franco ha tirato fuori i soldi di tasca propria per comprare il latte pediatrico perché lui su queste cose la notte non ci dorme. Esco, ha smesso di piovere. La giornata di fratello Franco e dei suoi volontari non è ancora terminata. «Siamo sempre aperti – mi spiega –, estate e inverno, Natale e ferragosto. Se noi chiudiamo loro non mangiano». La temperatura fuori si è abbassata notevolmente. Osservo l’insegna luminosa del centro. C’è un disegno che raffigura una mano che passa un pane ad un’altra mano e ricordo quello che un giorno ha detto Gandhi: «Per il povero Dio è un pezzo di pane». Mi volto e guardo la porta della chiesa di fronte chiusa, sprangata. Mi chiedo dove sia Dio stasera.
3 Novembre 2000. Gli unici ritratti che di lui ci sono giunti ci consegnano l’immagine di un cinquantenne precocemente invecchiato dal volto affilato e pallido. Gli occhi tristi e assenti. Un volto segnato dagli anni e dalla vita. Ma da giovane, assicurano gli storici, Francesco Paolo Gravina, nato il 5 febbraio del 1800, ottavo e ultimo principe di Palagonia e di Lercara Friddi, discendente di una delle più illustri e ricche famiglie nobili del Regno delle Due Sicilie, sindaco di Palermo dal 1832 al 1835, era un signore ricco anche di fascino al quale lo sguardo delle fanciulle si rivolgeva con interesse. Adesso si appresta a divenire beato. Si è chiusa nei giorni scorsi, infatti, a Palermo la fase diocesana del processo canonico dopo più di dieci anni dalla sua apertura. E fra qualche anno, se tutto andrà bene, andrà ad ingrossare la folta fila di “testimoni” che la Chiesa addita ai suoi fedeli quali esempi delle virtù cristiane praticate sino all’eroismo. A narrarne la vicenda umana e spirituale è Umberto Castagna, perito storico del Tribunale ecclesiastico regionale e biografo ufficiale del “Principe dei poveri”, a cui ha dedicato trent’anni di ricerche e ben tre biografie. È solo grazie a lui che la sua storia non è rimasta sepolta per sempre negli archivi. «Una vicenda straordinaria – racconta lo storico – iniziata quando, a diciannove anni, s’innamorò di Nicoletta Filangeri e Pignatelli, figlia del principe di Cutò. Un amore folle il suo, ma anche il passo falso intorno al quale ruota tutta la sua singolare vicenda esistenziale». Donna vivace, brillante, curiosa e bellissima, fu la stessa Nicoletta, più grande del principe di qualche anno, ad interessarsi in un primo momento a lui. «Forse per un certo tempo lo amò davvero, questo giovane aristocratico, ricco di misteriose attrattive, piacente e insieme riservato. Forse confuse il fascino che nasceva da tutte queste qualità con un amore sincero. Sono convinto che almeno credette di amarlo veramente», commenta Castagna. Lui, invece, l’amò davvero. «L’amò – continua – perché era bella, brillante e un po’ spregiudicata; l’amò, forse, perché era così diversa dalle donne di casa Palagonia. L’amò perché credette di essere riamato. L’amò per tutta la vita, come solo sapeva amare il suo cuore di cavaliere antico». Si sposarono il 14 marzo del 1819. Ma il matrimonio, tormentato e senza figli, naufragò dopo dieci anni perché nel frattempo l’affascinante principessa di Palagonia si era invaghita del giovanissimo e, dicono gli storici, aitante Francesco Paolo Notarbartolo e Vanni, principe di Sciara. Il palazzo dei Notarbartolo, sito nel popolare quartiere della Kalsa, distava solo pochi metri da quello dei Palagonia. Nicoletta cominciò a frequentarlo anche la notte, rincasando spesso alle primi luci dell’alba. Ancora innamorato, dopo aver tentato inutilmente di riconciliarsi con la moglie, una notte le fece trovare il portone sbarrato e un servo in livrea che, a nome del Gravina, la «invitava a tornarsene da dove era venuta». Nicoletta andò allora ad abitare, fino alla fine dei suoi giorni, col Notarbartolo. Era il 1829. Confuso, ferito e umiliato, il principe si chiuse nel suo palazzo e nessuno ebbe più notizie di lui. Aveva ventinove anni e una ricchezza da vertigini. Per le stanze dell’immensa dimora non si sentivano più le risate e il frusciare degli abiti di lei. Per lui quel silenzio divenne assordante. Dopo circa un anno, un giorno fu visto girare con una borsa carica di monete per i vicoli della Palermo miserabile a seminare di speranza la vita di tanta gente. Qualcuno parlò di pazzia, qualcun altro di conversione. «Da allora – dice l’appassionato biografo – tutte le sue immense proprietà, che consistevano in palazzi, ville, interi paesi e miniere di zolfo, campi di grano e vigneti e agrumeti e frutteti e mandrie di animali, furono spese solo per uno scopo: migliorare l’infinita sofferenza dello sterminato popolo degli infelici». Confinatosi in una stanza del suo palazzo, fece aprire i battenti delle sue dimore a tutti i miserabili della città: quell’amara, orrenda processione di esseri deformi o comunque sfortunati, che al suo avo Ferdinando Francesco II era parso così spiritoso farsi raffigurare in pietra e porre intorno alla sua villa di delizia, a Bagheria, come sberleffo alla società e alla vita. Nel 1832 fu eletto “pretore” (cioè sindaco) di Palermo. Carica che mantenne fino al 1835. Anche suo padre e suo nonno lo erano stati. Quelli furono, per lui, anni preziosi in cui le sue iniziative per la povera gente si moltiplicarono senza sosta. «Nel campo della carità – dice Castagna – il Gravina fu un vero innovatore per i suoi tempi. La sua idea era quella non solo di dare un temporaneo sollievo ai poveri, ma di “rifarli uomini” attraverso il lavoro, l’istruzione e la formazione religiosa». Nel 1837 in città arrivò il colera che, in poco tempo, su una popolazione di circa 170 mila persone fece più di 27 mila vittime, una strage senza pari in Europa. Tutti fuggirono tranne lui, che non volle, e i poveri che non potevano. Ad affiancarlo solo un gruppo di nobildonne e di popolane. La generosità dimostrata in quella drammatica situazione da quelle donne, gli diede l’idea di dar vita a una famiglia religiosa che si occupasse soprattutto dei poveri: le “Suore di carità”. «Una cosa singolare nella storia della Chiesa – commenta lo storico –, anzi unica: che un laico, non sacerdote, abbia fondato e diretto un gruppo di religiose». Esausto, si spense all’età di cinquantaquattro anni, il 15 aprile 1854. Qualche giorno prima, aveva dettato le sue ultime volontà, poi era voluto rimanere solo e aveva aspettato in silenzio la morte. «Morì – conclude Castagna – per essersi speso senza riposo per i suoi poveri ma soprattutto morì di quello che allora si chiamava “crepacuore” o “mal d’amore”. Fino alla fine, infatti, era rimasto innamorato della moglie».
Marzo 2003. Contrariamente a quanto generalmente si crede, la Chiesa cattolica non condanna le persone omosessuali in quanto tali ma parla piuttosto di «relazioni omosessuali» come «gravi depravazioni». Questa posizione, espressa chiaramente a più riprese e in diversi documenti ufficiali nel tempo, è stata infine cristallizzata nel compendio della dottrina della Chiesa, il Catechismo promulgato da Giovanni Paolo II nel 1992. Pur ammettendo che «la genesi psichica di tale fenomeno rimane in gran parte inspiegabile», la Chiesa ribadisce che «gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati» in quanto «sono contrari alla legge di natura precludendo all’atto sessuale il dono della vita». E, quindi, «in nessun caso devono essere approvati». Più avanti, poi, il Catechismo specifica: «Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali innate. Costoro non scelgono la loro condizione omosessuale; essa costituisce per la maggior parte di loro una prova». Una prova, naturalmente, per impadronirsi del cielo perché «le persone omosessuali sono chiamate alla castità». Tutto chiaro allora? Dal punto di vista dottrinale certamente sì. Ma la vita, anche quella di Santa Romana Chiesa, non sempre riesce ad adattarsi alla dottrina, seppur chiaramente espressa o vecchia di secoli. Basterebbe, ad esempio, ricordare che ai monaci che nel IV secolo si ritiravano in romitaggio nelle desolate terre del Nord Africa, e non solo, era fatto assoluto divieto di far pernottare i loro confratelli, specie se più giovani, nelle loro capanne. Il motivo è fin troppo facile da immaginare. Gli esempi potrebbero continuare fino a rendersi conto che nella Chiesa cattolica l’omosessualità ha le proporzioni di un fenomeno di massa. Recentemente, le alte sfere della gerarchia hanno redatto un durissimo documento nel quale, fra le altre cose, si chiede ai vescovi di interdire i seminari e le case religiose ai candidati con chiare tendenze omosessuali. Un rimedio drastico che però non elimina il problema. Perché dietro le chiare prese di posizione e le dissertazioni dotte ci sono spesso storie di nascondimento, di ipocrisia e di dolore. Come quelle di don Luigi o di Tiziana che qui di seguito raccontiamo. Requiem per un prete omosessuale Di don Luigi Stella nessuno parla più ormai e pochi hanno avuto il coraggio di farlo mentre ancora era in vita. Eppure è morto da poco più di cinque anni e i suoi funerali sono stati celebrati in una parrocchia della città da un altissimo prelato. Ma il tutto è avvenuto con il massimo della riservatezza. Anche un quotidiano locale, spesso così sensibile e bene informato di ogni sospiro del Sacro Palazzo, si è limitato a riservare all’avvenimento solo poche righe. Una “breve” affogata fra le altre. Una notizia senza importanza come tante altre. Ma di don Luigi non bisognava parlare. Di questo prete geniale e creativo che aveva scoperto progressivamente la propria omosessualità, di questo prete che aveva cominciato a dubitare della Chiesa e delle sue secolari certezze, bisognava assolutamente tacere. «L’allievo più intelligente che io abbia mai avuto», dice di lui uno dei suoi docenti della Facoltà teologica di Palermo. «Una persona sensibilissima, un vero artista», ricorda un suo ex-compagno di seminario che è adesso a capo di una grossa parrocchia del centro. Sì, perché don Luigi, oltre all’indiscusso talento per lo studio teologico e a una curiosità vorace che lo faceva interessare di tutto con passione, dipingeva e anche bene. Talmente bene che, dopo aver abbandonato il ministero – in seguito ad una profonda crisi di fede e a un rapporto molto conflittuale con la gerarchia ecclesiastica –, in quella Parigi dove, come un giovane bohémien, era fuggito, aveva aperto una galleria d’arte dove vendeva i suoi quadri. Qualcuno dice che lì avesse trovato anche l’amore. «Da allora in poi – racconta il suo ex-compagno – è iniziata l’opera di rimozione nei suoi confronti. È iniziata la congiura del silenzio come in genere accade nel nostro ambiente. Nessuno doveva più parlare di quel chierico del quale neppure uno era stato in grado di fugare i dubbi teologici e che, prima di andarsene, come mi ha raccontato un curiale presente alla scena, si era presentato al suo arcivescovo al quale, strappandosi il clergyman, aveva gridato in faccia: “Lei mi ha fatto perdere la fede”». Ma a togliere dall’imbarazzo superiori e confratelli ci ha pensato, a Parigi, un rapinatore entrato nella sua galleria d’arte. Gli è partito un colpo dalla pistola e l’ha ucciso. Per errore, dicono. Storia di Tiziana 8 Luglio 2000. «È come se mi avessero amputato una parte del corpo, come se mi avessero separata da me stessa». Ha gli occhi arrossati, Tiziana, ma ha voglia di raccontarsi, di ricordare, andare alla ricerca, con la memoria, di quella se stessa che una morale ipocrita e bigotta, sostiene lei, le ha impedito di essere e di amare. Tiziana è una ragazza mora, senza dubbio bella, dai capelli ricci e gli occhi di un verde assai intenso che si avvia a varcare la soglia dei trent’anni. Oggi ha un marito, una bambina, una casa soleggiata e un lavoro che la gratifica. Una cosa sola chiede: che la sua storia venga riportata in modo tale che nessuno la possa riconoscere. Ma la vicenda è vera, forse anche troppo comune, così come il suo dolore. «Quando andavo al liceo frequentavo un gruppo giovanile parrocchiale. Come succede normalmente quando ragazzi e ragazze stanno insieme, fu in quel contesto che ebbi le prime storie, le prime esperienze. Tanti sentimenti e troppa curiosità. In fondo, mi sentivo una persona graziata perché mia madre si era separata da poco e nella Chiesa i figli dei divorziati vengono guardati con sospetto, quasi fossero segnati da una colpa originaria. Da loro ci si aspetta di tutto. Economicamente non me la passavo neanche tanto bene. Mio padre, infatti, non ci dava una lira, ma c’era sempre qualcuno dei ragazzi disposto a pagare per me, con discrezione». Un giorno, però, nel gruppo entra una ragazza, Monia, più piccola di lei di qualche anno. Monia viene dalla buona borghesia della città, quella incolta e affarista che si è arricchita col sacco edilizio ma che ha mandato poi i figli a studiare in scuole di prestigio. Lei frequenta un istituto privato, la mamma si spende in iniziative caritative e il padre è un libero professionista dal volto sempre abbronzato. Monia e Tiziana diventano presto amiche, quasi inseparabili. Ormai passano insieme buona parte della giornata. La sera si intrattengono in lunghe telefonate per dirsi e raccontarsi tutto quello che, durante le ore spese insieme, non hanno saputo o voluto dirsi. Poi, un giorno la scoperta. «Ero a casa sua per aiutarla a fare i compiti – racconta Tiziana –, Monia non è mai stata molto studiosa. Era pomeriggio e sua madre non c’era. Mi ricordo ancora la scena: lei leggeva ed io la guardavo, non riuscivo più nemmeno ad ascoltarla. Sentivo dentro di me come pulsare qualcosa, sempre più intensamente, una specie di enorme brivido. Ad un certo punto, lei si è accorta che la osservavo. Ha alzato la testa dal libro, mi ha guardata e ci siamo baciate per tutto il pomeriggio, quasi senza fermarci. Io le dicevo che l’amavo e lei piangeva dalla gioia». Quella sera, ricorda, se ne andò a casa col cuore che le esultava ma anche con un’enorme confusione in testa. Le telefonò, parlarono a lungo, ossessionate entrambe dalla paura che ciò che avevano fatto fosse “peccato”. Monia disse che avrebbe chiesto consiglio ai preti della sua scuola, Tiziana al parroco. Ma l’unica risposta che ricevettero fu il comando si separarsi perché i loro «rapporti» erano «contro natura». Decisero allora di continuare ad amarsi, ma di nascosto. «All’inizio, nel gruppo nessuno sembrò accorgersi di nulla. Magari ogni tanto qualcuno ci prendeva in giro perché eravamo sempre insieme, ma nulla di più. Noi, però, ci amavamo sempre di più. Spesso Monia veniva a dormire da me perché mia madre per arrotondare faceva la baby-sitter e a casa la sera non c’era quasi mai. Eravamo talmente “cotte” che talvolta ci baciavamo anche in chiesa. Non davanti a tutti, s’intende, ma in qualche stanza nella quale andavamo con una scusa qualunque. “Lo sai che siamo lesbiche?”, le dicevo. Lei rideva e mi abbracciava». Un giorno, però, una ragazza, proprio in chiesa, le scopre. La pregano di non dir niente a nessuno, lei promette. Ma, dopo qualche tempo, si accorgono che i frequentatori della parrocchia, quando passano mano nella mano, sorridono, e qualcuno le indica da lontano. Il parroco, quando le incontra, quasi scherzando le separa e chiede loro se hanno un ragazzo. Cominciano a girare le battute, le barzellette sul loro conto. Qualcuno le guarda e scoppia a ridere. La loro confusione aumenta. Si stringono ancora di più l’una all’altra. Non frequentano più il gruppo giovanile, anche perché non arrivano più inviti per uscire. Monia comincia a dimagrire vistosamente, Tiziana diventa irritabile. Un bravo ragazzo della parrocchia tenta pure di “sbloccare” la più carina della coppia, Tiziana, mettendole le mani addosso. Il loro profitto scolastico scende sensibilmente. La madre di Monia si preoccupa e ne parla con le amiche, qualcuna, forse, le racconta tutto. «Una sera mi arrivò una telefonata, era sua mamma, mi intimava di non vedere più sua figlia. Sapeva tutto. Da allora non l’ho più quasi rivista. Ho saputo solo che era in cura da uno psicologo che la imbottiva di ansiolitici per “guarirla”. Io ho passato dei momenti terribili. Disgustata da tutta quella ipocrisia, non ho più messo piede in chiesa se non per sposarmi. Poi ho incontrato mio marito che di tutta questa storia non ne sa nulla. Siamo stati fidanzati per qualche anno e ci siamo sposati. L’orgasmo lo so fingere bene, poverino. Spero solo che, quando mia figlia sarà più grande, possa amare chi vuole». Pensi ancora a Monia ogni tanto? «Sempre, soprattutto quando faccio l’amore con mio marito».
Maggio 2002. «Preeee…» «Vado io». Santina si precipitò verso l’ingresso, afferrò la cornetta del citofono, la portò all’orecchio e distese le labbra in un sorriso. Sapeva chi era. Dall’altra parte, una voce calda, con tono pacato, cominciò a raccontarle una storia. Una fiaba inventata soltanto per lei. «Ma questo qua che intenzioni ci ha che ogni sera, da tre anni, si mette a parlare al citofono per una para di ora? Che vuole babbiare? E perché, invece di venire qua, non telefona? Maledetta la… che quel giorno ci ha aperto tua figlia a quello del pane alla porta. Se ci andavi tu ‘dda scimunita non s’innamorava!». Ciccio, il padre di Santina, come al solito borbottava mentre, sprofondato nella sua poltrona di finta pelle, fra una lacrima e l’altra, guardava in tv “Anche i poveri si amano, solo che soffrono di più”, con Llera Carmen Sorella y Palo nella parte della sventurata protagonista. “Mii... – continuò pensando a mezza voce –, ma ‘sta fimmina brasiliana è proprio bedda! Ma chi ci dunano a manciari ddocu? E dicono che nel terzo mondo c’è la fame! Si vede che mangiare picca fa bene”. Poi guardò sua moglie, Rosa, cinquant’anni, due figli, il seno floscio, gli occhiali spessi e trenta chili di sovrappeso e, mentalmente, cominciò a indirizzarle la solita serie di insulti. «È che Salvino, il ragazzo, è orfano di padre e il telefono a casa non se lo possono permettere. Speriamo che l’onorevole ci trova il posto così si sistema. E poi la madre è una brava persona: fa la baby-sitter ad una signora che abita nel palazzo dove il cugino di Giusy ha la portineria. Diciamo che si conoscono. In ogni caso, l’importante è che i ragazzi si vogliono bene e che lui non si droga», la voce stridula della consorte s’inserì, ignara, fra gli improperi del marito. «Speriamo, così la finiamo co ‘sta storia che facciamo ridere i polli dei vicini» le fece eco Ciccio, fra un’ingiuria e l’altra. Nel frattempo i due innamorati continuavano a tubare al citofono. «Mi ami?» domandava lei. «Ma certo che ti amo. Quante volte te lo devo dire?» rispondeva lui. «Allora raccontami la favola di lei che poi viene l’industriale e la porta via dalla casa della matrigna» riprendeva lei, attorcigliandosi il filo del citofono fra le dita. «Te l’ho raccontata già cento volte. Fammi andare a casa che domani mi devo alzare alle cinque per andare a fare il pane e sono già le undici» cercava di tagliare corto lui. «Va bene, però prima dammi un bacio». «Pchk!» Santina dopo andava a letto e sognava la fiaba che Salvino le aveva raccontato poco prima. E questo accadeva, da tre anni, ogni sera. Lui non era mai venuto meno all’impegno. Freddo, pioggia, malanni suoi e dei familiari. Nulla era mai riuscito a costringerlo a casa e a non presentarsi al suo appuntamento. Ogni volta che Santina ci pensava, sentiva il cuore batterle così forte che quasi le squassava il petto. Alla fine il miracolo era avvenuto. Dopo più di quattro anni, l’onorevole aveva “trovato” un posto alle Poste a Salvino. I due innamorati avevano così potuto «coronare il loro sogno che non si sapeva come andava a finire, poveri giovani», come raccontava la madre di lei alle vicine. Cerimonia religiosa solenne in una grande chiesa della città, naturalmente, gli invitati che maledicevano il caldo e i matrimoni celebrati in estate, e lei, bellissima, pelle scura e il seno florido stretto dentro un abito bianchissimo con tredici metri di velo, che finalmente diceva “sì” per sempre al suo lui. Poi l’emozione e le lacrime di tutti, ma anche l’imbarazzo del prete che, guardando nella sua scollatura, per un momento non era stato più in grado di proseguire. Infine, come da copione, il viaggio di nozze negli Stati Uniti per visitare i luoghi dove si muovevano i protagonisti dei film che li avevano fatti spesso sognare. Ma la vita a due non sempre risulta come la si immagina quando si è ancora fidanzati. E così, una sera, dopo una lite più violenta del solito – nella quale erano stati coinvolti, a vario titolo, i parenti di entrambi fino alla settima generazione o su di lì –, Salvino si tirò dietro la porta con l’intenzione, aveva dichiarato, di andarsi a «sfogare da una di “quelle”». Piuttosto prevedibile la reazione della sposina: scoppiò in lacrime appiccicandosi al telefono per riferire alla madre cosa le aveva fatto quel “mostro”. Il coniuge di fresca nomina, invece, accortosi di aver dimenticato le chiavi dell’auto a casa, bestemmiando tutti i santi del calendario, senza fare preferenze, diede una manata alla targhetta che recitava: “Fam. Salvato-La Pecorella”. «Pree!» gracchiò il citofono. «Chi è?» rispose Santina fra le lacrime. All’udirla, Salvino si sentì all’improvviso come preso da una vertigine che lo trascinò con la mente a giorni più felici e ormai quasi sepolti. Il tono della voce di lei era lo stesso di quello di qualche anno prima, soltanto un po’ increspato dal pianto. E, così, dopo qualche minuto di silenzio, il viso incollato al muro, gli occhi chiusi, si abbandonò come un tempo a raccontare con voce calma: «C’era una volta, in un quartiere lontano lontano…»
3 Agosto 1999. Sotto l’insegna di un discount, il supermarket dei poveri, in un quartiere popolare e popoloso della città, Salvo (ma il nome è d’invenzione), insieme ad altri cinque ragazzi, si affanna dietro ai clienti per aiutarli a scaricare i sacchetti della spesa dai carrelli e prendere la mancia per il servizio. Ha trent’anni, un’abbronzatura da villaggio vacanze, dei calzoncini con vistosi rododendri colorati, una canottiera blu elettrico sotto la quale si cela – ma non tanto – un ventre prominente e fra le labbra il canonico mozzicone di sigaretta. «Scuola non ne ho mai voluta – spiega senza mezzi termini –, alla licenza media ci sono arrivato prima di partire per la visita militare. Ho provato a fare il muratore, ma mi davano solo settecentomila lire al mese e poi mi stancavo. Certo, questo non è proprio un lavoro vero, però ogni giorno mi porto a casa trenta-quarantamila lire e, per le feste, arrivo anche a sessanta. E poi sto con gli amici», dice indicando i suoi “colleghi”. Adesso Salvo pensa a mettere su famiglia, la sera non esce più, fuma di meno e i soldi che guadagna li mette da parte per comprare i mobili di casa, «due stanze», precisa, che lui e la sua ragazza – che chiameremo Rosy – hanno già affittato. «Qui lo sanno tutti che mi devo sposare – continua – e mi lasciano scaricare più carrelli. Anche il picciotto della zona che viene per il pizzo mi rispetta e non mi chiede soldi». Ma quanto si paga per lavorare? «Io non ho mai dato una lira – risponde Salvo – perché quando “lui” è venuto la prima volta dicendoci che lo mandava “chi sappiamo noi” e che voleva ventimila lire ogni giorno da ognuno di noi, io, che mi devo sposare, ho preso Rosy e le ho detto: “Accompagnami da una persona che poi ti spiego”». E dopo? «Dopo sono andato da questa persona che non si può dire», continua Salvo quasi sottovoce, poi esita, si ferma. Riprende: «Allora… Lui sta sempre in una bettola della zona. Mi sono presentato tenendo per mano Rosy, perché certa gente le femmine le rispetta sempre, e gli ho detto: “Io mi devo sposare e se le do i soldi non so come pagare i mobili”». Lui cos’ha fatto? «Beh, nel frattempo la mia ragazza lo guardava fisso negli occhi. Allora lui ha chiamato il picciotto della zona e gli ha detto, davanti a me, di rispettarmi e di non farmi pagare niente fino al matrimonio. Anzi gli ha anche detto di trovarmi un supermercato dove si facevano più soldi». Insomma, Salvo, è finita bene: non paghi e, in più, “lavori” in un posto migliore. «Sì, in fondo sono contento. Però, il problema resta: dopo che mi sarò sposato, il pizzo lo dovrò pagare lo stesso. E qui è anche più alto di altre zone. Come farò a campare?». Già. «Mah, io una cosa l’ho già pensata», dice Salvo meditabondo. Cosa? «Se “quella persona” mi ha rispettato per il matrimonio, sicuramente lo farà anche quando mi nascerà il primo figlio. E non è detto che poi al primo bambino non gli faccia i fratellini». E se non funziona? «Allora ci vado con Rosy e il bambino. Hai mai visto qualcuno che non si commuove davanti ad un bambino?».
13 Ottobre 2000. Per la prima volta nella storia un papa, Giovanni Paolo II, li ha ricordati pubblicamente durante il Giubileo dedicato ai sacerdoti celebrato nei giorni scorsi in Vaticano. I preti con prole ci sono, dunque, e costituiscono un problema per la Chiesa cattolica. Considerati quasi dei dannati e degli eretici dai fedeli e dagli altri chierici, vivono ai margini della comunità ecclesiale. Guai, quindi, a chiedere informazioni su di loro alle Curie. Si rischiano solo imbarazzati silenzi e perentorie risposte negative. Il problema non esiste, affermano, o almeno, così si vorrebbe che fosse. Ma a smentire gli slogans propagandistici della Conferenza episcopale siciliana, guidata dal cardinale Salvatore De Giorgi, sulla “Nuova primavera vocazionale” che interesserebbe da tempo l’Isola, interviene puntualmente la cronaca. Il 6 luglio dell’anno scorso, a Palermo, proprio a ridosso delle celebrazioni per il Festino di Santa Rosalia, Giampiero Tre Re, ex docente di morale della Facoltà teologica di Sicilia, finissimo intellettuale, autore di numerosi e corposi saggi, si univa in matrimonio con Daniela Chinnici, brillante avvocato e attualmente segretario provinciale dei Comunisti italiani. Due mesi dopo, a settembre, nella chiesa di San Saverio, nel popolare quartiere dell’Albergheria, l’ex prete antimafia Gregorio Porcaro impalmava la sua “Pippi”, al secolo Giusy Salerno. A celebrare le nozze padre Cosimo Scordato e don Luigi Ciotti. Al matrimonio era presente anche il figlio della coppia, Matteo, di quattro anni. Più recentemente, circa due settimane fa, il vescovo di Piazza Armerina, monsignor Vincenzo Cirrincione, si è visto costretto ad affidare la parrocchia di San Bartolomeo di Enna al diacono Pietro Valenti. Quarantadue anni, sposato con Maria Grazia, padre di tre figli (due femmine e un maschio), nella vita “civile” assistente di laboratorio in una scuola, Valenti è il primo laico in Sicilia a guidare una comunità senza essere prete. Scavando fra le pieghe della cronaca, come a noi piace fare, si viene a scoprire però che la chiesa di San Bartolomeo, poco più di tremila fedeli nel cuore della città antica, è da più di un anno senza guida dopo l’abbandono dell’ex sacerdote Filippo Salerno dovuto, oltre che a motivi sentimentali, anche a dissapori con la Curia. Casi isolati? Non sembrerebbe affatto dalle storie che abbiamo raccolto. «Quando sono andato dal mio vescovo per dirgli che mi ero innamorato e che volevo lasciare il ministero, lui mi ha risposto che per bere un bicchiere di latte non era necessario mettersi una capra in casa. Allora ho capito che la mia compagna era la cosa più pulita che mi fosse rimasta». Ha voglia di raccontare e raccontarsi Paolo, ma a patto che il suo vero nome non venga fuori. «Se sanno che ho parlato con un giornalista – spiega – mi tolgono la cattedra di religione che mi hanno dato per vivere, dopo che ho lasciato il ministero». Come lui, anche gli altri preti sposati, incontrati in un viaggio in una sorta di Chiesa clandestina, hanno accettato di parlare, ma sempre con la condizione che non venisse fatto il loro nome e che non fossero resi riconoscibili dalle storie che raccontavano. Perché è proprio questa la differenza fra i chierici con prole siciliani e quelli del resto dell’Italia, i nostri hanno più paura delle ritorsioni della gerarchia. Sembrerebbe che una “certa” cultura si sia insinuata anche nei rapporti fra pastori e sudditi. Non in tutta la regione fortunatamente. Ci sono anche numerosissimi casi di vescovi che seguono con particolare attenzione le vicende dei sacerdoti che smettono la tonaca. Ma qual è la consistenza del fenomeno? Secondo i dati più recenti, sarebbero circa trecento in tutta l’Isola, dei quali più di ottanta solo a Palermo, ben poca cosa rispetto ai circa diecimila, sui 58 mila ancora in servizio attivo, di tutto il Paese. Se poi si vanno a guardare le cifre relative al pianeta, si vede che costituiscono il ventidue per cento del totale con ben 120 mila membri. Questi, però, sono i numeri forniti dalle stesse associazioni e c’è il sospetto che siano un po’ “arrotondati” per portare acqua al loro mulino. Purtroppo, però, non esistono stime ufficiali del Vaticano. Il suo Ufficio statistiche nega che questi dati esistano, ma il direttore della rivista vocazionale Rogate, padre Vito Magno spiega: «Gli unici a possederli sono i vescovi che hanno tutto l’interesse a non fornirli». «Sono, infatti, contenuti – dice don Cosimo Scordato, prete e teologo palermitano di frontiera – nelle relazioni che i vescovi presentano ogni cinque anni al Papa al termine della visita ad limina. Purtroppo il contenuto di quei documenti è secretato per trent’anni». Ma i preti sposati nelle città ci sono e dicono pure messa nelle loro case. Le chiamano “chiese domestiche”, con tanto di fedeli e sacramenti, compreso il battesimo e la confessione. Alcuni di loro concelebrano anche, ma con discrezione, nelle parrocchie di presbiteri amici. Eppure pochi sanno che esistono e non se ne parla mai sui mezzi d’informazione cattolici. «Quando te ne vai – dice uno di loro – in mano ti trovi solo una laurea in teologia, un titolo che lo Stato non riconosce neppure. E, con la tua nuova situazione, spesso con un bimbo in arrivo, magari a quarant’anni suonati, non puoi fare lo schifiltoso. Accetti le loro condizioni e ti metti in un angolo. Perché è questo quello che vogliono: che tu scompaia». In genere, infatti, le cattedre gli vengono assegnate in diocesi vicine dove non sono conosciuti. Ma non tutti ottengono l’insegnamento. «Dipende – spiega Salvatore – dalla rapidità con la quale ottieni la dispensa per sposarti, perché, finché il processo canonico non si chiude, non puoi fare nulla. Io, ad esempio, ho fatto i lavori più umili per diversi anni perché la mia richiesta non era “spinta” a Roma da nessuno. E poi dipende anche dal vescovo perché è lui che patrocina il tuo caso e, se non siete in buoni rapporti o non ti stima, ti devi rassegnare e cambiare aria». Ma ci sono anche quelli che non ci riescono ad attendere i tempi, è il caso di dirlo, biblici, circa dieci anni, e che perdono la fede o cambiano Chiesa. È il caso di Mauro che, dice lui, in un momento di disperazione è diventato pastore della Chiesa valdese. «Quando i protestanti sanno che hai abbandonato il ministero – racconta – sono i primi ad aprirti le porte». Adesso Mauro è rientrato nella Chiesa cattolica, ma è considerato un apostata e i tempi del suo processo si stanno sensibilmente allungando. Infine, ci sono anche le donne dei preti: le “tentatrici”, le “rivali di Dio”. Come le ha chiamate qualcuno. Rosa è una libera professionista, affermata e stimata, ha un fidanzato col quale progetta di sposarsi, ma quando era ancora una studentessa ha avuto una storia con un giovane prete. «Un giorno, però, ho scoperto che aveva anche altre ragazze, cinque o sei – ricorda –. Poi è scoppiato lo scandalo subito coperto dalla Curia. Lo hanno mandato fuori a meditare e studiare, poi è tornato qui a continuare quello che faceva prima, adesso so che l’hanno spedito per punizione a fare il vice parroco in un’altra diocesi. Tutto questo mi è servito a capire che certi uomini non pagano mai per i loro errori, a patto però che siano ecclesiastici». Già non molto considerate all’interno della Chiesa, le donne che si innamorano dei preti vengono spesso maltrattate. È il caso di Gianna, sposata, un marito lontano, e due figli già grandi, che ha commesso l’errore di aspettare un bambino da un parroco di frontiera. Lui ha improvvisamente scoperto la vocazione missionaria, e per questo è stato spedito in America Latina, mentre lei si è trovata a gestire da sola una situazione drammatica. La Curia è intervenuta per darle una mano soltanto quando ha minacciato di fare scoppiare lo scandalo. Prima l’avevano liquidata come “pazza”. Situazione simile a quella di Laura che, stanca di essere relegata al ruolo di amante con un bambino di pochi mesi da crescere, un giorno ha preso “il frutto del peccato” e lo ha portato nella chiesa dove il suo lui celebrava. Vedendolo così solenne e ieratico che benediceva, racconta, non ce l’ha fatta più ed è esplosa. Com’è finita? Il reverendo, notissimo teologo di orientamento progressista, è andato a insegnare in una prestigiosissima istituzione accademica ecclesiastica in un’altra città, a lei è stato promesso un “sostegno” purché tacesse. Situazione che ha accettato ma, commenta, con il cuore davvero a pezzi. Intanto, alcuni sacerdoti sposati siciliani della Spes (Societas presbiterorum eorum sororum) in occasione del Giubileo hanno preso carta e penna ed hanno inviato attraverso la Sir, l’agenzia di stampa della Chiesa italiana, l’Avvenire, il giornale dei vescovi, e quello della Santa Sede, l’Osservatore romano, una lettera ai vescovi italiani e, in particolare, siciliani che non è stata mai pubblicata e della quale nessun mezzo d’informazione cattolico ha mai dato notizia. Ecco qui di seguito il testo della lettera indirizzata «ai vescovi ed ai presbiteri nostri fratelli»: «Il Giubileo è un grande evento religioso che noi sacerdoti sposati guardiamo con grande speranza. Vorremmo infatti che vi sia anche per noi la possibilità di “riappropriarci” del nostro diritto di vivere pienamente la nostra vocazione ministeriale nella Chiesa che ci è madre e che amiamo grandemente. Le origini del giubileo si ricollegano all’Antico Testamento. La legge di Mosé aveva fissato per il popolo ebraico un anno particolare: “Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel Paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest’anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo”. Anche noi sacerdoti sposati certamente faremmo un bel giubileo se potessimo tornare ad avere il “nostro” giusto posto nella Chiesa che in qualche modo siamo stati costretti a lasciare. Crediamo che un significativo gesto in tal senso darebbe molta più credibilità alla Chiesa e la proietterebbe coraggiosamente nel terzo millennio con nuove prospettive di salvezza». In verità, l’idea non è nuova. Già il primate d’Inghilterra, il cardinale Basile Hume, recentemente scomparso, aveva proposto allo stesso Papa di concedere, in occasione del giubileo, «un’amnistia verso i preti sposati» riammettendoli al ministero. Il porporato inglese aveva presente la situazione, che costituiva quasi un precedente giuridico, di numerosi preti passati dalla Chiesa anglicana a quella cattolica con tanto di moglie e figli. La richiesta però era stata fatta cadere nel vuoto. Forse per affrontare il problema dei preti con prole un giubileo è ancora troppo poco, forse ci vorrebbe quello che l’arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, va chiedendo da tempo: un altro Concilio. Ma si sa che, col vento che tira per adesso in Vaticano e nella Chiesa italiana, il Concilio, nemmeno quello già celebrato, è meglio non nominarlo neppure. I preti sposati danno più fiducia La sua relativa autonomia giuridica, sancita dal nuovo Codice di diritto canonico per le Chiese orientali del 1990, gli permette anche di esprimersi con più libertà dei suoi colleghi di rito latino e più rigidamente sottoposti a Roma. Ma l’eparca di Piana degli Albanesi, antichissima piccola enclave albanese in provincia di Palermo, monsignor Sotìr Ferrara, l’unico vescovo che risponde a tutti al telefono senza tante anticamere e cerimonie, non ha dubbi in merito: «I miei preti migliori? Sono quelli sposati». La dichiarazione l’ha rilasciata nei mesi scorsi al periodico dei sacerdoti italiani Vita pastorale, dei padri Paolini, e per alcuni, che sono voluti andare al di là delle intenzioni dell’alto prelato, ha avuto soprattutto il sapore di una provocazione. «Ma nella nostra eparchia (diocesi di rito greco, ndr.) – spiega il teologo e diacono sposato Paolo Gionfriddo, direttore della rivista Oriente Cristiano – si segue semplicemente l’antichissima tradizione delle Chiese ortodosse di ordinare presbiteri uomini già sposati». «Mai avuto un abbandono a causa di una donna – riprende Ferrara –, qui i preti possono scegliere e questo dà loro maggior serenità». Su venti chierici che ha l’eparchia cattolico-bizantina, ben tre sono quelli uxorati, in pratica più del dieci per cento. «Sono stato ordinato – racconta papas (padre, ndr.) Nicola Cuccia, quarant’anni, una bambina di sette anni e parroco di Contessa Entellina – dopo un lungo periodo in cui, dipendendo l’eparchia giuridicamente da quella di Palermo, era impossibile anche proporre la consacrazione di uomini sposati. Poi, con l’autonomia giuridica acquisita negli anni Settanta, abbiamo ripreso la vecchia tradizione. Mia moglie fa la catechista in parrocchia e da noi in paese sono ormai talmente abituati all’idea del sacerdote con famiglia e figli che considerano strani quelli celibi». Ma non ha difficoltà nell’esercitare il ministero? «Anzi – risponde il papas –, la mia condizione mi aiuta perché i miei parrocchiani sanno che vivo i loro stessi problemi e, se parlo, è perché ho esperienza delle cose». Oltre a lui, sono sposati anche il parroco della cattedrale, dedicata a San Demetrio, papas Giovanni Pecoraro, trentotto anni e due bambini, e papas Antonio Macaluso, di settantotto, con una sfilza di nipoti e pronipoti, viceparroco alla Martorana di Palermo. Infine, c’è anche un giovane seminarista di trent’anni, Giuseppe Borzì, che, dicono, oltre a Dio e alla teologia, ami solo la sua fidanzata dagli occhi chiari. Nessuno dei suoi colleghi di rito latino potrebbe dire altrettanto. Un parroco ortodosso di Palermo 15 Settembre 2000. Si considera scherzosamente un «colpito dalla grazia», quella divina naturalmente. Papas Giovanni Festa, quarantanove anni, sposato, fisico asciutto, sguardo penetrante, è il parroco della chiesa ortodossa dedicata a San Marco di Efeso, a Palermo, in via Umberto Giordano 67. «Vengo da una famiglia cattolicissima – racconta –, mio padre era un tradizionalista fedele al concilio di Trento. Ho fatto parte di quella generazione di ragazzi che, subito dopo il Vaticano II, avevano aderito con entusiasmo alla cosiddetta Chiesa del dissenso. Il Concilio, infatti, aveva aperto orizzonti sterminati. Sono stato anche discepolo di don Giovanni Franzoni, il discusso abate del monastero benedettino di San Paolo, ed ho abitato a Roma nella sua comunità per due anni insieme a mia moglie». Tornato a Palermo, l’ancora laico Giovanni Festa aderisce ad un gruppo ecumenico di base, impegnato anche nel dialogo coi valdesi, e, nel 1980, si iscrive all’Istituto di scienze religiose della città che, dietro impulso del cardinale Salvatore Pappalardo, diventerà successivamente Facoltà teologica di Sicilia. Una delle più prestigiose istituzioni accademiche impegnate da anni nel dialogo interconfessionale e interreligioso. «Sono stati anni di grande attivismo e di magnifiche speranze – continua –. Allora c’erano nella Chiesa palermitana dei sacerdoti con una straordinaria preparazione teologica: Giovanni Bonanno, che poi ha lasciato il ministero in polemica con l’Istituzione; Gianni Avena che attualmente dirige l’agenzia di stampa cattolica Adista; e Nino Fasullo, il piccolo prete antimafia fondatore della rivista Segno, un uomo che non è mai indietreggiato di un passo». «Lentamente, però, si è scivolati nell’indifferenza. Il limite di quel tipo di esperienza era il suo appiattimento sul sociale, c’era ben poco spazio per la dimensione misterica della fede. In fondo questo è il destino dell’Occidente: non essere più capace di pregare». Continua a militare nel Pci, ma si allontana dall’attivismo religioso, pur continuando a studiare teologia. Comincia a leggere i Padri, i teologi cioè dei primi secoli, alternando quelli occidentali con quelli orientali, e riprende i testi relativi ai primi sette Concili ecumenici, ritenuti “fondamentali” per la dottrina cristiana. Questo studio, condotto in maniera solitaria, dura più di due anni. Nel 1985 avviene il “colpo di grazia”. «Incontro papas Gregorio Cognetti che, per vivere, insegnava biotecnologie cellulari all’università di Palermo». Anche lui, nato cattolico, aveva in seguito cambiato rito passando a quello bizantino, pur rimanendo fedele a Roma. In America, dove era andato per lavoro, si era infine convertito all’Ortodossia. Sempre per lavoro, si era trasferito a Zurigo dove aveva incontrato il vescovo Seraphim del Patriarcato di Mosca. Un giorno, dopo avergli chiesto di mandare un sacerdote a Palermo, si era sentito rispondere: «Non ho nessuno da inviare, ordino lei». Tornato in Sicilia nel 1984, fonda a Palermo la prima parrocchia ortodossa. «Quando ho conosciuto Cognetti non ero ormai più nulla. Ho scoperto presto che ciò che cercavo era lì, nella grande tradizione delle Chiese d’Oriente». Nell’ottobre del 1985 viene ricevuto nell’Ortodossia o, più tecnicamente, “ritorna alla retta professione di fede”, quella senza il “Filioque”. Subito dopo diventa diacono e lo rimane per tredici anni lavorando a fianco di Cognetti. Nel 1998 quest’ultimo muore a causa di un tumore al cervello. Il vescovo russo ortodosso di Parigi, Gurìa, scende in visita pastorale e, dopo quaranta giorni, avendo ricevuto il parere favorevole della piccola comunità palermitana, gli annuncia che il 21 giugno del 1998 sarebbe stato ordinato a Parigi. Nello stesso anno, per un accordo fra il Patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli, la Sicilia passa sotto l’obbedienza di quest’ultimo. «Nella mia parrocchia ci sono settanta italiani “ritornati” e molti greci, rumeni, russi ed eritrei. È una comunità che, con l’aumentare dell’immigrazione da parte dei Paesi dell’Est europeo, s’ingrossa ogni giorno di più. Noi non facciamo proselitismo, ma accogliamo chiunque si avvicini e lo aiutiamo a fare discernimento. Interesse? Sì, ce n’è tanto perché l’Occidente ha una grandissima sete di spiritualità».
7. Scuole cattoliche e portatori di handicap 27 Dicembre 1998. Se siete credenti e fate i bravi andrete un giorno in paradiso. Ma se la provvidenza vi ha donato un bambino che consuma la vita su una sedia a rotelle, allora dovrete passare già in questa terra le pene dell’inferno perché nessuna scuola cattolica accoglierà mai vostro figlio. Le scuole fedeli ai dettami di Santa Romana Chiesa sono infatti territorio off-limits per tutti gli studenti e i docenti disabili. Solo sei di esse sono provviste di scivoli e, di queste, non più di tre sono munite di bagni adatti. Inoltre, nessuna prevede la figura dell’insegnante di sostegno. «Non prendiamo alunni con marcati handicap fisici – spiega suor Maria Stella Noto direttrice dell’istituto Maria Mazzarello di via Sampolo – perché i loro compagnetti potrebbero imitarli ed assumere così atteggiamenti errati. Per lo stesso motivo – aggiunge –, non abbiamo insegnanti disabili, darebbero il cattivo esempio. Noi – conclude – vogliamo solo giovani fisicamente sani perché è ad essi che si rivolge il nostro progetto educativo scolastico». Dello stesso tono, ma con qualche piccola variazione sul tema, è la risposta della sua consorella salesiana, suor Maria, dell’istituto di via Giovanni Evangelista Di Blasi: «La nostra è una scuola normale – afferma perentoria la religiosa – e poi, onestamente, il problema è soprattutto economico. Gli handicappati costano troppo in maestre di sostegno». Uguale giustificazione, quella di ordine economico, viene anche da altre scuole rette da preti e suore. Ad esempio, dal Gravina di via Pecoraro, dalle Figlie di Sant’Anna di via d’Ossuna e di via Brancato, dall’Opera Pia Pignatelli di via Florio e, infine, dall’istituto dei Sacri Cuori di corso Calatafimi le cui religiose, in compenso, assicurano le loro preghiere anche per i disabili in età scolare. Ma ci sono anche quelle animate più da buona volontà che da reale competenza. Le sorelle del Sacro Cuore, sito nell’omonima piazza alla Zisa, si dichiarano, seppure con qualche incertezza, pronte ad accogliere un handicappato perché, come dice la superiora, suor Bordoni: «Abbiamo già una bambina albanese e le abbiamo dato veramente tanto amore che adesso parla anche l’italiano». Quale nesso vi sia fra un disabile ed un albanese non ci è dato ahimè saperlo. L’analogia, però, è inquietante. Seguono le religiose del Sacro Cuore del Verbo Incarnato di piazza Cascino che, «con il cuore in mano» dicono, non possono proprio accettare «nessuno fisicamente svantaggiato» perché, come si giustifica un’anonima consorella: «Siamo suore di carità, ma non sino a questo punto!». Poi vengono le consacrate con il senso dello humour, come le Figlie della Misericordia e della Croce di via Di Blasi, che non hanno scivoli, «ma solo giostre e giochi per bambini “normali”». Forse sarà una battuta che gira nell’ambiente, ma la stessa cosa avevano detto, in un primo momento, anche le sorelle del Sacro Cuore, quelle dell’albanesina, per capirci. Una secca, spesso irritata mancanza di disponibilità all’accoglienza dei disabili, senza la necessità di giustificazione o motivazione che sia, arriva, invece, dalle Ancelle Riparatrici di via Sampolo, dalle monache di Maria Santissima del Rosario di via Ingrassia, dal Santa Lucia di via Principe di Belmonte e, infine, dal Collegio di Maria della Purità di via San Lorenzo Colli. Viene poi il gruppo delle risposte diplomatiche. «Se ne può parlare» per il Ranchibile di piazza Don Bosco e per l’Imera di via dei Normanni. Ma nulla di più. Sottile, infine, e letteralmente degna di un gesuita è la posizione del rettore del Centro Educativo Ignaziano (l’ex-Gonzaga): «In linea di principio saremmo anche aperti ad una prospettiva di questo tipo. Non abbiamo, infatti, mai avuto richieste del genere». E in pratica, si o no? «Se ne può parlare – risponde il seguace di Sant’Ignazio – per l’anno prossimo. Senza, però, dare speranze a nessuno». Concludendo, sorge ancora una domanda: pensiamo davvero di dare denaro pubblico alle scuole private? In linea di principio sì, in pratica se ne può parlare per il prossimo anno, ma senza dare speranze a nessuno. Si potrebbe facilmente replicare. Storia di Noemi Capelli ramati, occhi color nocciola, mobilissimi, ed un corpo che è una foglia di carne adagiata sulla carrozzella. Ha quarant’anni e da quindici è prigioniera del “grande male”, come lo chiama lei, la sclerosi multipla. Una malattia che isola proporzionalmente all’avanzare dell’immobilità. Per paura – terrore di una solitudine ancora più grande, di essere segnata a dito, di ricevere l’ostracismo dalla sua famiglia e dalla comunità cristiana –, non vuole che si sveli il suo nome. La chiameremo Noemi, dalla pelle di luna, e in lei vedremo tutti quei figli di un dio minore, figli non voluti di una Chiesa che li costringe al silenzio e che permette loro solo di essere periodicamente oggetto di una carità pelosa. Figlia di genitori «cattolicissimi e benestanti», – il padre è un colletto bianco della pubblica amministrazione – Noemi ha anche uno zio prete, di quelli in carriera, dice lei, ma che non è mai andato a trovarla. In forte polemica con la fede dei suoi che, racconta, «in una mano tengono il rosario e con l’altra cercano la stretta dei potenti», decide, diciassette anni fa, di sposarsi in municipio. È lo scandalo. Due anni dopo, partorendo una bambina, ha una fuoriuscita di midollo, ma nessuno se ne accorge. Comincia a star male. «Soffrivo come un cane – ricorda –, non riuscivo più a lavorare, a stare in piedi. Tutti pensavano che fossi impazzita o, addirittura che avessi l’Aids, perché i primi sintomi facevano pensare a questo». Qui inizia il calvario di Noemi, una via dolorosa che ancora non è terminata. Il marito, perché «il rapporto cominciava a diventare per lui troppo impegnativo», la lascia. La bambina le viene tolta dai suoi genitori. Rimane sola a casa, immobile, distesa, stordita dal dolore. «In quell’abisso di sofferenza – racconta – mi sono chiesta se tutto ciò avesse un senso, se su questo lago nero di sterminato dolore aleggiasse lo spirito di un dio». Ormai non è più autosufficiente e non le rimane che andare in una comunità. Lì incontra Alberto (anche il suo nome è d’invenzione), s’innamora di nuovo. «Pensavo di ricominciare a vivere, come se un nuovo amore potesse avere la forza di scuotermi dalla mia immobilità, di rianimare ciò che in me era morto. Credevo in una sorta di riscatto perché avevo qualcuno con me», dice Noemi. Ma lui è il figlioccio di un importante sacerdote palermitano, un “prete di frontiera”, di quelli che girano con la scorta e confezionano continuamente infuocate filippiche antimafia. E il padre spirituale, il chierico coraggioso che combatte Cosa nostra, non approva la storia di Alberto con una divorziata. Così, un giorno, arriva persino a minacciarla per dissuaderla dal continuare quel rapporto. «È facile “convincere” chi si trova in una condizione come la mia», commenta. Il male avanza, la sua immobilità è sempre maggiore. Non sopporta più di stare in comunità. I genitori, dopo tante sue insistenze, la portano a casa loro. «Vivo con i miei, perché non posso fare altrimenti. Nelle comunità ti trattano come una bestia o ti sbattono insieme ai vecchi – spiega –. Io lo so che i miei genitori si vergognano di me, che pensano a me come ad un peso. La domenica vanno a messa ma non mi portano mai con loro. Poi, non mi passano mai le telefonate e chiudono a chiave le stanze. D’estate vanno per tre mesi in vacanza e mi lasciano a casa da sola. Allora, devo cercarmi un ospizio a buon prezzo, alla portata della mia pensione». «Mio padre – continua – un giorno me l’ha detto chiaro che lui mi dà solo un tetto e i pasti, per il resto mi devo arrangiare. Un altro giorno, infine mia madre mi ha pure rimproverata. “Perché non te ne stai tranquilla come tutti gli altri handicappati in un angolo a guardare la tv e finisci di rompere le scatole?”, mi ha gridato. Ma io non muoio da sola, mi devono ammazzare!». E la comunità ecclesiale come si comporta con te? «L’unica cosa che mi hanno detto quando ho cercato d’inserirmi in parrocchia – risponde – è che Dio mi ha punita perché non mi sono sposata in chiesa e che adesso non ho diritto a sperare in una vita normale ma devo portare con pazienza e gratitudine la mia croce. Io non ci credo in questo Dio dal volto feroce che si accanisce contro le sue creature per punirle e glielo ho detto. Si sono offesi ed ora si fanno vedere solo per feste, per sentirsi buoni. A me – conclude sorridendo – il loro Dio non serve più, il mio è più grande».
11 Aprile 2000. Il bambino dice che non ci trova niente di male a “fare le fiche” con le mani. Se le suore, che lo assistono per il doposcuola, lo riprendono, assume l’aria innocente dei suoi sette anni e replica: «Ma perché, che significa?». Piero (ma si potrebbe chiamare anche Ignazio o Paolo) lo sa però che quelle dita aperte quasi a forma di rombo sono «una cosa sporca», come dicono le monache, o «porca» come invece la definisce suo fratello «più grande», che glielo ha insegnato. Piero frequenta le elementari in una di quelle scuole da quartiere degradato che nessuna riforma sarà mai in grado di cambiare. Sua madre, Maria, si arrangia come può, andando a fare le pulizie nelle case dei signori e mendicando qualcosa alla Caritas o in parrocchia, perché suo padre, Saverio, come scherzano i vicini, «fa entra ed esci dalla galera». Niente di serio, naturalmente, solo piccoli furti, qualcuno con scasso. L’ultimo l’ha fatto in un appartamento nella parte “bene” della città. Ma i carabinieri lo conoscono. Ogni volta lo vanno a prelevare a casa all’ora di pranzo, anche se, racconta il bambino, lo lasciano sempre finire di mangiare. Piero ha due fratelli, anzi un fratello maggiore di sedici anni, Carmelo, disoccupato che fa qualche “lavoretto” ogni tanto, «ma non l’hanno mai preso», e una sorella, Mary, di diciotto già sposata con un figlio, Jonny, «perché ha fatto la fuitina». A scuola ci va «perché lo dice la legge – si giustifica –, altrimenti arrivano gli sbirri e se la prendono con mia madre». Ma né lui né i suoi docenti, quasi dei forzati all’insegnamento, credono che serva a qualcosa. «Tanto – spiega – appena mi piglio il pezzo di carta smetto». Una volta una coppia di volontari, che frequentano l’istituto delle suore dove passa i pomeriggi, hanno chiesto il permesso a sua madre per fargli passare il giorno di Natale a casa loro, quasi fosse un orfano. Sua madre glielo ha dato perché, dice Piero, gli vuole bene ed è rimasta a mangiare sola a casa, quasi non avesse più un figlio. Ha passato, ricorda, una bella giornata perché la casa era «caldissima», aveva il pavimento di legno, non c’erano spifferi e tutto era «bellissimo». La mamma di uno dei volontari era «bellissima» coi capelli «biondissimi» e gli occhi «come il mare». Tutti gli volevano bene quel giorno e non c’era suo fratello che puzzava di vino e sudore, e non c’era sua madre con gli occhi tristi che lo guardava. Piero ha imparato, in quella occasione, che ci sono persone con tanti soldi che parlano a bassa voce, che guidano auto lucide e grandi e che lasciano il mangiare nel piatto. Ma non ha capito perché. Allora, quando la sera è tornato da sua madre, dalle spalle curve e le mani callose, dentro di sé ha sentito montare la rabbia. Adesso, ogni volta che vede passare per strada una signora ben vestita e che sa di pulito, la chiama e le fa le “fiche” con le mani. Davvero non lo sa cosa significhi, ma guardando le loro facce lisce e vedendole accigliarsi, pensa in questo modo di passargli un po’ della sua rabbia. Qualcuna ogni tanto gli sussurra fra i denti: «Malacarne».
15 Aprile 2000. Non si ricorda più nemmeno quando ha iniziato. Gli sembra di averlo sempre fatto. Di essere sempre andato per la strada, la notte, a cercare negli scrigni che si aprono col pedale ciò che gli altri di giorno buttano via. Non ricorda nemmeno il suo nome. Non ricorda di avere mai avuto una famiglia, un lavoro, una casa. Neanche le persone, che la sera lo incontrano ogni volta carico di sacchetti, ricordano il momento in cui è comparso per la prima volta al loro cospetto a cercare fra i resti dell’esistenza di ognuno. Un giorno un signore distinto di un quartiere distinto gli ha urlato da lontano qualcosa. Era il suo nome: Totò Munnizza, si chiamava. Totò ha una barba bianca, lunga e incolta, striata di nero. L’alito gli puzza sempre d’alcol, ma ha lo sguardo sveglio del sobrio. Cammina curvo, trascinando i piedi nelle scarpe rotte e le buste coi suoi poveri averi. Ha un impermeabile come quello del tenente Colombo, sempre stretto con una corda alla vita. Nessuno ricorda di averlo mai visto aperto. È sempre lo stesso, d’inverno e d’estate, ma sempre più scuro. Totò parla poco e lancia lunghe occhiate di sbieco a chi gli si avvicina. Una volta le suore vestite da indiane lo hanno portato nel loro convento per ripulirlo. La sera però lo hanno ritrovato con le mani tuffate in un bidone nero ricolmo degli scarti della cucina a cercare la cena, così diceva. Chi gli voleva dare qualcosa doveva prima metterlo in una busta e poi chiuderla con un nodo. Passava le giornate sprofondato in una poltrona in un angolo. Adesso è normale, pensavano le sorelle e gli altri volontari di buon cuore. Ma una sera, quando sembrava ormai rimesso, caricato di spazzatura che sosteneva di voler gettare fuori nei cassonetti, è fuggito, raccontano, con la sua refurtiva. Qualcuno dice di averlo visto aggirarsi in un quartiere dormitorio della periferia perché, ha spiegato con gesti e mezze parole, la gente povera mangia di più e lascia più roba. Totò sostiene che non gli manca nulla. La notte, dopo la “caccia” serale, dorme con una buona bottiglia per tenersi compagnia nei cartoni che gli fanno di volta in volta da letto, da ombrello e da tutto quello che serve. E va in posti sempre diversi della città. Perché non vuole farsi prendere dai teppisti e dalle persone che dichiarano di volergli bene. E quando parla di morte, lo fa toccandosi sempre prima nei “posti giusti”. Dice che vuole adagiarsi in una bara d’argento. Una qualunque, una di quelle disseminate per la strada. Allora capisci che pensa ad un cassonetto d’alluminio. Se gli chiedi il motivo, risponde che il coperchio lo vuole abbassare lui come fa la gente quando butta qualcosa. Perché, in fondo, anche Totò si considera un rifiuto.
10. Quel benedetto posto fisso 27 Gennaio 2000. Se ci fosse un premio per gli stacanovisti dei concorsi pubblici, Giovanni, ventitre anni, e Vincenzo, ventisette, entrambi palermitani, di sicuro l’avrebbero già vinto e ben più d’una volta. Qualche settimana fa, a Milano, per i cento posti di vigile urbano c’erano anche loro fra 2621 candidati provenienti da tutta la Penisola. Per Giovanni è stata anche l’occasione per festeggiare un personale record: ben cinquanta concorsi affrontati (naturalmente nessuno vinto) in meno di cinque anni, alla media di uno ogni mese. Poi c’è Vincenzo, anche lui vicino a quota cinquanta, che ha cominciato a fare gli esami a concorso all’età di diciassette anni. Nel frattempo, però, non stanno con le mani in mano. Fra un concorso e l’altro, Giovanni, oltre a sgobbare sui libri, lavora nello studio tecnico del padre. E Vincenzo, per pagarsi le spese delle numerose trasferte, pulisce una chiesa della città guadagnando 25 mila lire al giorno. «Ogni volta che si parte – spiega Vincenzo – bisogna mettere in conto una spesa 6-700 mila lire. E se si superano i quiz, le spese raddoppiano perché si deve fare un altro viaggio. Insomma, si spende in media un milione per ogni concorso». Le spese, naturalmente, salgono quando i candidati vengono accompagnati da qualche familiare, come succede alle ragazze del Sud che difficilmente percorrono il continente da sole. Come nel caso di Rosanna, arrivata anche lei dalla Sicilia a Milano per il posto di vigile urbano, che si muove spalleggiata dalla madre Angela. Grandi sacrifici, quindi, anche economici, inseguendo il miraggio del posto fisso e dello stipendio il 27 del mese, di ogni mese. Cinquanta milioni spesi da ognuno di loro, alla media di dieci milioni all’anno. Con la stessa cifra e una buona idea altri avrebbero già messo su una piccola azienda e adesso viaggerebbero solo per diletto o per affari. Qualcuno nella loro stessa città e con molto meno, l’ha già fatto.
7 Gennaio 2000. Ogni mattina, all’incrocio fra le vie Leonardo Da Vinci e Regione Siciliana trascinandosi su un paio di vecchie stampelle, Ignazio, la pelle scurita dal sole e una folta barba incolta, nello spazio di un semaforo vomitava sull’automobilista disposto ad ascoltarlo, un’accorata e interminabile geremiade. Le gambe irrimediabilmente rovinate cadute da un ponteggio quando ancora «il Signore» gli dava «la grazia di lavorare»; una moglie confinata sul letto a causa di una malattia che «nessun medico aveva capito che cosa era»; una sfilza di figli che non conoscevano il conforto delle scarpe e ognuno con una personale disgrazia cucita addosso; una casa fatiscente che «può cadere da un momento all’altro» e, infine, una madre cieca costretta ad una misera vecchiaia. «Neanche la dentiera – gemeva – le ho mai potuto comprare». Nel giro di pochi minuti, Ignazio riusciva a tal punto a coinvolgere l’automobilista nella sua sventurata saga familiare che, quasi sempre, questi decideva di aiutarlo economicamente. C’era anche chi, vedendolo e già conoscendo le personali disgrazie di quello storpio, allungava automaticamente una banconota e s’informava sulla salute della moglie e su quella dei bambini. Poi lentamente gli affari sono peggiorati. «La gente – spiega Ignazio – col tempo si stanca. Finisce di commuoversi e gli viene il sospetto che tu li prenda in giro. Allora, o cambi zona, ma non è una buona soluzione perché le persone girano e le incontri sempre, o offri, diciamo, un altro prodotto». Così, un giorno, si è tagliato la barba, ha cominciato a vestirsi meglio e ha appeso le stampelle al chiodo. Ora cammina bene, la madre vive in un ospizio e ha ancora tutti i denti, sua moglie sta benissimo e si arrangia facendo pulizie, i figli vanno a scuola e gli danno delle soddisfazioni. Adesso vende un po’ di tutto: giornali la mattina, primizie quando viene la stagione, fazzoletti di carta, accendini. Ignazio sostiene che questo è il “mercato”.
8 Aprile 2001. Massimo Saputo, ventiquattro anni, siciliano, nato a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, una località nota per avere dato i natali al boss mafioso Giovanni Brusca, scolpisce e modella, ma con una mano sola. La sinistra. L’altra l’ha persa a nove anni nella macelleria del padre. «Giocavo – racconta – con quel mostro di metallo che emetteva un rumore che mi stregava. Mi sembrava un’astronave. Ero incantato dai riflessi argentei che mi abbagliavano. Ero solo nel negozio di mio padre. È bastato poco per trovarmi in un lago di sangue, tramortito da un dolore mai provato prima». È ancora un bambino. Per lui, dicono i medici, non c’è più alcuna speranza. Deve rassegnarsi a vivere con una mano sola. Impara una parola nuova che sente ripetere ai suoi vicini, ai parenti, ai maestri, ai suoi compagni di gioco. Una parola che in casa nessuno userà mai: handicap. Per molti, infatti, Massimo è un handicappato. Un’espressione che marchia, isola, suscita sguardi di pietà. Che fa sorridere i suoi docenti delle medie quando lui comunica che “da grande” vuole fare il pittore. Poverino, avranno pensato, ancora non ha capito di non essere “normale”. Ma lui continua a disegnare, a dipingere. «La mia prima sfida l’ho vinta alle medie – ricorda – quando sono diventato il più bravo nel disegno tecnico. Una follia maneggiare le squadrette e la riga con una sola mano. Loro però non sapevano che mia madre mi aveva insegnato che, se volevo, nulla per me era impossibile». Carattere inquieto, sensibilissimo, dopo la scuola dell’obbligo s’iscrive ad un corso professionale d’informatica. Un’altra sfida ingaggiata e vinta: battere sui tasti più veloce dei suoi compagni. «Non volevo lavorare coi computers – spiega –, mi bastava solo conseguire un altro obiettivo: far capire ancora una volta agli altri che ero normale. Che potevo meglio anche degli altri fare le cose che facevano tutti». Raggiunto il suo scopo, abbandona la scuola e va a lavorare come segretario di un imprenditore edile. È lì che comincia a studiare i materiali da costruzione. Che impara a conoscerne consistenza, resistenza, durezza. «Nei momenti liberi, ho iniziato a dedicarmi al restauro di vecchi mobili che trovavo abbandonati nelle case di campagna. Il legno è molto morbido, ma ho scoperto che lo erano anche il tufo e che l’argilla era piacevole da modellare. Insomma, di giorno scorrevo fatture e rispondevo alle telefonate e di notte imparavo a scolpire con strumenti forse inadeguati: un coltello, una lima, della carta vetrata». Per Massimo è un’altra sfida. In casa lo comprendono. Lo incoraggiano. Un suo fratello poliziotto, Alessio, scolpisce nei momenti liberi già da tempo. Un’altra sua sorella, Aurora, la più piccola, è iscritta all’Accademia di belle arti. E in famiglia ci sono anche altre vocazioni artistiche. Salvatore, il primogenito, ad esempio, fa l’attore di teatro. Prima insieme a pochi amici quasi per gioco, adesso per professione. «All’inizio mi vergognavo delle mie cose. Volevo mostrare ai miei dei lavori perfetti. Non solo delle prove di buona volontà. Sperimentavo tecniche, materiali. A poco a poco, ho scoperto che la mia vera vocazione era la lavorazione dell’argilla e mi sono dedicato solo a quella. Ho imparato a fare a meno degli strumenti. Ho inventato una tecnica che mi ha permesso di lavorare con una mano sola». Ma non c’è solo la passione per l’arte nella vita di Massimo. Ci sono anche i numerosi amici. Perché lui non è uno che si piange addosso. Gli piace far ridere la gente, organizzare. «Problemi con le ragazze non ne ho mai avuti. Innamorarsi e fare innamorare è una questione di anima, non di mani», taglia corto. «Naturalmente non pensavo di fare l’artista per mestiere. Il mio era un amore-odio privato con la materia». Dopo qualche anno, cambia occupazione. Le sue conoscenze informatiche gli si rivelano utili per entrare in una grande azienda telefonica. Ma nei fine settimana continua a rifugiarsi nel suo piccolo laboratorio e a creare, sperimentare. «Ogni nuovo lavoro, ogni nuova tecnica per me era ed è una sfida da vincere, un ostacolo-handicap da superare». Nonostante i risultati, sempre più apprezzati dalla cerchia dei conoscenti e dei familiari, però, Massimo soffre dell’isolamento tipico di chi vive in provincia. Non ha nessuno con cui confrontarsi, nessuno del mondo artistico a cui mostrare le sue opere. Il suo è un percorso solitario. Due anni fa arriva la grande occasione. Viene assunto come assistente da un grosso centro regionale di riabilitazione per disabili. Il suo compito è quello di realizzare progetti di inserimento nella vita sociale per tanta gente “diversamente abile”, gli spiegano, che altrimenti ne rimarrebbe esclusa. Presso il centro conosce anche una ragazza, Lucia, di origine italiana, ma laureata a Strasburgo, che è lì con una borsa di studio. Compagna nel lavoro, lo è diventata in seguito anche nella vita. «Girando, vengo quasi assalito, catturato da nuovi stimoli artistici. Vengo colpito in particolare dalla tristezza degli abitanti del vecchio continente. Ricchi, ma morti dentro. Per me diventa un’immagine ossessiva che non riesco a non trasformare in qualcosa di concreto: quadri, sculture… Oggetti che creo ancora per me e adesso anche per Lucia». Ed è proprio quest’ultima che lo introduce – durante uno dei loro sempre più frequenti spostamenti – a Siviglia, in Spagna, nel mondo artistico progressista e antifranchista. «Ho conosciuto gente straordinaria con la quale finalmente confrontarmi. Gente che mi ha incoraggiato a dedicarmi esclusivamente all’arte senza più perdere tempo con altre cose». Nella penisola iberica, Massimo rimane per un’intera estate e, aiutato dai suoi nuovi amici, lavora ad una personale di sculture che hanno a tema la “rivoluzione sociale” della Spagna dopo Franco. Il lusinghiero successo dell’impresa lo spinge a dare una svolta alla sua vita. Da qualche mese, infatti, vive con Lucia a Lussemburgo e lavora a pochi chilometri di distanza, a Gent, in Belgio, in un atelier di artisti provenienti da tutta Europa, ma in prevalenza dall’Italia. «Adesso mi dedico soprattutto alla manipolazione dell’argilla. Mi sono un po’ specializzato». «La pittura? L’ho abbandonata ormai, diciamo che ci ho perso la mano», dice sorridendo.
25 Maggio 1999. Gaetano ha solo otto anni, dei pantaloncini blu sdruciti, una canottierina a coste che un giorno, forse non lontano, fu bianca e indossa un paio di guantoni rossi, troppo grandi, che gli arrivano quasi ai gomiti, ma picchia duro contro il sacco di sabbia. Sogna di diventare un pugile famoso, uno di quelli che guadagnano «un mare di soldi», che hanno le foto sui giornali e abitano in grandi case colorate con il prato intorno. Gaetano si allena ogni giorno per un’ora, dopo aver finito i compiti, in una piccola palestra di via Della Ruota, al Capo, ma non è il solo. Con lui altri venti ragazzi, fra i dieci e i diciotto anni, ogni pomeriggio s’incontrano per boxare, imparare quella che una volta si chiamava «la nobile arte» e sognare una vita diversa in un quartiere in cui la povertà più che essere una condizione è spesso una malattia ereditaria, che si tramanda di generazione in generazione. Ad allenarli c’è Salvatore Micale, cinquantasei anni, capelli brizzolati, un po’ stempiato, una passione forte per il pugilato e la sua gente, che lo ha spinto a mettere da parte per anni i soldi degli straordinari – è operaio alla Fiat di Termini Imerese – e a tirar su dal nulla, tre anni fa, una palestra, la Polisportiva Santa Maria di Gesù, nella canonica di una chiesa dedicata a Sant’Onofrio, con ring regolamentare, pesi e sacchi di sabbia. «La boxe è come le donne – dice Salvatore –, o ci s’innamora a prima vista o niente, non ci sono vie di mezzo. Sono entrato per la prima volta in una palestra a tredici anni per accompagnare un amico più grande – racconta – e da allora non ne sono più uscito. A quattordici anni e mezzo ho fatto il primo incontro e non mi ricordo più neanche se l’ho vinto o perso, quanto tempo è passato, – sorride – erano gli anni Cinquanta e c’era la fame. Io lavoravo di giorno e la sera mi allenavo, quando dovevo combattere mi davo malato, per questo motivo sono stato anche licenziato due volte. Talvolta – continua – tornavo al lavoro ammaccato e dovevo inventare un sacco di scuse per giustificare i lividi». Poi son venuti il matrimonio, i figli e la necessità di non rischiare il posto di lavoro. Salvatore Micale è costretto ad appendere i guantoni al chiodo, ma continua ad allenarsi ogni sera, organizzare piccoli tornei e frequentare l’ambiente. Un giorno un amico, che gestisce una palestra a Bagheria, gli chiede se gli va di dargli una mano ad allenare qualche ragazzo che promette bene, accetta. Comincia quella che lui stesso chiama la «fase due» della sua vita sportiva. «Ho scoperto – dice – che questo modo di vivere la boxe mi piaceva di più. Allenare un adolescente, infatti, è anche in un certo senso educarlo, accompagnarlo in un tratto di strada che è o è stato, in fondo, il più difficile per tutti. E in questo senso – continua –, la boxe è una scuola straordinaria perché t’insegna ad autodisciplinarti, a controllare la tua aggressività, ad imparare a studiare chi hai di fronte per indovinare le sue mosse. Insomma, ti sveglia». Un pomeriggio, poi, mentre torna a casa dal lavoro, si ferma ad osservare due ragazzini che mimavano a fare i pugili, non si scambiano pugni, stanno immobili l’uno di fronte all’altro e cercano di anticipare, parandosi con le braccia, i colpi del compagno. «Una tecnica quasi perfetta – ricorda –, quei due erano dei veri boxeurs. Il campione, infatti, non mira a far male all’avversario, ma a dimostrargli con l’agilità dei movimenti la sua superiorità. Ho pensato: peccato che nessuno si accorgerà mai di questi due, magari potrebbero anche sfondare. Non ci ho dormito la notte. La mattina dopo – conclude –, avevo già deciso, cercai un locale e misi su una vera palestra tutta per loro, per levarli dalla strada, per non fargli venire strane tentazioni e per invogliarli e, per favorire le famiglie, non ho mai chiesto una lira». Adesso Salvatore ogni pomeriggio, alle cinque, scende da casa e va ad aprire il locale della vecchia canonica dove s’insegna la «nobile arte», dietro di lui una torma di ragazzini spinge e si precipita dentro a sognare di essere Rocky Balboa che non ha paura di nessuno, sconfigge i malvagi e abita in una grande casa colorata con il prato intorno. E chissà che un giorno la favola per qualcuno non si avveri.
Ottobre 2001. Una manciata di case gettata sulla catena montuosa siciliana delle Madonie, poche migliaia di anime un tempo dedite quasi esclusivamente alla coltivazione e alla raccolta della manna. Castelbuono, un centro che dista poco più di cinquanta chilometri da Palermo, oggi è una località segnalata in quasi tutte le guide turistiche soprattutto per il suo magnifico castello da poco restaurato, i ristoranti rustici e i suoi alberghi. Ma non solo. Nell’articolata geografia religiosa dell’Isola il piccolo comune madonita è da tempo noto anche come vivaio di vocazioni alla vita consacrata. E, in particolare, per una speciale forma di quest’ultima: quella eremitica. C’è infatti una lunga tradizione di uomini in fuga dal mondo e gelosi della propria solitudine. L’ultimo in ordine di tempo è un giovane di poco più di trent’anni, minuto, il volto scavato, gli occhi piccoli e accesi, una folta barba e i capelli rasati. Quasi raggomitolato nel suo abito di panno rozzo, sembra emergere da un’altra epoca. Si chiama frate Rosario Leonarda, è originario della stessa Castelbuono e vive in un piccolo eremo in pietra viva ai margini del paese messogli a disposizione dal vescovo di Cefalù. Ci accoglie in una stanzetta buia. «La luce non ce l’ho – ci dice subito –, dobbiamo aspettare che si alzi il sole». All’interno qualche candela, un letto di assi, un tavolo con sopra un cucinino e, accanto a questo, una radio. «Ascolto solo Radio Maria» si giustifica. Poi s’informa: «Siete venuti per parlare? No? Dovrei raccontarvi la mia vita? Ma a chi può interessare? È una vicenda normale come tante altre». Lo convinciamo che è piuttosto singolare che, nell’era della comunicazione globale, un uomo decida di vivere da solo tagliando i ponti con la società. «Se pensate che possa aiutare qualcuno ad avvicinarsi a Dio, allora va bene: vi racconto la mia storia». Nato nel maggio del 1967, ultimo di sei figli di una famiglia semplice e contadina, in paese lo descrivono come un bambino sveglio e vivace. Come molti suoi coetanei, dopo le medie, frequenta l’istituto alberghiero. «A diciotto anni ho fatto la prima esperienza presso un convento di frati». Poi i ricordi si fanno più confusi, nel racconto del “piccolo eremita” qualcosa non quadra. Parla di due anni di permanenza a Corleone nel noviziato dei Francescani rinnovati, ma non sa collocare con precisione il periodo nel tempo. La gente di Castelbuono racconta, invece, la storia di un giovane allegro partito come volontario per il Libano, durante il servizio militare, e tornato, qualche anno dopo, con uno sguardo spento, attraversato da strane visioni di morte. La gente parla ancora di un giovane tornato vecchio, rimasto per mesi segregato in silenzio a casa sua e partito all’improvviso una mattina, quasi di nascosto, per farsi frate. «Mentre ero a Corleone – riprende Rosario, – mi sentivo chiamato a vivere con Dio nella solitudine. Ma non è come pensano le persone che si entra in monastero e si decide. È necessario fare un lungo discernimento per capire cosa Dio vuole da noi». Alla vigilia dei voti, decide di uscire dal convento. Va allora in Svizzera a lavorare per qualche anno come cuoco. «Avevo bisogno di chiarirmi le idee», spiega. «Per chi ha vissuto in un ambiente protetto come una comunità religiosa, il mondo è una giungla violenta. Lavorando, però, ho riscoperto la realtà della vita materiale, ho imparato che nella fatica d’ogni giorno è possibile incontrare Dio». Nel 1991 altra decisione apparentemente repentina. Si licenzia e torna a casa. «Me ne sono andato quando ho capito che la mia esperienza lì era finita. Sono cose che senti, è inutile spiegare come avvengono», chiosa. Un giorno, passeggiando per i boschi che circondano il paese, incontra frate Gabriele, un eremita figlio di un diplomatico argentino in Italia che, dopo aver passato più di dieci anni sepolto in un monastero cistercense vicino Roma, si era stabilito in un piccolo rifugio sui monti a pochi chilometri da Castelbuono. «Rimasi subito affascinato dal suo ideale di radicalismo evangelico, – continua – ma avevo paura. Non mi sentivo pronto. Non sempre puoi fare quello che desideri. Ci sono tempi e momenti per ogni cosa. Quando il tempo è maturo, la cosa non ti costa fatica. Nella vita ho imparato che bisogna sapere attendere che i fiori sboccino da soli. Forzandoli, li si uccide solamente». Dopo un anno, torna un’altra volta in convento a Corleone. Ma lì capisce finalmente qual è la sua strada. Va, quindi, dal suo vescovo per chiedergli consiglio. «Monsignor Rosario Mazzola è un uomo molto buono e molto saggio. Mi affidai a lui e promisi nelle sue mani di essere povero, casto e obbediente per tutta la vita». Da allora vive nel piccolo eremo ai bordi del centro abitato. «Conduco una vita normale», dice. «Mi alzo alle otto. Sì, lo so è un po’ tardi. Prima mi ponevo il problema. Dopo ho pensato che, se anche dormo un po’ di più, Dio mi vuole bene lo stesso. O no?». Il resto della giornata lo dedica a fabbricare piccoli oggetti in legno o in gesso e a dipingere icone. «Lavoro dalle quattro alle sei ore al giorno se nessuno viene qui a trovarmi. Molta gente vuole che l’ascolti. Oggi nessuno ne ha più il tempo. In quanto alla pittura, ho imparato da solo osservando alcuni monaci. Le cose che faccio le regalo». Sul suo tavolo ci sono alcune tavolette e dei fogli incolonnati. Li prende e ci spiega la complessa esegesi delle figure sacre. Notiamo che i volti, stranamente, si assomigliano un po’ tutti e ricordiamo quello che la gente va dicendo in proposito su di lui. Qualcuno segnandosi narra, infatti, che una notte frate Rosario pregando ha parlato con Dio e l’ha anche visto… I fioretti di fra Rosario «Vivo nel presente, giorno per giorno. Il domani appartiene a Dio solo. Perché allora preoccuparsene?» «Leggo solo la Bibbia, le opere di Santa Teresa d’Avila e di San Giovanni della Croce. Da qualche tempo anche i mistici orientali. I documenti del magistero? Io non ne so di teologia, non li capisco…» «Quelli che nella Chiesa fanno carriera diventando magari vescovi o cardinali, quelli che in nome di Dio si arricchiscono morendo lordati di denaro… mi provocano solo compassione e misericordia perché hanno perso di vista l’unica cosa essenziale nella loro vita: Dio e il suo amore per tutti gli uomini. Sono stati abbagliati dalla gloria del mondo e dal demonio. Io non ho paura di giudicare chi si comporta così. Ogni cristiano, infatti, è chiamato a scegliere il bene e a scartare il male, anche nella Chiesa. E poi l’ha detto Gesù: non chi dice “Signore, Signore” è cristiano anche se monsignore o cardinale» «L’universo è nulla in confronto al mondo interiore d’ogni uomo, al suo cuore»
Ottobre 2001. Ogni sera fra Tommaso prima di coricarsi allarga le braccia e in un sospiro recita le parole del Cristo sulla croce: «Padre nelle tue mani consegno il mio spirito». Ma ogni mattina, da qualche anno, prima di iniziare la preghiera apre il breviario e, su un foglietto ripiegato all’interno, traccia a penna una piccola croce: è un giorno in più per servire Dio. Fra Tommaso Maria di Gesù – al secolo Pasquale Calvanese – nasce, ottavo di quattordici figli, a San Gennariello, frazione di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, il 13 luglio del 1908. «Non eravamo una famiglia benestante – racconta – ma in paese ci chiamavano lo stesso “i signori” perché mio padre era un impiegato del Comune». Un’infanzia in ogni caso contadina passata, sotto il torrido sole meridionale, ad inseguire rane lungo i fossi e mangiare fichi abbarbicati agli alberi. Di quell’età fra Tommaso conserva ancora il sorriso pronto dei bambini e uno sguardo vivace, a tratti quasi sognante. A diciott’anni entra nei Carabinieri a cavallo «per una ragazza che mi piaceva e che stava a Roma dove c’era la caserma», spiega. Fa velocemente carriera e, col grado di capitano, viene mandato nel Corno d’Africa «perché la Patria avesse anch’essa “un posto al sole”». Combatte, soffre caldo, fame e sete e uccide, anche. «Mussolini, che ha fatto in Africa e nel nostro Paese tante cose buone, regalava all’Italia l’Impero e il Papa, sorridente, benediceva i valorosi conquistatori del suolo africano», commenta con un filo d’ironia. Infagottato nel suo saio di sacco, incede adesso lentamente a causa dei troppi anni che gli curvano le spalle e nulla, in quel corpo appesantito, farebbe indovinare il passato da brillante ufficiale «sprezzante del pericolo», come era scritto nelle sue note personali, valoroso in guerra e amante delle belle donne dalla pelle color dell’ebano. «In quel periodo mi “distrassi” un po’. In patria avevo lasciato una fidanzata che avrei dovuto sposare al mio ritorno». Scoppiato il secondo conflitto mondiale, viene fatto prigioniero dagli inglesi in Somalia. Passa cinque anni (dal 1941 al 1946) recluso in un campo ufficiali a Londiani, in Kenya. «Allora – ricorda – mi dichiaravo “ateo praticante” e le mie letture si riducevano a qualche romanzetto sconcio. Ma nel campo non c’era affatto quel tipo di libri e così, un giorno, l’unica cosa che riuscii a rimediare fu una specie di biografia di Padre Pio da Pietralcina. Quella lettura mi cambiò l’esistenza e divenni cristiano. E se a metà della vita un uomo si pente, ritorna bambino». Tornato in Italia, nell’ottobre del 1946 si reca a San Giovanni Rotondo. «Ero curioso – dice – di vedere quel cappuccino di cui tutto il mondo parlava. Non credevo veramente alla sua santità e non avevo nessuna intenzione di farmi frate». La prima volta che s’inginocchia, per la confessione, davanti al beato di Pietralcina, padre Pio lo caccia. «Me ne volevo andare – continua – ma un amico mi convinse a riprovarci il giorno dopo». Così la mattina seguente si rimette in fila con tutti gli altri penitenti. Quando viene il suo turno, il padre lo guarda e lo gela con una domanda: «Ma pecché nun te fai frate?». «Che potevo fare?», quasi si scusa. «Divenni frate e cappuccino per giunta. A quei tempi i francescani cappuccini erano l’Ordine più povero e severo della Chiesa». Entra in noviziato e a quarant’anni si rimette a studiare. «È stata dura, la teologia non mi entrava proprio in testa, ma cosa non si fa per amore…». Dopo di allora rivede il santo cappuccino diverse volte e passa molto tempo accanto a lui. «Eravamo diventati amici e, poi, eravamo quasi compaesani, parlavamo sempre in dialetto». Sono gli anni Sessanta, arriva il Concilio Vaticano II e la Chiesa viene scossa fin dalle fondamenta nelle sue secolari certezze. Fra Tommaso, che ormai nell’Ordine è uno che conta, è amareggiato. «Ognuno ormai faceva quel che gli pareva. Con la scusa dell’aggiornamento e del rinnovamento era scomparsa la povertà e si erano determinate delle situazioni di fatto scandalose». Il religioso entra in una crisi profonda. Vorrebbe continuare a vivere la propria fedeltà alla Regola del Poverello d’Assisi, ma si rende conto che fra i cappuccini non è più possibile. Nel 1967 va da Padre Pio per chiedergli consiglio su una sua idea di fondare un ramo riformato della famiglia francescana. «Il beato – narra – mi accoglie e, senza farmi neanche parlare, mi dice: “Fai bene ad andartene, se non fossi troppo vecchio me n’andrei pure io”. Dopo abbiamo parlato a lungo del mio progetto ed è venuto fuori che il padre era stanco dei frati che gli intrallazzavano intorno e che si arricchivano alle sue spalle. Tutto questo lo faceva soffrire molto». Poco tempo dopo ottiene da papa Paolo VI l’autorizzazione per la fondazione di un nuovo Ordine. A Baida, vicino Palermo, in un conventino di vagoni ferroviari con accanto una chiesa di cemento e lamiera, dà vita ai “Frati minori rinnovati”. È il natale del 1972. Adesso i frati “poveri” – la loro Regola gli impedisce di accettare denaro – sono più di cento e predicano il vangelo degli ultimi sparsi fra Africa, America del Sud ed Europa. Ma, nonostante l’aspetto dimesso, fra Tommaso a suo modo conserva ancora il piglio del combattente. Atei, massoni, comunisti, protestanti, anticlericali e “laicisti” sono i nemici di una battaglia in difesa della Chiesa che lo porta, nonostante gli anni, a percorrere in lungo e in largo il Paese per tenere conferenze e partecipare a dibattiti televisivi. Dove non può arrivare personalmente, supplisce coi suoi libri d’apologetica (disciplina ecclesiastica che mira a difendere la Chiesa, la sua storia e la sua dottrina). L’ultima sua fatica è un corposo volume di settecento pagine che ha appena pubblicato, “Bibbia e cristiani a confronto” (Ed. Herbita). Il primo, Chi ha ragione?, lo ha scritto più di vent’anni fa ed è stato, per il suo genere, un discreto successo editoriale: più di diecimila copie vendute. E se qualcuno gli fa notare che i mea culpa del Papa sui crimini dei cattolici si susseguono ormai ad un ritmo sempre più incalzante, fra Tommaso risponde che lui è il Santo Padre e fa quello che vuole, ma che la Chiesa non ha mai peccato e mai avrebbe potuto farlo perché è santa e immacolata. Inquisizione, crociate, roghi, cacce alle streghe e tutte le altre leggende nere non sono altro che menzogne inventate dai soliti nemici di Cristo. E sembra, nella sua buonafede, uno di quei soldati che difende una trincea dimenticata in una guerra che nessuno vuole più combattere. È un uomo fuori dal mondo, questo frate dai modi gentili, che nulla sa di politica e di ciò che accade fuori, nella città degli uomini. Che, anche quando viaggia o cammina per strada, sgrana in continuazione il suo rosario d’ossi d’olivo e non guarda mai nessuno in faccia. Ma è stanco fra Tommaso, i novantré anni, seppur portati splendidamente, pesano e oggi anche parlare, raccontare e ricordare è per lui faticoso. Ha bisogno continuamente di riposare, di sedersi per riprendere fiato. Dietro il suo conventino di vagoni il sole s’inabissa lentamente in un cielo in fiamme. È l’ora del tramonto. La campana della piccola chiesa suona per chiamare i religiosi alla preghiera. Il frate si avvia lentamente. Poi, ad un tratto, si gira verso di me e mi sussurra, quasi fosse una confidenza: «È bello ‘sto mondo, è davvero bello. Peccato che lo si debba lasciare quando si è appena imparato ad amarlo».
Agosto 2003. Le mani raccolte come in un guscio, gli occhi mobili e profondi incorniciati dagli occhiali, i capelli corti e spettinati, le labbra sempre aperte in un sorriso. Al collo una croce di legno sorretta da un filo di spago e indosso un saio penitenziale, da novizia, di rozza tela chiara. Chi conosce Anna Cuticchio, figlia del celebre “maestro puparo”, il cavalier Giacomo Cuticchio, e sorella dell’altrettanto celebre Mimmo, la prima donna “pupara” della storia di questa antichissima e raffinatissima arte, potrebbe pensare al suo ennesimo colpo di teatro. Però l’amato-odiato teatro delle marionette questa volta non c’entra. «La vita alle volte ha la capacità di sorprendere anche noi che siamo abituati a reinventarla ogni giorno coi nostri personaggi di latta e legno» commenta. E la sua vita ce la racconta seduta al tavolino di una caffetteria – “Il Rintocco” in via dell’Orologio – nel centro storico di Palermo, quasi di fronte al Teatro Massimo, aperta pochi anni fa con la figlia Vanna proprio là dove una volta c’era il Teatro dell’Opera dei Pupi del cavalier Giacomo. È proprio lì che spesso è possibile incontrarla per ascoltarla e parlarle. «Qui viene tanta gente ormai – spiega –, mi raccontano le proprie pene, mi rovesciano davanti agli occhi e al cuore il sacco delle loro sofferenze». E lei cosa fa? «Io ascolto e basta, ormai non lo fa più nessuno». E sorride, sorride sempre quando parla, ascolta, guarda, ma soprattutto quando mostra una busta che le è appena arrivata dalla Città del Vaticano. «Vede? Questo è il certificato di annullamento del mio matrimonio religioso. Adesso potrò liberamente professare i voti quando l’arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi, lo vorrà». Sì, perché Anna Cuticchio ora è soltanto una “novizia”. Potremmo dire quasi una sorta di suora “in prova”. E di prove nella sua vita Anna ne ha superate già tante. Aveva appena quindici anni quando venne rapita dall’ex marito. Lui ne aveva soltanto diciannove. «Tutto è avvenuto una sera, in un paesino della Sicilia, a Terrasini, a pochi chilometri da Palermo, mentre mio padre faceva il teatro. Io ero innamorata di un altro ragazzo, un carabiniere, ma a mio padre non piaceva». La scena sembrerebbe di quelle da film italiano degli anni Sessanta, alla Pietro Germi, per intenderci. Quei film in bianco e nero con Alberto Sordi o Claudia Cardinale, gli uomini con la coppola e lo sguardo duro e le donne col velo nero e gli occhi bassi. Tutti già sapevano tutto prima che avvenisse, tranne lei. «Durante lo spettacolo – ricorda – la gente mi guardava ed io non riuscivo a capire perché. Poi all’improvviso due uomini mi afferrarono per le braccia e due per le gambe e mi portarono fuori caricandomi su una Fiat 1600. La ricordo ancora». E com’è finita? «Ci ho fatto due figli: Giacomo, morto a 19 anni in un incidente stradale, e Vanna, che vive con me. Allora la vita funzionava così. I genitori c’insegnavano a sopportare». Nel 1960 si trasferiscono a Torino, in Piemonte. Lui fa l’operaio in fabbrica, come tanti meridionali a quei tempi, e lei invece la contadina, dalle 5 del mattino alle 17. «Andavo in bici al lavoro. Cinque chilometri all’andata e cinque al ritorno. Non ero abituata a tutto quel freddo». Ma in seguito fa anche la cameriera in un albergo, la cuoca, la portiera di un palazzo e per sette anni la commessa in un negozio. Nel frattempo, a trentadue anni, si separa. «Davvero non ne potevo più». E la “pupara” quando cominciò a farla? «Un giorno venne mio fratello Mimmo per degli spettacoli in Piemonte e mi chiese: “Vuoi fare la pupara?”. Mi convinse a tornare in Sicilia. Era il 1979». «Sono stata la prima donna “pupara” della storia. Quello delle marionette, infatti, è sempre stato un mestiere da uomini perché richiede molta forza fisica. “I pupi non hanno ossa, ma rompono le ossa” diceva mio padre». Torna a Palermo, quindi, e lavora per un anno col fratello. Poi decide di mettersi in proprio, di aprire un teatro tutta da sola. «Io ed i miei figli abbiamo tirato su anche materialmente il teatro e lo abbiamo chiamato “Bradamante”, in onore dell’eroina dei Paladini di Francia con la quale in un certo senso mi identificavo». Nel frattempo, nel 1980, Giacomo muore, come dicevamo, in un incidente stradale. «Mi sono buttata a capofitto nel progetto del teatro, un progetto che era soprattutto di e per mio figlio. Volevo ammazzarmi di lavoro, suicidarmi in questo modo e ci sono quasi riuscita». Una vita difficile quella degli artisti in Sicilia. Pochi contributi economici pubblici e tanta indifferenza da parte degli amministratori locali. «Sono andata avanti per anni facendo molti sacrifici. Ma a un certo punto non ce l’ho più fatta e nel 1995 ho chiuso il teatro. Una sconfitta per me. Mi sono sentita una donna inutile». E la sua vocazione quando è venuta fuori? «In quel tempo avevo un compagno. È stato lui che mi ha incoraggiato a studiare, per metterla in scena, la vita di una santa della tradizione ortodossa: Santa Marina di Bitinia. Ci ho preso talmente gusto, che ho cominciato a leggere anche la Bibbia e le vite dei santi». E com’è finita? «Beh, lo vede no? Al mio compagno tutto questo non è piaciuto, come potrà ben immaginare. Mi sono riavvicinata al buon Dio e alla sua Chiesa e adesso aspetto solo che il cardinale mi conceda di prendere i voti». E nel frattempo? «Nel frattempo studio, mi sono iscritta all’Accademia di Belle Arti, un sogno covato da tempo, e, incoraggiata dall’arcivescovo, insegno ai bambini dei quartieri poveri l’arte dei Pupi, anche per levarli dalla strada e dalle sue tentazioni». Rimpianti? «Mi pento solo di aver perso così tanto tempo. Ma forse è vero che c’è tempo per ogni cosa». E sorride.
21 Luglio 2000. Un tempo la primavera portava con se le rondini, oggi il suo arrivo è annunciato dalla presenza degli squatters nelle calde città italiane. Percorrono il nostro Paese in autostop o da clandestini in treno e in nave per svernare e assaporare il tepore della bella stagione. Silvia, dall’inconfondibile accento sardo, ha ventitre anni, occhi chiarissimi, capelli viola e una vistosa catena di piercing che le parte dal naso e le arriva fin sotto il labbro inferiore. Con una tazza di metallo chiede qualche spicciolo a coloro che si soffermano a guardare il suo compagno che, poco lontano, in una trafficata via di una città del Sud, si accompagna con la chitarra e canta quasi sottovoce una lamentosa canzone di Bob Dylan: «quante strade deve percorrere un uomo prima di poter essere chiamato uomo». Qualcuno mette mano al portafoglio, altri fuggono via quasi infastiditi. «La gente non ci sopporta, è come se fossimo appestati. E dire che fino a tre anni fa − racconta −, ero anch’io una di loro. Stavo attenta a vestirmi bene, studiavo e il sabato andavo a farmi una pizza con gli amici. Secondo loro ero una persona “normale”. Un giorno però non sono tornata a casa e da allora vado da una città all’altra seguendo le stagioni e la voglia». Nessuno sa quanti siano esattamente gli squatters che si muovono nel nostro Paese. Privi di documenti di identificazione, sono dei cittadini invisibili. Occupano in genere antichi palazzi abbandonati, capannoni industriali dismessi o appartamenti popolari. Ma anche gli squatters, chi lo sa, potrebbero avere qualche santo in Paradiso, anzi, addirittura un patrono. Si tratta di Giuseppe Benedetto Labre, nato il 26 marzo del 1748 in Francia, ad Artois. Morto, nella più assoluta povertà sui gradini di una chiesa, a Roma, a soli trentacinque anni di età. Irrequieto, arso da una sete, dicono i biografi, inestinguibile di Dio, Giuseppe Benedetto andò via di casa a dodici anni. Dopo aver girovagato per diversi monasteri in Francia, dai quali fu sempre respinto perché ritenuto «inadatto» alla vita religiosa, nel 1770 si recò in Italia, a Roma, dalla quale ripartì presto per riprendere la sua vita di pellegrino per i santuari d’Europa. Una volta morto, fu seppellito, a Roma, nella sua chiesa preferita la sera di Pasqua. Pio IX lo beatificò il 7 maggio del 1860 e Leone XII lo dichiarò santo l’8 dicembre del 1881. Detto questo, solo per far capire ai soliti benpensanti che anche tra gli eletti della Chiesa vi sono uomini che hanno vissuto una vita errabonda e negletta, torniamo ai nostri squatters. Squatter viene dall’inglese to squatt (in gergo, squattare) e significa: «occupare le case». Quelli italiani si rifanno agli occupanti di case inglesi e tedeschi e ai Kraakers (spaccaporte) olandesi. Il riferimento politico è storicamente il pensiero anarchico espresso dal pensatore ottocentesco Max Stirner nel libro: «L’unico e la sua proprietà». Oggi, invece, l’autore più letto è Alfredo Bonanno, anarchico-individualista siciliano, inesauribile scrittore di pamphlet sovversivi. Scopo di uno squatter è, quindi, quello di compiere una sorta di rivoluzione privata. Ma come si diventa squatter? «Il percorso mentale che in genere ti porta sulle strade è questo: la società non mi dà i mezzi per campare, se mi va bene solo quelli per sopravvivere o per essere sfruttato. La società con me è spietata, con i miei amici e con gli animali. Se sono fortunato muoio come un pezzo in serie. Allora io mando all’aria il sistema, mi prendo ciò che voglio e me ne frego. Per adesso mi diverto», spiega Marcello, trentadue anni, le guance scavate, uno sguardo che è un abisso di tristezza e degli studi iniziati in filosofia, a Bologna, che lo fanno ritenere l’ideologo del gruppo. Per arrangiarsi, come gli altri, si è improvvisato giocoliere, suonatore, mangiatore di fuoco e fachiro. Al giorno, se gli va bene, riesce a fare anche 100 mila lire. «Una bella sommetta − continua −, ma i soldi li mettiamo da parte anche per i periodi di magra o per i cani che ci portiamo appresso. Qualcuno li invia a casa dove ha lasciato moglie e figli». Uno di questi è senz’altro Pablo, spagnolo, che, in un italiano incerto, racconta di aver lasciato la famiglia dopo aver perso il posto di lavoro. «Non sopportavo lo sguardo di mia moglie − ricorda −, mi sembrava che mi colpevolizzasse per il fatto che la fabbrica aveva chiuso. Un giorno me ne sono andato sbattendo la porta e da allora non ho più rivisto né lei né mio figlio. Però, quando li ho, le mando un po’ di soldi. Mi mancano, ma ormai è troppo tardi». Sì, perché dalla strada non si ritorna, sostengono. Anche se alcuni, col passare degli anni, decidono di cercarsi un lavoro come tutti gli altri, magari nella città dalla quale sono partiti, e di metter su famiglia. Altri, invece, coi risparmi aprono piccole imprese agricole che producono alimenti biologici. «All’inizio − dice Wilma, un sorriso che incanta, vent’anni − ti manca tutto: pasti regolari, il letto caldo e i vari comfort. Poi cominci a prenderci gusto. Ti piace l’andare dove vuoi, fare le vacanze magari in Spagna o in Marocco, conoscere sempre gente nuova. Io ho seguito un ragazzo che mi faceva impazzire. Quando è finita la storia volevo tornarmene a casa, a convincermi a continuare è stata la prima carica della polizia, di notte, in una casa che avevamo occupato da poco. Con le ossa rotte, ho pensato: cazzo, allora, abbiamo ragione, questa società è veramente di merda se hanno bisogno di prendersela con noi». Ma non ti manca proprio nulla? Si fa pensosa e poi risponde di botto: «Sarò ancora borghese: la doccia». Avvertenza In
particolare: La
data di pubblicazione è stata indicata all’inizio di ogni singola storia.
Soltanto in un paio di casi il lettore troverà due date, poste la prima
all’inizio del “pezzo” e la seconda all’inizio di un paragrafo: si tratta di
un collage di storie aventi un unico filo conduttore, ma pubblicate su
testate e in periodi differenti, o sullo stesso periodico ma in date diverse. |
A Giovanni,
Salvatore, |
[formazione] [esperienze di lavoro] [pubblicazioni] [e inoltre...] [links] [contatti] [home]