Nunzio Pagliarello
I Dieri di Baulì
Memorie della Val di Noto

Introduzione
30 agosto 2004
Al Direttore del Corriere degli Iblei, Palazzolo
Acreide
Caro Direttore,
sono un palazzolese di novanta anni abbonato del Suo bel giornale. Sono
lontano da Palazzolo da circa sessant'anni e attualmente vivo in provincia di
Firenze.
Leggendo gli ultimi numeri del Corriere degli Iblei ho appreso con grande
commozione della prossima costruzione di un monumento agli
emigrati, a cui voglio dare un contributo anch'io, nel mio piccolo. Plaudo a
questa bellissima iniziativa che ha lo scopo di rinforzare i legami fra i
palazzolesi nel mondo.
Apprendo dal suo giornale altre iniziative, che secondo me rendono il
nostro paese moderno e "internazionale". Il recente raduno delle
Forze di Polizia Europee ne è una dimostrazione.
Ma quello che sta rendendo veramente moderno e civile, a mio avviso, Palazzolo
Acreide è la recente costituzione dell'Ufficio Anti Racket. Credo che anche
l'associazione Giuseppe Fava esprima questa voglia della nostra comunità di
darsi una fisionomia moderna ed esemplare.
Come potrà rendersi conto, nonostante i decenni di lontananza, l'affetto che mi
lega alla mia terra è intatto. Quante cose potrei raccontare di Palazzolo della
mia gioventù...
La ringrazio per l'ospitalità, e salutandola, tramite il suo giornale, saluto
tutti i palazzolesi.
Nunzio Pagliarello
30 settembre 2004
Al Direttore del Corriere degli Iblei, Palazzolo
Acreide
Caro Direttore,
sono
quel palazzolese di cui ha gentilmente pubblicato la lettera nel numero scorso
e di cui molto la ringrazio. Numero del suo giornale che peraltro non ho ancora
ricevuto, forse per un disguido postale. Comunque mi ha telefonato mia sorella,
emigrata in Australia, di anni 85, per
dirmi che mi aveva letto. Grazie
ancora.
Le
invio se permette questo e forse in futuro altri miei ricordi che, qualora ritenesse degni d'interesse per i lettori,
potrà un giorno pubblicare nel suo
giornale.
Cordialissimi
saluti.
Nunzio
Pagliarello

I
Dieri di Baulì
Leggendo di briganti su uno degli ultimi numeri del
Corriere degli Iblei mi è improvvisamente tornata alla memoria una storia che raccontavano i nostri vecchi quand’ero
piccolo. Avrò avuto undici dodici anni allora - adesso ne ho novanta - quando mi portarono a vedere un luogo
veramente impressionante Si trattava
dei cosiddetti “Dieri di Baulì”, vale a dire le due “fortezze” della
contrada Cava di Baulì – quella che si trova pressappoco a 4 km da Palazzolo.
Chissà se ci sono ancora? In un posto
del diavolo, una cava profonda, si fronteggiavano il Dieri Piccolo e il Dieri
Grande, alti, scavati lungo le due rocce scoscese, ma a distanza di settanta,
ottanta metri l’uno dall’altro,
cosicchè fra di loro si poteva volendo, a voce spiegata, comunicare. Dislocati
com’erano quasi nel vuoto, i due rifugi erano militarmente inattaccabili, a
patto però che fossero presidiati costantemente e congiuntamente. In essi si
erano acquartierati i briganti di Baulì. Per decenni il loro rifugio fu
inespugnabile.
Più volte i “Compagni d’Arme”, come venivano allora
chiamati i poliziotti del Regno Borbonico, si erano avventurati a tentare di
stanare i famigerati inquilini, ma
erano stati sempre respinti, e disastrosamente per i soldati di Franceschiello.
Le loro spingarde nulla potevano contro il fuoco incrociato che veniva ora
dall’uno ora dall’altro Dieri.
Mi
ricordo anche del soprannome favoloso, e molto spaventevole, che avevano due di
questi fuorilegge: “Occhiu di vitru” (occhio di Vetro) e “Mussu di Taugghja”
(muso di bottiglia di terracotta). Costoro probabilmente furono gli ultimi
superstiti di una ciurma che aveva razziato imperturbata per anni la zona.
Forse furono gli inquilini più longevi dei due Dieri, in ogni caso gli ultimi.
Fatto sta che non morirono di vecchiaia perchè riusci a porre fine a questa
storia un ragazzino di cui non ricordo il nome, che aveva saputo della taglia
spiccata a Siracusa sulla testa di quei due. Con la scusa di portar la ricotta
fresca a “Occhio di Vetro” nottetempo lo uccise. La storia narra che mentre
mangiava gli calò sulla nuca un colpo
d’accetta. Poi mise la testa in un sacchetto e camminò tutta la notte a piedi
fino a Siracusa per andare riscuoterne la taglia. Fu facile per i Compagni
d’Arme catturare l’altro, “Mussu di taugghja” rimasto solo.
Questo almeno è quello che io ricordo mi raccontavano gli antichi.

Zu’ Pietro
Non so se nella nella contrada Santa Lucia, il
piccolo borgo di masserie a quattro km da Palazzolo Acreide, qualcuno ricorda
ancora, anche per sentito dire, Zu
Pietru. Io da piccolo lo conobbi, lui era già vecchio, con la cornetta all’orecchio, perchè mezzo sordo. Era un
personaggio di grande “rispetto” nella zona. Ma non nel senso che oggi si
intende quando si parla di cose siciliane. Voglio dire che tutti si rivolgevano
con grande considerazione a Zu Pietro,
ora per controversie legali, ora per consigli o per dubbi di cultura. Passava insomma per l’intellettuale, anche
se fino all’età adulta era stato del tutto analfabeta.
Viveva da solo, come un prete. La sua ampia e comoda
casa di scapolo fu per anni e anni una specie di municipio, di club, fra quelle masserie. Ci si andava per consigli, ma anche per la
sua generosità, per i piccoli regali in denaro per i più bisognosi. Era filantropo, anche se un po’ strambo. Famosa era diventata la
campana di vacca, dove soleva tenere
nascosti i suoi soldi. Quando era il momento di prelevare denaro, cacciava tutti via fuori di casa, prima di tirar fuori il campanaccio dal
nascondiglio segretissimo che mai rivelò a nessuno. Fino alla morte e oltre il
famoso campanaccio non si riusci mai a
scovare.
Zu Pietro
teneva corsi serali di alfabetizzazione a tutti gli abitanti di Santa Lucia,
grandi e piccini. Si può dire che fu il maestro elementare di tutti. Mio padre,
io stesso, abbiamo appreso i primi rudimenti del leggere, scrivere e far di
conto in questa scuola privata che
aveva come fondatore Zu Pietru e con lui stesso per preside e per maestro.
Ma la cosa più curiosa era di come fosse riuscito a
diventare, da contadino analfabeta, personaggio così acculturato. Vale la pena
di raccontarlo in poche righe.
Immaginatevi due giovani fratelli e una sorella che vivevano da soli, lontano dai genitori
e da Palazzolo in quelle contrade. Un giorno fratelli, tornando a casa dal
lavoro in campagna si accorgono che la sorella improvvisamente è sparita.
Rapita? Non era bella, anzi piu’ttosto bruttina questa ragazza, ma chissà.
Hanno però un sospetto. Forse sanno dove trovarla. Salgono sul tetto del
cortile di una masseria vicina e intravedono dalla finestra la sorella pacifica
all’interno di quella casa estranea. Lei non si accorge di loro, loro zitti se
ne vanno. Era stata condotta in casa da un borioso giovanotto, solitario, che
loro ben conoscevano. Era una bravata. Una “sciammaricata” per usare un termine
forte, che adesso non conosce più nessuno. Una bravata violenta, carica di
conseguenze.
Se ne ritornano a casa, l’indomani continuano a lavorare
nell’aia, rimurginando il da farsi.
Come comportarsi. Considerate che allora le ragazze portavano il fazzoletto in
testa, come ora le islamiche portano il chador; erano molto sottomesse, e
e per molto meno di quello che era capitato si rimaneva “disonorate” a
vita.
Com’è, come non è,
al tramonto i due fratelli, mentre spagliavano ancora nell’aia col
forcone, vedono passare il borioso
giovane, in tenuta da caccia con tanto di fucile. Lui non sapeva che
loro già sapevano. Lui saluta, e ha
l’improntitudine di fare anche
l’ironia. Li saluta e dice della recente pioggia, che ha fatto spuntare nel
terreno i “murruna” dell’erbetta nuova ( i morroni dell’erbetta sarebbero le
piccole corna dell’erba che spunta, o anche i cornini dei vitellini da latte). L’allusione era chiarissima! A questo
punto tutto succede in un lampo. Il più
grande, Pietro, dà un colpo di tridente
in testa allo smargiasso cacciatore e lo atterra, gli sfila il fucile e fa
fuoco uccidendolo sul colpo. L’onore è lavato.
Parte e si incammina piedi fino alla pretura di Noto, a costituirsi. Racconta il
fatto, consegna il fucile. Lo imprigionano, ma curiosamente al processo viene
condannato solo per il porto abusivo d’armi (il fucile dell’ammazzato), non
perl’omicidio, che’ a quei tempi, per
il motivo per cui era stato commesso (onore) si veniva senz’altro assolti.
Zu Pietro passò tre anni nelle
Patrie Galere, ove ebbe il tempo di imparare a leggere e a scrivere e a
studiare perfino con gran profitto materia giuridica. Poi ritorno a casa e fu
per il resto dela sua vita uomo integerrimo e gran lavoratore. Sua sorella
ando’ sposa ed ebbe figliolanza.
A noi piccoli rimaneva in mente
una filastrocca con cui la si ricordava, questa sorella.

“Raffiella, longa a mmàtila
e cu li jammi stuorti
l’uocchi comu ‘i persichi
e a vucca di la morti.”
La
barba del barone
Quando ero bambino nella contrada di Santa Lucia si
potevano vedere i pali del telefono che il barone Judica aveva fatto piantare,
tanti anni prima, prima per comunicare fra la sua casa di campagna e quella di
Palazzolo. Ma ai miei tempi tutti sapevano che quella linea telefonica non
funzionava più. Il perché non l'ho mai saputo.
Mi ricordo di come funzionassero invece molto
bene i lavori nelle masserie del barone
Judica. Allora la campagna palazzolese era molto popolata, non come ora. Si
lavorava duro, ma non posso dire che si campasse di stenti.
Mi ricordo dei mestieri antichi, ormai scomparsi.
Persino il ricordo dei nomi di questi mestieri ormai si è perso. Gli
“urdinari” per esempio erano gli
addetti a guidare i convogli di muli nei viaggi lungo le mulattiere fra un un
paese e l'altro. Poi vi erano i
vaccari, i campieri (le guardie private a cavallo), i carrettieri,
ingaggiati per i carretti di proprietà
del barone. E così via.
Mi ricordo di un buffo episodio che capitò fra il
barone Judica e un suo carrettiere. Era
un giovane di trentacinque anni, con una bella barba nera, lucida, fitta e
lunga più di quella che il barone stesso fieramente portava. Judica avra allora
già passata la cinquantina.
Forse vi era una certa gelosia da parte barone per
la barba del carrettiere, per cui un bel giorno, non potendone più, gli ordinò di levarsela quella barba. Chi
credeva di essere? L'autorità del padrone
non ammette discussione, non restava che ubbidire.
E invece Giuseppe (questo era il nome del
carrettiere) non ubbidì.
Dopo qualche giorno, al cospetto di tutti i
lavoranti della masseria, e ostentando un "nerbo" fra le mani, il barone
ordinò all'uomo di seguirlo nelle sue stanze perché “gli doveva
parlare”. Era chiaro a tutti che era
intenzionato a dargli una lezione. Li videro salire per le scale e venne chiusa
la porta a chiave.
Quel che si dissero non lo sa nessuno. Pare che però, quando furono soli, il
carrettiere tirò fuori dalla tasca una catena da finimento di mulo e, afferrato
il barone e calatigli le braghe, fu lui a impartire la lezione.
Certo, non vi erano testimoni, chi può dire come
siano andate veramente le cose?
Ma dal fatto che il barone dopo si preoccupasse di
chiedere ai suoi contadini se avevano sentito grida venire dalla stanza, si
capì che qualcosa non era andato come nelle tradizioni.
Non so se il valente carrettiere che aveva salvato
la sua barba rimase ancora a lavorare per Judica, certo è che fu sempre molto
stimato ammirato nel paese per gli anni avvenire.

Il piccolo
archeologo
Da ragazzino l’’archeologia era una mia mania
solitaria che non condividevo con nessuno dei miei nove fratelli.
Tutte quelle storie di fantasmi, di tesori sepolti,
di incantesimi si mescolavano con la curiosità che destavano certi luoghi dai
nomi veramente evocativi.
Si prenda per esempio la Sella di Castelluccio, dove
davvero la montagna ha la forma della groppa di un cavallo.
Quello era un posto di ruderi e di antichità dove mi capitò un fatto strano.
Un giorno, mi ricordo, mia sorella Idria aveva avuto
per tutta la notte mal di pancia. Mia
madre mi mandò a cogliere della ruta. Di quest’erba non era difficile trovarne,
anche vicino casa nostra, ma presi per scusa quella piccola commissione per
arrivare fino al Castelluccio, uno dei miei posti archeologici preferiti. In
quel luogo, solitario e abbandonato mi imbattei in una scala di pietra che
iniziava rasoterra per poi scendere entro un rudere di casa mezzo sepolto. Non
c’era nulla d’interessante su quei vecchi gradini coperte di licheni. Appoggiai
l’orecchio sulla pietra, da dove sembrava venisse un suono, e quale non fui la
mia meraviglia - e il terrore - nel sentire distintamente lo scalpitare degli
zoccoli di un cavallo al galoppo. Fuggii a gambe levate. Non ricordo se lasciai
lì persino l’erba che mi era stato ordinato di cogliere.
Un’altra
volta, sentendo raccontare dai grandi delle antichità di Noto Vecchia, i ruderi
della città distrutta nel terribile terremoto del 1693, – però ero grandicello
ormai, avrò avuto 15 anni – volli andare a esplorare il luogo. Vi giunsi a piedi. Era un tardo pomeriggio e mi aggiravo tutto solo fra quelle
macerie ricoperte dall’erba. Trovai quasi subito un fischietto di terracotta,
di quelli scolpiti. Feci per suonarlo e il fischio echeggiò a lungo, solitario,
fra le coste contrapposte della vallata. Ma in maniera così curiosa, così lungo
e amplificato, da avere un non so che di lugubre. Gettai via il fischietto e
corsi via a gambe levate, terrorizzato.
Un’altra volta poi mi misi a scavare dentro una di
quelle grotte che si aprono in alto su
quelle coste scoscese di pietra bianca
che dicono siano state tombe o abitazioni già nella preistoria, come ce
n’è tante per esempio a Pantalica. Smossa
appena un po’ di terra trovai subito una mandibola umana con tutti i
denti bianchi perfetti, bellissimi ancora attaccati. Presi una “ianca” (un
molare, il più bello) me lo misi in tasca e ritornai a casa. La notte ebbi un
incubo: sognai uno scheletro, grandissimo, alto come un albero che mi
rimbrottava e mi ordinava di andare a rimettere al suo posto quello che avevo
rubato. Cosa che feci subito l’indomani stesso. Ma non ebbi più animo d’entrare
nella grotta. Scagliai da lontano il povero dente dentro la grotta e fuggii a
gambe levate.

Leggende
di magia
Quando ero piccolo non esisteva né radio né
televisione. La sera si andava a letto presto, ma dopo cena i grandi
raccontavano storie, di cui qualcuna m’è rimasta per sempre in mente. Certe
sere il discorso prendeva la piega dei
racconti favolosi, di magie e di “antichità”. Quante volte sentivo dire, per
esempio, che in certi luoghi, in certe ore del giorno – a mezzogiorno o a mezzanotte
– apparivano gli spiriti.
Lo Zu’ Pietro, quell’uomo saggio di cui ho già
parlato, soleva dire che nella contrada detta degli “Ariazzi” ogni lunedì di
un mese che iniziasse di lunedì, allo
scoccare della mezzanotte, iniziava nell’oscurità una fiera. Si potevano vedere
allora, alla luce bianca della luna, venditori in costumi antichi, che
offrivano a chi aveva il coraggio di entrare, anzi regalavano proprio, monete
d’oro e gioielli. Venditori che ti pregavano, imploravano quasi, di accettarli
quei loro doni. Nessuno di quelli che c’erano andati, diceva Zu’ Pietro
misteriosamente, s’era mai fidato di accettarne alcuno. E avevano fatto bene.
Il posto si chiamava anche “’u Culuòruvu”, cioè il Serpente. Forse altri lo conoscono
come Primosole, perché situato nel punto più aperto a est di Palazzolo, dove
all’alba, in lontananza, si vedono spuntare i primi raggi di luce,
direttamente dal mare.
Sempre lungo mulattiera che porta a Santa Lucia - la
Reggia Trazzera, come era denominata allora ufficialmente - vi è una località
che, passando da Testa dell’Acqua, porta a Noto Antica. Il posto si chiama
propriamente Munti Alleriu ed è situato
fra Mandrie Alte e la Mènnula di Santa Lucia.
Anche qui si raccontava una storia di incantesimi
che tutti nella zona sapevano bene. In questa altura l’ultimo principe
saraceno, prima della sconfitta aveva sotterrato tutti i suoi fedeli soldati,
anche i superstiti, che aveva ucciso personalmente uno a uno, e anche la sua
sposa. E dentro aveva infine sepolto tutto il suo tesoro. Forse poi si era
ucciso anche lui.
Secondo la tradizione il tesoro poteva essere
recuperato facilmente. Sarebbe stato del cavaliere avesse superato tre prove di
destrezza e consisteva in questo: girando al galoppo attorno al cocuzzolo di
Muntalleri il pretendente avrebbe dovuto nell’ordine: mangiare un melograno
intero, ma senza farne cadere a terra neanche un chicco; bere un bicchiere
d’acqua, masenza versarne nemmeno una goccia; infine mangiare a uno a uno i
chicchi una spiga di grano senza farne cadere nessuno. Credo che il tesoro sia
lì, ancora intatto, ad aspettare il suo valente cavaliere.
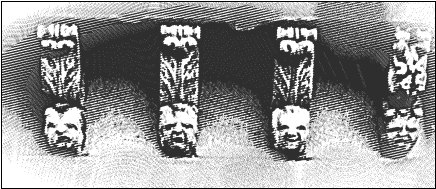
a Saialemme
“Per levare la sete a Siracusa senz’acqua ci
vorrebbero almeno cento pozzi!”
Così dicevano ai tempi antichi i siracusani, circondati da ogni parte dal mare ma assillati da
sempre da una atavica sete. Poi qualcuno, non si sa chi, tirò su l’aquedotto. I
grandi lo chimavano a Saia a Lemme (l’acquedotto di Lemme o di Alemme o
qualcosa del genere). Ma a Saialemme nessuno ricordava chi l’avesse costruita.
Si sa solo che partiva da Sortino per portare acqua dolce alla città di
Archimede. Da Palazzolo a Sortino da
ragazzo ci andavo spesso a piedi,. Il viaggio, di buon passo, durava due ore e
mezzo. Ricordo che un giorno, recandomi con mio padre a Sortino, siccome mi
chiamo Nunzio chiesi di vedere la madonna della Nunziata nella chiesa madre di
Sortino. Era bella,con tutte le decorazioni barocche, ma era la copia della
statua della Nunziata di Palazzolo, che comunque era ancora più bella. Sempre
quel giorno mio padre mi condusse a vedere anche l’aquedotto meraviglioso. Mi
spiegò che era fatto di “bituma” e “pizzulama”, un impasto fortissimo a base di
calce e pezzi di terracotta macinata,
il cemento di allora. E vidi che ogni cento metri aveva un pozzo di drenaggio e
sedimentazione.
Sul misteriosissimo costruttore di questa mirabile
opera d’antica ingegneria c’era una leggenda che aveva per protagonista un
prete, dedito alla magia, in combutta con gli spiriti.
Questo prete aveva a servizio un ragazzo, l’aveva
raccolto trovatello, che gli faceva da garzone, da cherichetto e da sacrestano.
Il prete possedeva una casetta in una sua campagna e dentro questa casetta si
mormorava che si appartasse spesso, indaffarato in non si sa quali traffici. Nella
casetta proibiva a tutti d’entrare, poteva metterci piede solo e soltanto lui.
Un giorno, che doveva assentarsi per andare per un affare urgente al paese,
lascia il ragazzo a far la guardia alla casetta, ma proibizione assoluta di
entrare e di toccare alcuna cosa.
Appena il prete si allontanò, fu subito premura del
ragazzo entrare nella casa e mettersi a toccare un po’ qua e un po’ là. Vide
sopra il tavolo una bellissima e lucida tabacchiera d’argento. Non potè fare a
meno di carezzarla e di aprirla. Ma non appena la apre una voce, che non si sa da dove viene comincia a
ripetere svelta le seguenti parole: “Cumanna! Cumanna! Cumanna! Cumanna!”.
La prima cosa che gli viene in mente di comandare
allo spirito della tabacchiera è quello di cui aveva sempre sentito parlare: i
cento pozzi per Siracusa assetata. Il prete torna e mettendosi le mani ai
capelli: “Che hai fatto sciagurato di un ragazzo – gli dice - la Saia era già
costruita! Perché hai consumato la magia?” Ma nessuna Saia c’era prima che il
ragazzo chiedesse la grazia allo spirito della tabacchiera.
E
così Siracusa dall’oggi al domani fu bell’e dissetata.

La grotta dei
nobili
Tutti sanno del grande terremoto dell’undici gennaio
1693 “’a vintin’ura”, cioè alle tre del pomeriggio, che distrusse la regione
degli Iblei e mezza Sicilia. Ancora ai miei tempi la tradizione del grande
terremoto non era un ricordo affidato alle letture, ma si tramandava di bocca in bocca, nel corso
delle generazioni. Il nonno di mio nonno, per esempio, diceva che da Santa Lucia, mentre tutti
erano intenti al lavoro, si vide salire una
grande nuvola di fumo da quello che è l’attuale contrada di Palazzo,
dove allora il paese sorgeva. Senza che si udisse alcun rumore il paese era
intanto completamente crollato.
Se andate a Noto,
vedrete che fra i ruderi della città distrutta c’è solo un edificio che
sembra essere rimasto illeso: è il
Convento delle Carmelitane.
Il terremoto era stato previsto da una monaca, “a
Monica Santa” che tutti prendevano per pazza. Costei aveva previsto non solo il
giorno, ma anche l’ora in cui sarebbe avvenuto
il cataclisma.
Fra gli abitanti di Noto qualcuno ci credeva e
alcuni invece non ci credevano. Qualcuno che aveva in casa oggetti di valore li
aveva messi al sicuro. Tra i nobili la profezia era stata presa un po’ per
scherzo e un po’ sul serio. Pensavano
di passare per ridicoli, ma intanto un po’ di paura l’avevano. Decisero che per
quel giorno che era stato profetizzato dalla Monaca sarebbero andati a
rifugiarsi in una grotta sotto la montagna vicina al paese, portando seco i
beni più preziosi. Si armarono di vettovaglie e da mangiare, di giochi con cui
passare il tempo, e si installarono nella grande grotta.
Il cataclisma, come profetizzato, puntuale avvenne,
Noto fu cancellata dalla faccia della terra. Ma si spaccò in due anche la
montagna, con una cateratta di pietre che chiuse anche la grotta. Per molti giorni si udirono le urla
disperate dei nobili provenire come dall’interno della montagna. Di quella
che venne detta la Grotta dei Nobili si
persero le tracce.
Del tremendo terremoto ricordo a memoria una poesia
che dicevano i miei vecchi. Ne ricordo le parole, anche se alcune di queste non
riesco a capire cosa significhino. Ve la trascrivo in siciliano così come suona
nelle mie orecchie, sperando che qualcuno riesca a tradurla:
“Unnici di ginnaru milli e
intuornu,
Hannu offesu tantu Diu
supernu.
Tiempu tri Credi finisci lu
munnu
Si vedi Morte, Paradisu e
Infiernu.”

Storia
di Aretusa
Anche quello che sto per raccontare l’ho sentito da
piccolo da persone diverse, e in diverse occasioni.
Dicevano che la Sicilia era nei tempi antichi
disabitata, ricoperta completamente da un’unica fittissima foresta. Gli alberi
erano così intricati che non si poteva neanche pensare di entrarci. I
primi coloni superarono questo ostacolo in un modo semplice e sbrigativo:
diedero fuoco alle foreste. Si narra che l’incendio che ne seguì fu tanto
grande che il fuoco divampò tre lunghi anni prima di spegnersi del tutto.
Le popolazioni dei nomadi colonizzarono dapprima le
rive dei fiumi, che non erano torrenti
di adesso, ma erano molto grandi, alcuni addirittura navigabili. Il Tèllaro (u
Latiddaru) che passa da Palazzolo, sboccava a Sud della costa orientale.
l’Anapo che riceveva anch’esso le acque della Val di Noto, aveva la sua foce
sempre nel mar Ionio, ma proprio davanti all’isoletta di Ortigia, cioè dove è stata fondata Siracusa.
I vecchi dicevano anche che i nomadi insediatisi
alla foce dell’Anapo provenivano tutti dall’occidente della Sicilia. Su Ortigia
esisteva già invece da tempo la colonia di un popolo ancora più antico della
costa orientale del Mediterraneo, dove è l’attuale Turchia.
La leggenda racconta che un ragazzo del popolo della
foce volle un giorno conoscere quell’isoletta che lui vedeva all’orizzonte
davanti al suo fiume. Una mattina attraversò a nuoto le due miglia scarse di mare che separavano l’isola dalla foce
del fiume e approdò sulla spiaggia. Qui incontrò subito una ragazza. Era bellissima. Anche se i linguaggi che i
due giovani parlavano erano diversi, si fece capire quando le chiese il suo
nome. La ragazza disse di chiamarsi Aretusa. Il ragazzo disse il suo: Ciano. Si
sorrisero, ma l’incanto durò poco. I fratelli
di Aretusa subito accorsi lo cacciarono in malo modo minacciandolo e
proibendo al tempo stesso ad Aretusa di scambiare in futuro parole con lo
straniero.
L’amore, che è fatto soprattutto d’impedimenti,
divampò fra i due ragazzi. Ciano mentre si allontanava le sorrise, ma con lo
sguardo di chi prometteva che sarebbe tornato.
Ogni mattina Ciano vedeva il sole spuntare proprio
da dietro l’isola d’Ortigia e gli sembrava di intravedere, nel controluce
splendente dell’astro sul mare, l’ombra di Aretusa che lo salutava da lontano
con la mano.
Dopo qualche giorno decise di tornare per farle un
regalo. Riemi di “manna” in un piccolo vaso.
Questa prelibatezza era allora comune in Sicilia. I vecchi dicevano
che sulle montagne di Palermo la manna
era raccolta dai faggi, incidendone la corteccia come si fa con le piante di
caucciù, e lasciandone colare questa specie di miele.
Ciano ritrovò Aretusa e le porse il vasetto,
promettendole amore eterno. La ragazza
per ricambiarlo raccolse alcune foglie di una piantina che colà cresceva e gli
fece una treccina verde.
Ma l’incanto fra Ciano e Aretusa fu spezzato ancora
dal sopraggiungere dei parenti inferociti. Ciano riuscì a fuggire ma ragazza fu
punita così severamente da morirne. La leggenda dice che Aretusa si trasformò
allora in una perenne fonte d’acqua dolce che da allora si versa a occidente
nel mare verso la foce del fiume, come a cercare per sempre il ragazzo.
Ciano piantò nella foce paludosa del fiume la
treccina verde ricordo di Aretusa e da allora lì il papiro vi cresce
spontaneamente, unico luogo nelle coste d’Europa.
Chi va a Siracusa può vedere ancor oggi la Fonte di
Aretusa: grossi pesci d’acqua dolce ne escono per disperdersi nell’acqua del mare circostante. La leggenda
dice che il ragazzo, per raggiungere a
sua volta l’amata, si sia trasformato a sua volta in fiume sottomarino che
alimentava con la sua acqua dolce eternamente la fonte del suo amore.
Tutti sapevano questa storia quando ero piccolo. Le
donne raccontavano inoltre - l’ho sentito con queste mie orecchie - che
guardando nelle conche d’acqua dove il fiume si ferma e diventa palude, fra i
mille verdi steli del papiro piantato da Ciano, si può intravedere, sotto il
tremolare dell’acqua increspata dal vento, la ragazza Aretusa che tesse una
tela.
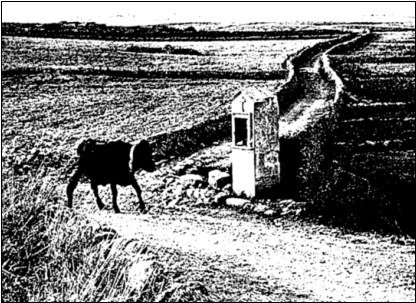
Buoncoraggio,
brigante galantuomo
Da ragazzo sentivo parlare di
Buoncoraggio. Quando qualcuno, da povero che era sempre stato, diventava
improvvisamente ricco, state pur sicuri che da casa sua era passato
Buoncoraggio, brigante galantuomo, a sussurrargli nell’orecchio un buon
consiglio. Così raccontavano i grandi.
Nella Val di Noto c’era un detto
che suonava così:
Buoncuraggiu rubbau cientu jumenti
Pigghiau tuttu, e nun si sappi nenti.
La specialità di Buoncoraggio era
l’abigeato, il furto delle cento giumente del proverbio, ma naturalmente egli praticava anche tutti
gli altri numeri della sua arte di predone. La cosa curiosa era però che, sia
nei suoi molti anni di galera che nei pochi periodi nei quali fu in libertà,
mai fu visto vantare ricchezza e vanagloria. Qualcuno anzi, per questo suo
carattere così modesto, lo considerò poco più di “’nu babbu”, uno sciocco.
Buoncoraggio comunque non se ne
dava per inteso. Non era il solito brigante crudele, come ce n’erano tanti a infestare
le campagne di allora, fu il mitico Buoncoraggio della Val di Noto.
Le cose con lui andavano quasi
sempre così: faceva il colpo, vendeva gli animali, e poi nascondeva gruzzolo. Il nascondiglio era
sempre lo stesso: una pentola, fil di ferro per chiuderla, poi una buca
abbastanza profonda dove calare la pentola e tenera a mente dove aveva fatto
il buco.
Ecco, era proprio il ricordo
della buca il vero grattacapo. E d’altronde, dove depositare la refurtiva se a
quei tempi le banche non facevano questo servizio? Il metodo non poteva essere
dunque che questo. La buca sarebbe stato a 30 passi dal tale albero, vicino
alla tal casa, nella tal zona, nella tal direzione; precisamente quella in cui
un albero, una torre, una casa, una punta di montagna potevano “collimare” col
tesoro, così come il mirino, quando si spara un buon colpo, collima con la
punta del fucile.
Non si sa se Buoncoraggio fosse analfabeta, o se sapesse
leggere e far di conto; si sa di certo che non lascio mai traccia di mappe che
indicavano il tesoro. Le uniche sue mappe erano calate nel fondo della sua
testa, come le sue pentole nel fondo della terra. Ma con gli anni troppe
pentole, troppe buche, troppi tesori sparsi ai quattro venti della Val di Noto.
E più che passava il tempo, più che quel gomitolo di direzioni, di fili nella
testa, si ingarbugliava.
Buoncoraggio invecchiando si
decise a una soluzione drastica. Sfilava dalla testa uno di quei fili per
rinvenire le pentole nascoste e ne faceva dono
a chi gli tornava più a genio. Fece queste confidenze, in carcere o da
libero, quando ne aveva voglia, ma si trattava sempre di poveri diavoli.
Talvolta l’indicazione era vaga, non per malizia, ma perché se l’era scordato
proprio del tutto dove precisamente era la tal buca, e allora il tesoro era
proprio perso. Altre volte fu il caso,
dopo tanti anni, che rivelò a un contadino mentre arava una pietra più grossa e
più sonante delle altre. Ed ecco venir fuori la pentola coi soldi del buon
brigante.
Ma sia che fosse un tesoro dei
suoi, o qualcosa di molto più moderno, che con Buoncoraggio non aveva proprio
niente a che fare, era sempre a lui che dalle nostri parti si dava il merito o
la colpa per le fortune improvvise.
E fu per questo che Buoncoraggio,
che si disfece di tutti i suoi tesori, morì povero ma benvoluto.
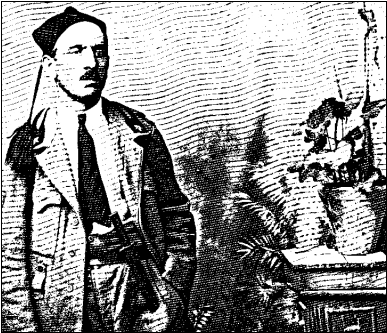
La
figlia del caliaro
Questa
non è una vera e propria storia, ma una specie di fotografia. Come in ogni
paese, la sera di domenica nel orso principale c’era lo struscio. Noi, ragazzi
di campagna che stavamo sei giorni in campagna a lavorare, col vestito buono
della festa, maschi coi maschi, femmine con le femmine, ovvero queste ultime
con le madri o le sorelle più grandi. Noi, ragazzi di campagna, figli di
massari, facevamo gli spacconi coi ragazzi del paese. Sostenevamo – ed era
spesso vero – di avere più soldi in tasca di questi ultimi. I massari, proprietari di terra, erano
allora gente benestante. Non c’era ancora l’emigrazione, le campagne erano
tutte popolate. L’emigrazione, quella venne dopo la guerra.
La
domenica e nelle feste, nel corso principale di Palazzolo Acreide la calca era
tale che ci stringeva quasi spalla a spalla. Per tutto il Corso, dalla piazza
al quartiere alto di “Palazzo” si formavano due fiumane di folla, da una sponda
quella che andava su, e dall’altre quella che andava giù.
Fra
le ragazze me ne ricordo una in particolare: alta, ben in carne, di bellezza
fiera, oggetto per tutta la settimana dei nostri discorsi e la domenica dei
nostri sguardi. Non mi ricordo più il suo nome, era per tutti la “figghia d’’o
caliaru” , e si accompagnava spesso con un’altra, “Liddra ‘a sciàbbula”, ovvero Paolina detta la “sciabola”, per dire di ragazza alta e
bella.
La prima era figlia appunto di un tale che di
mestiere faceva il “caliaru” che andava nei paesi vicini a vendere la “calia”
che aveva fatto in casa. L’arte consisteva nell’arrostire i ceci nella sabbia
arroventata fino a farli diventare delle palline perfettamente rotonde e
croccanti. Un lavoro se vogliamo
onesto, non come quello di certi “frustieri”, quei commercianti
forestieri che per le feste venivano da lontano. Metti ad esempio i catanesi “spatioli”, ovvero famosi per
essere violenti e facili di coltello, o i palermitani “vicarioti”, cioè inquilini
abituali delle galere della “Vicarìa”.
Prima delle feste ricordo che il banditore comunale
metteva in guardia pubblicamente la buona gente di Palazzolo da questi mariuoli
poco raccomandabili. Ma il “caliaro” di Palazzolo, benché fosse un girovago al
massimo si spostava fino alle feste di Bucchieri, Buscemi, Cassaro e Ferla. Mi
ricordo della sua “abbanniata”:
Taliati com’è caura, chi
ciauru ca fa
Tri sordi, un quartaruni, cu
a voli s’a pigghia cca.
Con la sabbia arroventata arrostiva anche le fave
secche e i semi di melone, “favi, calia e simenza” appunto, e poi esponeva
nella bancarella in “monzelli”, in mucchietti, illuminati dalle lampade
d’acetilene. Faceva anche i dolciumi, i “sanfirricci”, una pasta di zucchero e
miele stirata e allugata dozzine di volte prima di ridursi a lecca-lecca dalla
forma ritorta come le colonne barocche della chiesa dell’Annunziata.
Ecco, io mi ricordo come fosse ora una di quelle sere di festa, che si udì, del brusio della folla, dapprima un grido. Poi il rumore distinto e preciso di una terribile “timpulata”, di uno schiaffone. Cos’era successo? Nulla di grave, tanto che dopo un istante di smarrimento la folla comincio a processionare come prima. Ma fra mormorii e risate si sparse subito la voce che la figlia del caliaru aveva stampato una delle sue grasse e belle manine sulla faccia di uno di noi ragazzi che non aveva proprio resistito alla tentazione e aveva osato metterle una mano sul sedere.

ricordo di Peppi Cucciaru
Peppi Cucciaru (Giuseppe Cucchiaio) era un
agricoltore della Contrada di Santa Lucia di Palazzolo. Persona rispettabile e
anche rispettata, in quanto se qualcuno cercava di raggirarlo la sua bontà
finiva.
A quei tempi li crapari di Palazzolo (i caprai, molto diversi dai pastori di
pecore, che erano persone perbene) erano sempre in lite con gli agricoltori
delle campagne perché, quando il grano nel mese di marzo e aprile era tenero e
verde facevano pascolare le capre lì in mezzo, quando il padrone non ci stava.
E questo a Peppi Cucciara dava molto fastidio e quando li pescava nella sua proprietà
era una quasi battaglia. Sempre vinta da Peppi peraltro, sia per la potenza con
cui lanciava sassi (con tutte e due le mani, chè era perfettamente ambidestro),
e sia perché era di una precisione come se avesse avuto un fucile, tanto che il
più delle volte andava a caccia proprio
senza fucile.
Un giorno mio nonno andò a fargli visita nella sua
abitazione e, mettendosi poi i due a passeggiare per i campi lì attorno, Peppi
vede sopra una pianta un colombaccio (tutuni in siciliano), si rivolge a
mio nonno e gli dice “Turi, vai a pigghiari ‘stu tutuni” e mentre li
dice prende un sasso e lo lancia verso quella povera bestia uccidendola
all’istante. Mio nonno va a raccogliere il colombo e Peppi gli fa: “Tienilo,
portalo a casa e lo dài a Santa, che ti fa ‘u bruoru (il brodo)”.
Bisogna poi sapere che a quei tempi a Palazzolo ne giravano molti di caprai, che al mattino vendevano il latte per le strade. Queste persone possedevano le capre, ma non avevano campagna dove farle pascolare. Allora la mattina uscivano fuori dal paese e, per le strade dei campi, ai lati, dove ci stava sempre un po’ d’erba, le facevano brucare. Ma nelle terre che vi confinavano, se non si vedeva nessun proprietario nelle vicinanze, facevano sosta. E a quel punto non c’era bisogno di dare ordine alle bestie, quelle sapevano già dove trovare da mangiare. E se per caso veniva il padrone della terra il capraio dava un fischio e le capre in pochi secondi erano tutte a fianco del loro padrone, e se lui prendeva la corsa anche loro erano al suo fianco. Insomma erano più furbe del padrone.
Un giorno Peppi Cucciaru andò a visitare una sua
campagna, lontano dal suo abitato, quand’ecco che vede appoggiato su di un
tronco di quercia un uomo, che con la pipa in bocca fumava. Lontano dalla
quercia, tra il grano, ci stavano le
capre che pascolavano; e il capraio non si era accorto di Peppe che in un
istante lancia un sasso e gli fa saltare la pipa di bocca. Le capre sentito il
fracasso intanto sono scomparse, compreso il padrone, e la cosa finisce qui. Ma
non passò tutto liscio in quanto qualcuno di nascosto aveva visto la scena e
pensò che Peppe avesse ammazzato il povero capraro. Il testimone accorre da mio
nonno gli dice preoccupato: “Guarda che Peppi ha ammazzato un capraro!”. Vanno a controllare nel tal posto, erano
trentacinque piedi da dovePeppi aveva lanciato la pietra. C’era la pipa, ma
nessun craparu. Fortunatamente non era stato ucciso, era filato via in
silenzio con tutte le sue capre.
Peppi io non l’ho mai conosciuto, questi che racconto
sono tutti ricordi di mio nonno. Diceva che era un uomo grande e di
bell’aspetto. Ma questa abilità per il tiro delle pietre doveva a un certo
punto costargli cara. Per una questione di confini, un giorno litigò con
un’ometto col fucile – che poi non era altro che suo cognato, col quale non
andava affatto d’accordo. Vedendo una mattina che i muretti di confine fra le
sue terre e quelle del cognato erano spostati ne chiese e ragione conto
all’uomo, che rimase in silenzio. Peppi raccolse come aveva fattosempre con le
due mani due pietre, per una punizione micidiale. Ma il cognato più svelto di
lui gli spara quasi a bruciapelo prima nella mano destra e poi in quella
sinistra, rendendolo innocuo per sempre.
La fine di Peppe non l’ho mai saputa, se non il fatto
che morì, benestante com’era sempre stato, di vecchiaia, e rispettato, se non
per l’incidente delle mani.

Gregge e
mulino, di buon mattino…
Circa nel 1923-25, nella zona di Testa dell’Acqua,
di Nicastro e di Gelso, veniva spesso a ogni stagione una persona detta u
sciancatu. Si chiamava così perché gli mancava una gamba. Non era vecchio
ed era anche salutibile. Andava per le famiglie della zona a chieder
l’elemosina, da mangiare e qualche volta anche da pernottare. Però nello stesso
tempo era un po’ furbacchione.
Una sera finì la giornata in contrada Gelso, nella
massarìa di massaro Bastiano che lui conosceva da tempo e gli domandò se poteva
dargli alloggio quella sera. Dopo aver mangiato, u massaru Vastianu disse
all’ospite: - Vui putiti dòrmiri nel fienile, perché non abbiamo altri letti.
Là non fa freddo, e così domani potete andare via. Io domani debbo andare ‘o
mulinu, a macinari u frummientu, e devo partire un po’ prestino.
Allora u sciancatu dà la buonanotte al massaro e alla massara e va a dormire nel
fienile.
Verso le ore una u sciancatu chiama: - Massaru, u
jaddu canta, è tardu. Sapiti comu si rici: mànnira e mulinu vacci matinu.
(Massaro, il gallo canta, è tardi e sapete come dice il proverbio: gregge e
mulino, vacci di buon mattino.) Il massaro rispose: - Ancora è prestu, mancu i
Triali su sciuti. (è ancora presto, non sono spuntate neanche le tre stelle
delle Pleiadi.)
Ore due: - Massaru, u jaddu n’autra vota cantau.
Mànnira e mulinu vacci matinu…
- E va beni, - disse u massaru Vastianu - aiutatimi
a carricari i sacchi r’o frummientu che minni vaio.
E così u massaru partì per il mulino.
U sciancatu, visto che u massaru non ci sta più
incomincia a gridare: - Massara, sento freddo, mi sento di morire dal freddo.
La massara gli dice: - Cosa posso fare? Vi posso
dare i “pòspari” e vi accendete il fuoco.
- D’accordo - rispose u sciancatu.
Allora
la massara, per dargli li cirini, con la mano fuori dallo sportello della porta
gli dice: - Prenda e si accenda il fuoco.
Lui,
per prendere, ha preso la mano della massara e tenendola stretta incomincia a
carezzarla, dicendole “Massara, come è bella questa mano…”
Ma u massaru Vastianu aveva capito l’idea dello
Sciancatu e non era andato al mulino, ma si era nascosto a portata di mano
tanto da poter osservare tutto quello che succedeva. A questo punto u massaru
entra nel cortile da una seconda porta e sbuca proprio dietro lo sciancato che
stava prendendo i pòspari per accendere il fuoco. Prende per un orecchio il
malcapitato e a stivalate accompagna lo sciancato per la strada del
ritorno. Che dopo quel giorno in questa contrada non si vide più.
Ma quando si incontrano quelli che sanno la storia
dicono: - Massaro, u jaddu canta. Mànnira e mulinu vacci matinu…
Quello
che ho appena raccontato mi fa venire in mente
questa canzuna, che si chiama:
Pinsieru d’u garzuni per la patruna
Tutta la notti iù agghiu a
camminari
La strada è lonca e
l’allusru di luna
Prima ch’è ghiorno ddà
m’agghiu a truvari
Sotto li porti della me patruna
Idda mi rici “C’hai vinutu a
fari?”
“Vuogghiu la sua promessa,
mi la duna?”
Mi rici: “Ora ti vuogghiu
accuntintari.
Lu patruni nun c’è, ma sugnu sula.”
traduzione: Tutta la notte
ho da camminare, la strada è lunga al lume della luna, prima di giorno lì mi
dovrò trovare, sotto le porte della mia padrona. Lei mi dirà: “Che sei venuto a
fare?”” Voglio la sua promessa, me la dà?”
Lei mi dice: “Ora ti accontenterò. Il padrone non c’è, e sono sola.”

Indice
Introduzione
I Dieri di Baulì
Zu Pietro
La barba del Barone
Il piccolo archeologo
Storie di magia
Saialemme
La grotta dei nobili
Storia di Aretusa
Buoncoraggio, brigante galantuomo
La figlia del caliaro
Ricordo di Peppi Cucciaru
Gregge e mulino
Pinsieru d’u garzuni per la patruna
Stampato in proprio
il 9 gennaio 2005, per uso personale.
Tutti i diritti dell’Autore.
Permesso di riproduzione del presente lavoro, in toto o in
parte solo su richiesta.
Le illustrazioni sono elaborazioni tratte da libri o da
documenti fotografici privati dell’Autore (eventuali richieste di
riconoscimenti al seguente indirizzo: psalvus@tiscalinet.it)
Copertina, campagne di Ragusa (elab. Foto Scianna)
p.4, l’Autorea 34 anni
p.6, necropoli della pineta, Palazzolo A.
p.10, raccolta del lino a Comiso, primi ‘900 (elab.foto Lo
Iacono)
p.13, Rosaria Giardina e Basilio, primi ‘900
p.16, mulino S.Lucia, Palazzolo A..
p.18, Palazzo Iudica, Palazzolo A. (elab. Foto Scianna)
p.24, Chiesa di S. Paolo, Palazzolo A.
p.28. Campagne verso Ragusa (elab. foto Scianna)
p.31, Sebastiano Finocchiaro in divisa da Ardito, circa
1930
p.34, Statua all’interno di chiesa S Annunziata, Palazzolo
A.
p.37, chiesa di S. Paolo (particolare), Palazzolo A.
p.42: part. Di Chiesa S.Annunziata di Palazzolo A.