|
|
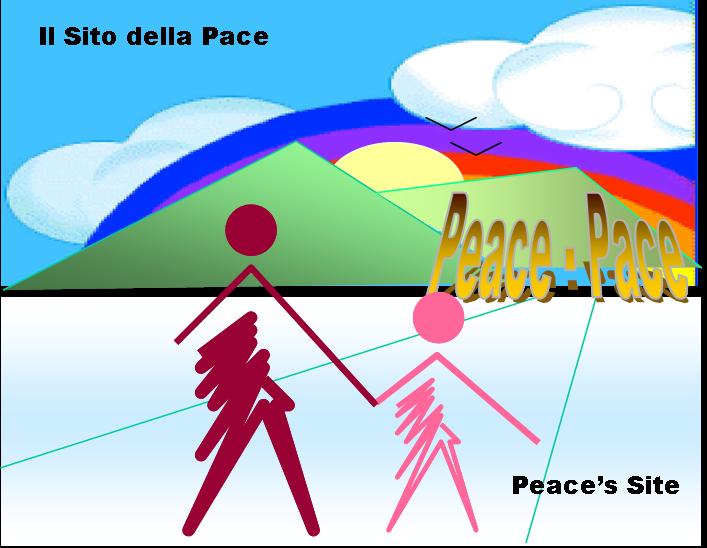 |
![]()
Introduzione critica: Dalla fiaba alla poesia.
Esiste una poesia per bambini? Quali caratteri ha o dovrebbe avere? Quale rapporto tra i bambini e la poesia? Come educare alla poesia? In che termini porre la questione della, comprensione? A queste e altre grosse questioni, che ancora oggi ci poniamo, Rodari fornisce risposte nel saggio "i bambini e la poesia" pubblicato sul Giornale dei genitori, n. 6-7, giugno/luglio 1972. Lo scritto si configura come integrazione al saggio "La letteratura infantile oggi" .
Alla domanda se esista una poesia per bambini si potrebbe anche rispondere subito di no, che non può esistere una poesia per bambini più che non esista una poesia per avvocati, o per maestri di scuola, o per vigili notturni. La poesia esiste autonomamente, a prescindere da chi si trova ad essere il destinatario del suo messaggio; o non esiste. Ci sono poesie che possono essere capite, sentite, diciamo pure vissute dai bambini, indipendentemente dal fatto che siano state create per loro oppure no. E ce ne sono altre, troppo lontane dal loro campo di esperienza, troppo dissonanti con le loro strutture mentali o con il loro mondo sentimentale, troppo discordi con il loro vocabolario perché essi possano in qualche modo goderne. Ma non esiste quella cosa che possa essere poesia per i bambini e non-poesia per gli adulti.
Sono quasi luoghi comuni e ci si potrebbe lavorare sopra solo per tautologie. Sono poi la traduzione affrettata, l’applicazione automatica della legge generale secondo la quale non esisterebbe una letteratura per bambini, ma solo libri dei quali anche i bambini si possono impadronire. Questa legge ha esercitato tanto a lungo tra noi il suo impero, diciamo pure la sua dittatura, ed è cosi comoda da adoperare, che è diventato quasi obbligatorio renderle omaggio anche quando si ha intenzione di violarla, per darsi un’opinione diversa.
Libri di prose o di versi potrebbero giungere ai bambini solo per caduta, così come ad essi sono giunte le fiabe, nate con tutt’altri caratteri da quello di "trattenimento dei piccirilli", o le maschere del teatro, l’arco e le frecce della tribù primitiva; oggetti già sacri e rituali come la trottola o la bambola, e cosi via. Il che è stato certamente vero fino a quando il bambino è rimasto una semplice appendice della società adulta, senza il diritto di avanzare esigenze proprie, rivendicazioni autonome. In generale non sembrerebbe più vero da quando il bambino è stato scoperto dall’industria, prima come lavoratore poi come consumatore, valorizzato dalla pedagogia, studiato dalla psicologia.
Oggi, poi, in presenza di un’industria culturale che, al seguito dell’allargamento della scolarizzazione e dell’obbligo scolastico, va scoprendo il pubblico infantile, l’ostacolo teorico non viene negato, ma semplicemente rimosso. Dopo aver imparato a distinguere tra poesia e cultura, abbiamo imparato a distinguere anche tra cultura e industria culturale. A loro volta i bambini, hanno imparato a manovrare una infinità di strumenti, dal giradischi al registratore, dal proiettore alla radio, al televisore, con i quali compiono certamente esperienze diverse da quelle del bambino di cento anni fa, che a sei anni di massima andava a zappare la terra o a lavorare in filanda. Bisogna tenerne conto, per parlare di poesia e di bambini, oppure no?
Ecco insomma affollarsi i dubbi e le domande intorno alla perentoria risposta negativa da cui siamo partiti. Per lo meno si sente il bisogno di articolarla, secondo determinazioni più controllate. Anche le teorie estetiche hanno camminato, sotto il pungolo della linguistica, l’offensiva della semeiotica. Possiamo allora sospendere la risposta e fare qualche indagine preventiva. Può darsi ci capiti di scoprire che la stessa domanda non sia del tutto precisa nell’indicare i termini della questione – che le sfugga la realtà dei rapporti tra il bambino e la poesia.
Ninne-nanne e filastrocche
Una prima indagine da fare mi sembra quella relativa agli incontri e agli usi della poesia che il bambino fa spontaneamente nei primi anni di vita. Poesia, in questo caso, popolare, secondo l’individuazione che ne fece per primo, nella cultura europea, lo Herder, seguito dai romantici. Parlo delle ninne nanne, nella ristretta misura in cui esse sono ancora vive e non siano già precocemente sostituite dai rumori di Carosello. Parlo delle filastrocche, cantilene e tiritere popolari che, per lo meno nel mondo contadino, hanno ancora una qualche esistenza e funzione; delle contine, che continuano a far parte del rituale dei giochi, distribuendo i ruoli in base a una formula magica; delle preghiere in rima, dei proverbi, dei nonsensi che accompagnano da sempre certi giochi tra adulto e bambino. Si tratta di forme che appartengono, per lo più, a patrimoni regionali, dialettali, a circolazione limitata. Noi non possediamo un "corpus" nazionale di queste creazioni del folclore. Anche per le fiabe, del resto, abbiamo dovuto accontentarci per molto tempo di raccolte regionali, quando già in altri paesi, dalla Germania dei Grimm alla Russia di Afanasjev, prima l’entusiasmo dei romantici, poi quello dei folcloristi, avevano portato alla nascita di grandi raccolte nazionali, in un certo senso anche nazionaliste, cioè progettate e sentite come contributi alla formazione di uno spirito nazionale.
Per quel che riguarda le rime popolari certo i lavori più importanti, con diversi intendimenti, sono quelli dei tedeschi: la raccolta dei Volkslieder dello Herder, che per altro aveva una sua visione non soltanto nazionale del carattere e dell’importanza dei canti popolari; e il Des Knaben Wunderhorn, di Achim von Arnim e Clemens Brentano, al quale capitò la fortuna, o la disdetta, di ricevere un riconoscimento ufficiale dal governo prussiano, per il " patriottismo " cui faceva appello, nel momento in cui era all’ordine del giorno la " liberazione dai francesi " (sono parole del ministro prussiano degli interni, von Stein). A proposito di questa raccolta, e singolare che, accogliendovi anche poesie di Goethe, accanto a canzoni anonime, gli autori proclamassero "popolare non solo ciò che è fatto, ma ciò che è accolto dal popolo ". Non vedo però in Europa e fuori un paese che abbia qualcosa di paragonabile alle Nursery Rhymes inglesi, una raccolta che si è fatta da sola nel tempo e che è parte integrante dell'unità linguistica dell’Inghilterra, strettamente intrecciata al costume nazionale, tanto che i suoi personaggi, le sue rime burlesche, sono entrati nel repertorio delle citazioni quotidiane e col loro spirito hanno decisamente influito sulla nascita di un capolavoro come "Alice nel paese delle meraviglie", che si nutre di " nursery rhymes " almeno quanto Pinocchio si nutre di fiabe popolari toscane. Anche il nonsense letterario, il " limerick ", un genere in cui è diventato famoso Edward Lear, ma che è praticabile da tutti, grazie a una formula fissata con grande precisione e facilissima da adottare, entra nel patrimonio di ogni bambino inglese: è un genere in cui il popolare e l’infantile si fondono felicemente.
In Francia, il Trésor de la poésie populaire, di Claude Roy, fa largo spazio a contine, ninne nanne eccetera, come a testi di canzoni, ballate, storie di " images d’Epinal ", in un’antologia di un folclore duro a morire proprio perché si esprime di preferenza nella lingua nazionale. Le differenze brevemente accennate fra la tradizione italiana, sparsa per cento rivoli a lungo incomunicanti, e la tradizione tedesca, inglese, francese, non sono davvero casuali. Inglesi e francesi hanno raggiunto la loro unità nazionale, anche linguistica, molto prima di noi. In Germania l’unificazione politica è avvenuta in ritardo, ma il sentimento nazionale tedesco aveva già travato il modo di esprimersi, prima nella Riforma (è appena necessario accennare ai canti di Lutero), poi nel Romanticismo e nella sua filosofia. Si tratta di paesi in cui, per strade diverse, è caduto prima che da noi il solco tra letteratura e popolo, il ritmo della rivoluzione borghese è stato o più rapido o meno contraddittorio.
L’incontro con la poesia popolare è dunque il primo incontro del bambino, e che questo avvenga in prevalenza su basi dialettali ha la sua importanza, certo, ma non muta la qualità dell’incontro, la sua ricchezza emotiva.
Si tratta pur sempre di incontri che sono situazioni vive, non artificiose. La madre che canta la ninna nanna e il bimbo che si addormenta ascoltandola vivono una situazione reale, di cui le parole e la musica sono l’espressione poetica. Vita e poesia sono la stessa cosa nella voce che canta e fornisce insieme la sostanza dell’espressione e la sua forma, il contenuto e le sue forme. Nella ninna nanna le parole tendono a scomparire, a diventare un sottovoce, un canto a bocca chiusa. Tende insomma a prevalere la musica, di cui sarebbe sbagliato vedere solo la funzione rassicurante, consolatoria, il rifornimento di protezione e tranquillità di cui è la fonte. Il bambino vive pienamente quel momento che è anche formativo della sua mente e della sua sensibilità. La voce che canta, come ogni altro segno, indizio o sintomo del mondo che lo circonda, è una guida alla scoperta della realtà e delle sue forme.
La scoperta del ritmo
La filastrocca gli dà qualcosa di diverso. Intanto, una prima esperienza del ritmo che sembra svilupparsi naturalmente sui più semplici ritmi che il bambino scopre in modo autonomo. Se il pensiero del bambino, come ci spiega il Wallon, nasce per coppie (e Klee rincara: "non ci sono concetti, ma coppie di concetti") cosi anche il primo ritmo è semplicemente un movimento binario, un ta-ta, che si presta a infinite ripetizioni. Binario è in genere il ritmo delle filastrocche popolari: giro-giro-ton-do. Quattro quarti è il loro tempo naturale, nella trascrizione musicale. L’effetto di monotonia, e dunque di povertà ritmica, che ne consegue, è corretto dalla notevole libertà di cui la filastrocca popolare gode nella distribuzione delle sillabe. Mentre la metrica italiana classica conta le sillabe con molto rigore, pur ammettendo il meccanismo delle elisioni, la filastrocca popolare conta gli accenti, non le sillabe: la sua battuta, come la battuta musicale, consente una "taktfuellung" abbastanza variata. Possiamo sentirla molto bene in questa filastrocca pugliese (trascritta nei quaderni della fondazione Basso):
Pizzi pizzi strangulizzi
la Maria facia lu pane
tutte le musche lu spurcane
lu spurcane a quattro a quattro
lu fischiettu m’ha ruttu lu piattu
(i primi due versi sono ottonari, novenario il terzo, ottonario il quarto, decasillabo il quinto). La metrica inglese e quella tedesca permettono libertà sillabiche del genere. Heine ne ha fatto un uso straordinariamente ricco. La scoperta principale della filastrocca, accanto a quella del ritmo, è quella della rima. Essa consente l’identificazione di coppie di parole per assonanza, dunque arricchisce il bambino di un nuovo strumento conoscitivo e linguistico. Il piacere caratteristico delle filastrocche non mi sembra tanto quello della ripetizione, che certo vi ha la sua parte, quanto per l’appunto questo, di scoprire nuove parentele di parole, nuove classi. La scoperta è accompagnata da una sorpresa piacevole, che provoca il riso. Nella filastrocca il linguaggio è goduto in sé, contemplato e sentito indipendentemente dagli usi pratici. E’ già quel "parlare per parlare" in cui Novalis aveva riconosciuto la " formula liberatoria ". Si parla per agire, si parla per essere, si parla per dire: ed ecco, si parla per parlare, per scoprire nient’altro che le parole e i loro suoni, le loro analogie segrete, per vivere di parole, per lasciarsene incantare e trascinare. Così ricca, complessa e formativa in più sensi ci appare l’esperienza del bambino che galoppa sulle ginocchia del padre, al ritmo di una filastrocca: e la conclusione non è soltanto un suono più sorprendente degli altri, è talvolta un movimento improvviso (il padre finge di lasciar cadere il bambino, per esempio), cioè il piacere della paura.
Le " conte "
Le contine, offrono un’esperienza diversa. Esse sono un fatto rituale: stabiliscono la regola del gioco, assegnano i ruoli. Il bambino accetta questa regola, e accettandola dà alla contina quasi un valore magico, che del resto la contina merita, perché spesso non è che un antico scongiuro ridotto a strumento di gioco infantile. Poesia e magia sono, alle loro origini, strettamente intrecciate e i bambini sono forse gli ultimi ad accettare che siano poche sillabe, quasi sempre senza senso, a governare i loro atti: an bara bai, cicì, cocò... Ara bell’ara discesa Cornara... An ghin go - tre galline e tre cappò... Qualche volta è possibile seguire all’indietro la contina, rintracciare indizi della sua storia. Così è per esempio per la contina settentrionale che fa: Enkete penkete puffetiné - abeli fabeli domniné...
Ce n’è una tale e quale in Jugoslavia: nelle prime parole è possibile riconoscere il verbo tedesco "impiccare" "haengen". E’ una specie di ballata della forca (austro-ungarica nella specie). Così nella cantilena infantile dei bambini inglesi sul ponte di Londra che casca, è addirittura possibile, come dicono i folcloristi, rintracciare un lontano ricordo dei sacrifici umani che accompagnavano le nuove costruzioni.
Nelle contine, insomma, sono precipitati relitti d’ogni genere. E ne entrano continuamente dei nuovi, se in Sardegna usano ora una contina che comincia: "Gigi Riva che sai giocare - quanti gol mi puoi segnare – posso segnarne ventitré - uno, due tre". Alle contine, per il loro carattere rituale, possiamo associarle sequenze che si recitano per accompagnare un gioco: i bravi tamburini, la bella lavanderina, palla pallina, che recitano le bambine battendo la palla contro il muro. Quest’ultimo tipo di filastrocca rituale ha un diretto collegamento con il comportamento spontaneo del bambino che spesso, mentre gioca, si accompagna con le parole, per descrivere il proprio gioco, per allargarne le frontiere con l’immaginazione. Quando egli interiorizza il linguaggio e non ha più bisogno di questo monologo a voce alta per pensare, la filastrocca rituale gli serve ancora per passare dalla legge interiore a quella esteriore: la sua esperienza giustifica quel modo di accompagnare il gioco e la filastrocca gli traccia davanti il binario dei gesti e dei movimenti, come una sfida, una difficoltà liberamente scelta.
Le preghiere rimate, parlo di quelle autenticamente popolari, partecipano della filastrocca e del rito. Non credo che siano un autentico "pregare". Possono servire di fondamento a un’educazione religiosa? Non credo nemmeno questo, a meno di scambiare per educazione religiosa l’abitudine a recitare formule di preghiera senza vera partecipazione. Il loro significato sta piuttosto in quella disposizione al raccoglimento, alla compostezza che favoriscono e che solo in senso molto lato possiamo definire religiosa. Rispondono a quel registro infantile che Luigi Santucci ha chiamato dell'"accovacciato". Ciò che le distingue essenzialmente è il loro carattere serio" in opposizione al carattere giocoso delle filastrocche, delle contine, eccetera.
Le situazioni descritte hanno in comune di essere situazioni vitali, nelle quali le varie forme della poesia popolare sorgono direttamente dai singoli e diversi momenti della vita e trovano in essi la loro motivazione. L’ascolto o l’apprendimento da parte del bambino di quei testi avviene senza forzature di nessun tipo, in modo spontaneo, almeno nella misura in cui di spontaneità è veramente lecito parlare: in sostanza sono elementi del modello culturale ambientale che agiscono sul bambino senza distrarlo, per così dire, dal suo essere bambino. Sul bambino, e non, per esempio, sullo scolaro.
L’esperienza che il bambino compie per mezzo di quei testi è esperienza vitale nel senso che non è finalizzata ad altro, o ad altri che a lui. Dipende da lui l’intensità con cui possono influire sulla sua formazione, l’intensità della sua reazione attiva, autoriflessiva, ai vari stimoli che essi gli forniscono, sul piano dei meccanismi del riso, di quelli del linguaggio, di quelli logici e fantastici. Sappiamo quanto il linguaggio conti nella formazione delle strutture mentali: anche i testi della poesia popolare sono momenti privilegiati del linguaggio, ne suggeriscono un uso libero e autonomo, sono linguaggio per gioco, linguaggio immaginato. E’ dunque già esperienza di poesia quella che il bambino compie per loro mezzo. La definizione di poesia popolare, del resto, è una definizione di comodo. Forse sarebbe più giusto parlare di poesia orale, in opposizione alla poesia scritta, riferendosi alla sostanza dell’espressione più che alla sua forma.
Alla poesia popolare si collegano direttamente, ispirandosi ai suoi modi, ai suoi ritmi, alle sue figure, non pochi poeti di tutte le letterature, da Puskin che mette in versi le fiabe russe, al Goethe di certe ariette – Roeslein, Roeslein, Roeslein rot - Roeslein auf der Heide –, allo Heine di certe ballate, al Pascoli letteratissimo ma capace di movimenti semplici, di cantilena, al Valeri di certe canzonette, e cosi via. Vi si avvicinano talvolta i crepuscolari. Il collegamento può essere indiretto e passare attraverso la nostalgia per l’infanzia: cosi per esempio nel Child Garden of Verses di R. L. Stevenson, uno tra i più illustri esempi di un grande scrittore che abbia voluto parlare direttamente ai bambini (Tolstoj è, per la prosa, l’esempio massimo).
Talvolta è un collegamento più diretto: per esempio quello di Carrol col mondo dei nonsenses popolari inglesi. Il caso di Carroll, tuttavia, è abbastanza speciale. Non si tratta più di un poeta che occasionalmente, per una certa disposizione d’animo, presta la sua voce a una tradizione diversa da quella letteraria e finisce per incontrarsi con i bambini sul loro terreno, spesso senza averlo pensato; ma di uno scrittore che volta decisamente le spalle a tutto per mettersi a giocare con i bambini. Ha scelto lui il loro terreno, e vi si è collocato intero, col suo gusto per la matematica e per la logica, con i suoi umori dissacranti nei confronti dell’accademia e dell’arcadia.
Il " giocattolo poetico "
Sul fatto che sia legittimo rivolgersi ai bambini in versi, per interessarli, divertirli, per dire loro cose che dette in altro modo non ascolterebbero, per dare loro immagini stimolanti, per nutrire e formare la loro immaginazione, io non ho davvero dubbi. Io stesso – la citazione mi sembra doverosa, non immodesta – ho scritto molti versi per bambini. Per lo più comici, raramente gnomici, didascalici. Non li ho mai chiamati poesie, ma filastrocche. Semmai "poesie per ridere", o "poesie per isbaglio". Non mi ha mai interessato, in relazione al mio lavoro, sapere se fossero poesie o no: ho sempre preferito accantonare il problema, dichiarandomi un fabbricante di giocattoli, di giochi con le parole e con le immagini, di comunicazioni e provocazioni in versi. Ho utilizzato coscientemente anche certi poeti che amo, da Palazzeschi ai surrealisti, perché mi fornivano un linguaggio cosi vicino a quello della poesia popolare e, al tempo stesso – rispetto alle sue tradizioni – cosi rivoluzionario, che l’accostamento doveva per forza riuscire a qualche effetto sorprendente. Ho pubblicato le prime filastrocche in un quotidiano: e da un quotidiano si può parlare al pubblico solo in un certo modo, tenendo presente anche quel che succede sulle altre pagine. Non ho trascurato di tener conto che i bambini d’oggi traggono le loro informazioni e i loro stimoli dalla televisione, dal cinema, dal mondo della tecnologia, della pubblicità: per farsi ascoltare da loro è indispensabile ricordarsene.
Naturalmente ho i miei alibi anch’io: non ho mai pensato prima a un contenuto, a una lezione qualsiasi, da immettere in questi o quei versi; ho seguito liberamente e sinceramente le parole, dove mi portavano, cancellando, dove potevo, quelle che avrebbero creato difficoltà eccessive ai lettori. Questo porsi dei limiti, accettare una certa chiave, fa parte della scommessa. E’ un modo di porsi, per cosi dire, al servizio dei bambini. Dunque dei bambini, non della poesia.
Penso che altri facciano lo stesso, senza preoccuparsi di interpretare teoricamente il significato del loro lavoro. Lo fanno perché credono di fare cosa utile. Su questo terreno, la discussione non riguarda più, evidentemente, la poesia o la non poesia. Riguarda il modo di porsi al servizio dei bambini. Perché crescano, non perché restino bambini. E questo sgombra il campo da tutta la produzione bamboleggiante, falsamente pedagogica, che qualche volta si fa passare per "poesia per bambini"; che non è né "poesia" né "non-poesia": è pedagogia sbagliata. Non può essere nemmeno definita "poesia di consumo", come potrebbero essere i versetti del Bonaventura o le parole delle canzoni dello "zecchino d’oro".
Mi sembra di aver detto, così, che credo alla cosiddetta "poesia per bambini" solo quando si pone onestamente come gioco poetico, come giocattolo, prendendo questa parola in tutta la sua nobiltà. Il giocattolo poetico, con tutte le sue possibilità (dal comico al drammatico), mi sembra un necessario ponte di passaggio tra la poesia popolare della prima infanzia e la poesia propriamente detta, quella che non può tener conto del destinatario e, delle sue esigenze egocentriche, che non può accettare chiavi riduttive, insomma che deve liberamente proiettare sul suo cammino tutte le possibilità del linguaggio, tutti i suoi possibili significati.
Può darsi che il giocattolo poetico si riveli, occasionalmente, poesia. Ma sarà un risultato da accettare come un dono non cercato. In questo caso la massima evangelica va rovesciata: servi i bambini, e il regno dei Cieli (la poesia) ti sarà dato per sovrappiù.
Ora a me sembra che l’allargamento dell’istruzione, la nascita (stentata fin che si vuole) di una scuola per l’infanzia al posto dei vecchi asili-deposito di bambini, l’esplosione dei nuovi mezzi di comunicazione abbiano non già diminuito, ma enormemente accresciuto la richiesta di quello che ho chiamato "giocattolo poetico", cioè di parole con le quali i bambini possano crescere. Poesia, non-poesia, che importa? Il dilemma ha anche un aspetto ozioso, aristocratico. Quello che importa è dare ai bambini, con qualunque mezzo, parole vere, non suoni superflui da dimenticare immediatamente. E intendo, con parole vere, parole pronunciate da un adulto impegnato con la sua totalità in questa creazione. Parole vere, cioè piene.
Un esempio: Gatto
L’ideale sarebbe che a fabbricare questi giocattoli, a tenere ai bambini quei discorsi, a inventare per loro quelle musichette, quelle strade di parole che li possono guidare alla scoperta della poesia, fosse sempre un poeta.
Ho preso tutti i bambini per mano,
andiamo in corsa per la città.
Alto più alto, nano più nano,
evviva evviva la libertà.
E’ Alfonso Gatto che chiama così, dal suo "Vaporetto" di "poesie, fiabe, rime, ballate per i bambini d’ogni età", dichiarando fin dal titolo la sua consapevolezza di far poesia senza età, e nel tempo stesso accettando i limiti dell’occasione, scegliendosi un pubblico, mettendosi al suo servizio.
Non date retta al re,
non date retta a me.
Chi v’inganna
si fa sempre più alto d’una spanna,
mette sempre un berretto,
incede eretto
con tante medaglie sul petto.
Non date retta al saggio,
al maestro del villaggio,
al maestro della città
che vi dice che sa...
Questo, con quel che segue, è un vero " discorso in rima ": nasce da un semplice gioco di rime baciate, nella tradizione popolare; non si allontana da un tipo di canto facile, in un senso però diverso dal modo come è di solito " facile " il canto di Alfonso Gatto; le rime non cadono per tranquillizzare, per acquietare, ma per sorprendere e provocare, per negare la tradizione in nome di una moralità più alta ("sbagliate solo da voi"); i personaggi evocati cadono come birilli sotto quel colpo preciso – " non date retta " – che è proprio il contrario della morale che viene predicata, per esempio, a Pinocchio, e che spesso comincia proprio con un " dà retta... ". Il giocattolo verbale chiama i bambini a un gioco tutt’altro che infantile. Gatto non bamboleggia, rimane adulto in ogni parola. Fortuna sua, rimane anche in ogni parola poeta.
Ma non disdegna di usare modi minori, di prosa appena corretta da accenni di musica, se gli preme più la cosa da dire che il modo di dirla:
Tre bambini stanno zitti
zitti come coscritti
davanti al caporale.
E la mamma li guarda sospettosa,
gli dice: " vi sentite male
o state macchinando qualche cosa? "
Come vedete è falso, l’oro.
Il silenzio non è d’oro.
Eccetera. Qui non vedo poesia. La necessità di usare quelle parole, collocandole in quella sequenza, è una necessità pratica: il raccontino, in prosa, sarebbe stato meno libero, meno attraente, meno giocattolo; le parole che contano "zitti", "oro", non avrebbero avuto quel rilievo, l’immagine del caporale non avrebbe ricevuto la conferma dalla rima con " male ". Gatto stesso doveva sapere che il suo libro era fatto di materie diverse, se nel sottotitolo ha distinto le " poesie ", dalle " rime ", dalle " ballate ". E mi sembra molto bello che un poeta come lui abbia accettato di firmare, per così dire, un ibrido, un libro che il critico letterario non basta a classificare, e si classifica benissimo, invece, dal punto di vista del bambino, del suo piacere, perfino del suo utile. Il libro rappresenta, più o meno, un caso di felice incontro tra un poeta e un padre affettuoso.
In questo libro il bambino non può riconoscere, da solo, poesia da non poesia. Il bambino è per conto suo, per sua necessità, contenutista. Se dovesse indicare la poesia che gli piace di più, probabilmente non riuscirebbe a indicare quella che gli ha vera mente parlato di più, quella in cui l’emozione gli è venuta dalla forma anziché dal soggetto, in cui ha sentito vibrare l’insolita carica di significato della parola poetica. La sua esperienza della poesia può rimanere inconsapevole: questo non vuol dire che questa esperienza non ci sia stata.
L’incontro con la lettura
Col bambino che legge, però, siamo già a scuola. E’ qui che avviene il vero e proprio incontro tra il bambino e la poesia. O non avviene, secondo i casi. Il semplice fatto di dover imparare a memoria delle poesie non è ancora un incontro tra il bambino e la poesia.
A scuola avviene di solito anche il graduale passaggio dalla poesia popolare, dal giocattolo poetico, alla poesia vera e propria. La scuola è o dovrebbe essere la grande mediatrice. In un certo senso, però, la scuola e costretta a graduare quell’incontro da difficoltà che non riguardano tanto la poesia, quanto l’apprendimento del leggere e dello scrivere. Le difficoltà d’ogni genere che comporta questo apprendimento sono note e io non vi insisterò se non per dire che di solito esse sono sottovalutate, al punto che il libro di lettura è caricato di compiti che con l’apprendimento della lettura non hanno niente a che fare: copiatura, divisione in sillabe, analisi grammaticale, analisi logica, eccetera. Il libro diventa facilmente uno strumento di tortura. La lettura non è più una scoperta, ma un esercizio; non è un momento vitale, ma un adempimento burocratico, finalizzato all’interrogazione, al giudizio, alla pagella, eccetera. In queste condizioni, ogni discorso sulla poesia cade, non ha senso.
Anche ipotizzando le condizioni migliori dal punto di vista didattico, rimane la necessità di fornire ai bambini, nei primi due o tre anni di scuola, testi facili, anche più facili di quelli che il bambino potrebbe affrontare oralmente: la lettura è in un certo senso una riconquista del lessico da un nuovo punto di vista. Sembrano indispensabili testi di mediazione e anche versi di mediazione, che consentano la riconquista sul terreno della parola scritta delle scoperte che il bambino aveva già compiuto a contatto con la poesia popolare: il ritmo, la rima, il gusto della parola per la parola. E’ il momento delle filastrocche, delle canzonette, delle poesie per gioco, delle rime facili, del giocattolo poetico, come ben sanno i compilatori di libri di lettura per il primo ciclo. I quali non sempre tengono conto, tuttavia, che si tratta di un momento importante non in ordine all’apprendimento della lettura, ma in ordine alla formazione di una sensibilità per le possibilità del linguaggio, cioè per la poesia. Gli errori di gusto, in questa fase, possono avere conseguenze gravi. La poesia è la più alta forma di conoscenza ed esplorazione del linguaggio: anche a livello di gioco, di mediazione e preparazione, bisogna che essa si presenti con una sua dignità, una sua capacità di emozione e sorpresa, che parli per così dire un po’ più in alto del bambino, lo faccia salire sul piano dove anche le parole più semplici possano rivelare significati nuovi e le immagini offrano un’autentica possibilità di lavoro alla fantasia.
Perché l’esperienza abbia già carattere di esperienza poetica bisogna che essa abbia come perno principale la parola, cioè la forma dell’espressione e la forma del contenuto, più del contenuto stesso. La scelta non può dunque essere di carattere contenutistico. Voglio dire che distribuire i versi nel libro secondo le esigenze del calendario, anziché secondo quelle dell’educazione alla poesia, è nocivo e arbitrario. Le stagioni, le feste, le esigenze, reali o presunte, della formazione morale, religiosa, ideologica e simili, che in molti libri predominano, rispetto a quelle della qualità dei testi, sono in realtà motivazioni esteriori: questa riduzione della poesia a forme didascaliche mette tra parentesi la sostanza, che è l’incontro con il linguaggio e la sua libertà.
Dalla terza in su mi pare che il discorso cambi. Quando le difficoltà della lettura stanno diminuendo e già per molti bambini il rapporto con la parola scritta non è più un lavoro di decifrazione di segni, ma di uso libero e fantastico di quei segni, emerge la possibilità di favorire l’incontro con la poesia vera, la poesia grande, senza più aggettivi limitativi. Il bambino, e anche il ragazzo, continueranno ad aver bisogno di giocattoli, anche verbali, ma sta maturando in loro una maggiore capacità di impegno umano. Lo stesso loro bisogno di crescere, di conquistare più pienamente la realtà, li rende capaci di sforzi maggiori. Al tempo stesso la loro disponibilità per le emozioni, i sentimenti, gli ideali, l’assenza in loro di grettezza, il disinteresse con cui spendono le loro energie, li apre ad accogliere il messaggio poetico, che è un messaggio a vivere più in alto, è sempre un invito a " egregie cose ".
" Lungi dal proprio ramo... "
Siamo in una quarta elementare. La maestra invita i ragazzi a scegliersi, entro una settimana, nel loro libro di lettura, la poesia che preferiscono. Essa ha capito che l’incontro con la poesia non può fare a meno di un carattere personale, privato e, insieme, di scoperta, di avventura. Ha abbandonato da tempo la vecchia pratica di dettare o indicare una certa poesia, illustrarla brevemente, assegnarla per lo studio a memoria, ascoltarne la recitazione, giudicarla con un voto. Non si può usare la poesia per una pratica del genere: sarebbe come usare un orologio d’oro per piantare un chiodo nel muro. Per i chiodi esistono altri martelli.
Non tutti i ragazzi scelgono: chi per distrazione, chi perché ancora sordo a certi richiami, chi per paura di sbagliare. La maggioranza, però, sceglie e nelle sue scelte appare molto divisa, anche se non sarebbe difficile distinguere quelli che hanno scelto in proprio da quelli che hanno scelto per imitazione. Tra le poesie scelte c’è " Lungi dal proprio ramo - povera foglia frale ", di Leopardi, ce n’è una di Ungaretti. Ogni ragazzo legge la poesia che ha scelto, la spiega se può, nasce una certa discussione. I ragazzi vogliono ora sentire la maestra leggere essa stessa le poesie scelte. Essa legge, aggiunge spiegazioni puramente lessicali. La mattinata se n’è quasi andata: qualcuno già si è messo a fare un disegno sulla poesia che ha scelto. C’è appena il tempo di una specie di votazione. Si scrivono tutti i titoli – una decina – sulla lavagna. Si vota per la poesia più bella. Viene scelta la poesia di Leopardi. Appena un’ora fa molti ragazzi ridevano di quelle parole inconsuete " lungi ", " frale ": evidentemente fraintendevano la sorpresa che li aveva colpiti. Ora l’hanno interiorizzata. Ora sono proprio quelle parole ad affascinarli. I loro commenti sono: com’è detto bene – non si potrebbe dire meglio – è triste ma non fa piangere (La poesia e sempre una vittoria sul dolore.)
La maestra è prudente, non insiste, non assegna poesie da studiare a memoria. La mattinata è stata piena di emozioni. Anche il verso di Ungaretti: è il mio cuore il paese più straziato... è stato a lungo sentito, assaporato, lasciato fluttuare nell’aria a caricarsi di echi.
Qualche giorno dopo la maestra ha portato a scuola un piccolo schedario di poesie, da lei stessa ricopiate su alcuni cartoncini, per porle a disposizione dei ragazzi. Tra quelle poesie, la bella ballata del Carducci "Sul Castello di Verona – batte il sole a mezzogiorno". Non so per quante settimane quelle poesie siano rimaste là, come un discreto silenzioso richiamo. So che a un certo punto il castello di Verona era diventato, tra quei ragazzi, quasi una moda: e i versi che si ripetevano più spesso erano quelli in cui la parola del canto era più precisa, più ricca di storia, con venature arcaiche che collocavano la leggenda in una lontananza linguistica oltre che temporale: " Il gridar d’un damigello – risuonò fuor della chiostra "... " i donzelli ivano "... o quelli in cui con maggiore schiettezza il Carducci ha raggiunto i toni della poesia popolare, a un giro più alto della spirale: " mala bestia è questa mia – mal cavallo mi toccò – sol la vergine Maria – sa quand’io ritornerò... ".
Alla fine dell’anno i ragazzi conoscevano a memoria diverse poesie, non tutti le stesse, ma quelle che avevano scelte e frequentate più spesso, e che si erano fissate nella loro memoria da sole, così come a noi si fissano nella mente le poesie che amiamo. Potrei citare a memoria anch’io molti versi di Montale, di Gatto, di Sereni, di Luzi, di Betocchi, di Holderlin, di Apollinaire, di Eluard, dei poeti scoperti e frequentati nell’adolescenza, negli anni delle grandi e decisive passioni. E se ripenso al carattere di quelle mie scoperte, mi sembra, per limitarmi alla poesia italiana, che fosse quella di una lingua contemporanea salvata nella sua serietà, nella sua dignità, nella sua capacità di elevare, di accendere la mente, mentre intorno il regime fascista faceva di quella lingua l’uso che sappiamo. Credo che quei poeti abbiano molto aiutato, noi, allora giovani, a concepire un atteggiamento verso la vita diverso da quello che avrebbe voluto instillarci una propaganda tanto volgare quanto onnipresente, fosse anche solo nel riconoscere quel che non eravamo, quel che non volevamo. L’esperienza della poesia che hanno avuto i ragazzi di cui ho detto non è stata superficiale, scolastica, ma vitale, profonda. La poesia è entrata per cosi dire nella loro vita: non nei compiti di scuola, che non sono vita; la scuola può educare solo se si nega come scuola, se ricrea in se stessa le condizioni della vita. Hanno imparato a memoria dei versi nel solo modo utile, cioè perché li hanno amati e vissuti. Non è stata per loro, quell’esperienza, la formazione di un riflesso scolastico: ma la prima formazione di un gusto, di un bisogno intellettuale e morale.
Perché questo accada, s’intende, bisogna che i ragazzi abbiano una scelta ampia, alla quale non basta il libro di lettura, come non basta l’antologia, nella scuola media. E bisogna che questa scelta sia libera, bisogna che trovi in se stessa le sue motivazioni. Gli stessi ragazzi di cui ho detto avevano preso l’abitudine di incidere su un registratore le poesie che amavano: riascoltandosi mentre le leggevano o le recitavano essi erano i primi a cogliere il momento in cui la voce veniva meno alla parola, non la rivelava, l’espressione non aderiva alla forma, ma era suono vuoto. In questo ascolto essi proseguivano l’esplorazione della poesia, la conquistavano sempre meglio, in tutti i sensi. Una poesia poteva esaurire il loro interesse in una settimana, un’altra bastava per mesi. Anche quell’ascolto aveva, mi sembra, il carattere autoriflessivo che ha nell’arte il linguaggio. Essi in fondo ricreavano il linguaggio di quelle poesie e cosi penetravano davvero nel segreto della poesia, che è uno sforzo di continua ricreazione del linguaggio.
Nella scelta di cui si è detto, ovviamente, i ragazzi vanno aiutati. Tocca all’educatore la prima ricerca, quella per individuare nel patrimonio poetico della lingua le parti che possono meglio riuscire all’incontro tra i ragazzi e la poesia. Tutta la poesia a tutti i ragazzi e un non-senso, per tante ragioni. La loro comprensione ha dei limiti, come ne hanno la loro esperienza di vita, la loro stessa capacità di sforzo, di misurarsi con i sentimenti e le idee dell’adulto, la loro conoscenza della realtà. Sempre che si scelga per aiutarli, non per imporre loro dei limiti a nostro giudizio. Scarteranno da soli le poesie che assolutamente "non capiscono".
Si dirà che in questo modo si abusa della poesia, introducendo in essa distinzioni che non le appartengono. Ma anche qui, anche di fronte alla poesia, vale per noi il punto di vista dei ragazzi e dei bambini. In loro nome abbiamo tutto il diritto di ricavare un’antologia di poesia per bambini, o per ragazzi – e in questo caso parleremo con sicurezza di poesia, e non di giocattolo poetico, o di introduzione alla poesia – dal patrimonio della poesia senza aggettivi. E il modo, l’intelligenza, l’apertura, il coraggio con cui sarà fatta l’operazione non risulteranno meno importanti del modo come la poesia verrà presentata ai bambini e ai ragazzi: non come un obbligo scolastico, ma come un paese da scoprire.
La poesia dei bambini
Credo che dobbiamo dire qualcosa, dopo aver parlato di poesia per l’infanzia, anche delle poesie dei bambini. Ne sono sempre nate, nelle scuole, ricevendo o no una valorizzazione, spesso equivoca. Ne nascono oggi, penso che ne nasceranno sempre più domani, via via che si faranno strada due idee, per ora quasi embrionali: la prima, che l’insegnamento debba essere sempre più creativo; la seconda, che il bambino, più in generale l’uomo, debba essere considerato non tanto un semplice consumatore di cultura – di libri, di poesia – ma un produttore di cultura, e anche, perché no, di poesia.
Un'attività di invenzione verbale è presente nelle manifestazioni spontanee del bambino nei suoi primi anni di vita. Egli può, di volta in volta, scoprire una parola e cantarsela o trovarle un ritmo, una melodia e adattarvi delle parole. A volte parola e canto nascono insieme. A volte è la scoperta di una rima buffa, che ne chiama altre, che chiama a storpiare le parole, per obbligarle a rimare. Il bambino gioca con gli accrescitivi, con i diminutivi, con i nomi propri. Nomina insieme, senza distinguere, gli oggetti che vede, le proprie emozioni, le fiabe che conosce, come in questa canzoncina di una bambina di tre anni: Tavolino, non cantare che viene il lupo... Sedia, non cantare che viene il lupo... Mamma, non cantare che viene il lupo... Che è insieme gioco, esorcismo, uso magico della parola, espressione immediata, automatica, nella quale la condensazione delle immagini (tavolino, non cantare...) ha qualcosa di simile a quella di cui fa uso il sogno, nella sua tecnica, descritta da Freud. Questi spunti, o germogli, o brandelli di creatività presentano un grande interesse e andrebbero studiati con maggiore attenzione di quanto non si faccia. Studiati, voglio dire, non solo da un punto di vista psicologico, non solo dal punto di vista della formazione del linguaggio, ma del contributo che essi danno alla formazione delle prime strutture mentali. Così andrebbero registrati e studiati i monologhi con cui spesso il bambino accompagna il gioco che sta facendo, e nei quali sono presenti tipi diversi di espressione, di affabulazione, di creatività. E’ un lavoro che si è cominciato a fare nelle scuole dell’infanzia (già materne); per esempio a Reggio Emilia, col gioco del " cantastorie ", durante il quale i bambini inventano delle storie, del tutto liberamente, o utilizzando stimoli semplicissimi, suggeriti dall’adulto.
Veniamo invece ai testi poetici che ci danno i bambini nelle scuole elementari. Eccone uno, intitolato Paese triste
Re della luce
perché ti nascondi
nella nebbia fitta?
Prima il paese
era brillante
lucente
dorato.
Ora è triste
senza i colori
e senza i bambini
per le strade.
Avrete subito avvertito una singolare pulizia e nettezza verbale. Il tema fantastico è molto semplice e si sviluppa sull’opposizione quasi obbligatoria: sole – nebbia; il paese visto col sole, il paese visto nella nebbia; che a sua volta è sentita solo come assenza di sole, non è degnata di una descrizione diretta, di una metafora, solo di quell’ora, tra le immagini della memoria e quelle che stanno davanti agli occhi. L’unica audacia è nell’attacco, perfino un po’ pomposo "re della luce" che, rispetto alla sobrietà degli altri versi, rappresenta una deviazione. Eppure proprio in quel "re della luce" è già un risultato poetico: direbbe Sklovski che c’è già un effetto di "straniamento". L’oggetto non è nominato direttamente, eppure proprio per questo appare rivelato, amplificato. Non so come sia uscita quell’immagine. Bisognerebbe domandarlo al solito Mario Lodi, perché la poesia è uscita proprio da una sua classe, una terza elementare, nel settanta. Lui certo saprà come sono nate quelle parole una per una, perché la poesia è nata alla lavagna, ed è firmata " tutti ".
Possiamo solo immaginare che in una mattinata di nebbia i bambini, o il maestro, abbiano cominciato a parlare, appunto, della nebbia. Avranno fatto le loro osservazioni, confrontato le loro impressioni, conversando con quella libertà che Lodi sa così bene stimolare e rispettare. Si tratta di bambini che sono già al terzo anno di " testo libero ", che sanno che parlare non è perdere tempo ma la cosa più importante da fare, che non si parla per fare bella figura, per ottenere un voto, eccetera eccetera. Insisto su questo punto. Le condizioni in cui la classe vive abitualmente, i valori che la piccola comunità si è andata costruendo, sono essenziali per capire come a uno di quei bambini sia capitato di proporre: " facciamo una poesia sulla nebbia? "
Ecco, che cos’è per loro " fare una poesia sulla nebbia "? Non è come fare un tema sulla nebbia: già di temi, nella classe di Mario, non se ne fanno mai. Non è nemmeno come fare un " testo libero ", in cui l’importante è dare espressione immediata e sincera ai propri contenuti. E’ un’altra cosa, dove quel che importa è il " come " dire, più che il "che cosa". La mattinata deve aver avuto qualcosa di speciale, altrimenti sarebbe bastato un "testo libero". L’emozione nata nella conversazione deve aver avuto una certa qualità particolare. Occorrevano parole speciali, proprio le parole giuste, scelte una per una, ordinate in un certo modo, certi suoni, un certo ritmo.
Quando si fa un tema bisogna dire le cose in fila, dall’a alla zeta. Quando si fa una poesia non c’è bisogno di dire tutto, di dire molto: ma se si trovano le parole giuste si può dire molto con pochissime parole, piene di significati e di echi. Il bambino che ha suggerito "dorato" per descrivere il paese nel sole forse ha cercato solo di dire un colore, ma certamente quella parola gli è giunta anche dall’immagine del "re": il re ha una corona d’oro, nelle fiabe e nella frettolosa mitologia dei luoghi comuni.
Perché non ci sono bambini nelle strade? Perché sono a scuola, naturalmente, e noi lo sappiamo. Ma nella verità della poesia, è la nebbia che li nasconde. Il verbo nascondere del secondo verso, e lui che ha fatto sparire i bambini dalla strada.
Brillante e lucente non era il paese: era il sole, è dal sole che vengono quegli aggettivi, come dalla luce vengono i colori. Le parole si rimandano, si richiamano, si collegano con fili invisibili e sottili: è così che avviene nella misteriosa economia della poesia.
Può stupire che io abbia impostato questo accenno di lettura della poesia del Paese triste con tanto impegno, come se stessi parlando di una poesia di Ungaretti o di Montale. Non è che io giudichi quel risultato un grande risultato, una poesia da stampare nei libri perché faccia il giro del mondo. Essa è veramente viva, ovviamente, solo nel contesto in cui è nata. I bambini che l’hanno scritta sanno tutto di ciascuna parola: "questa l’ho detta io ", " questa l’hai detta tu ". E’ esperienza loro, in gran parte incomunicabile. Ma che esperienza ricca, emozionante, produttiva. Bambini che vivono di queste esperienze sono certo infinitamente più vicini alla poesia di quelli che hanno conosciuto soltanto lo studio a memoria della " pioggerellina di marzo ". Quel che conta è l’esperienza poetica di quella mattinata, il tono morale con cui è stata vissuta, il ricordo che lascerà, e anche più del ricordo, il modo come quel lavoro si sarà fissato nelle menti e nelle personalità dei bambini. Dallo stesso giornalino " Insieme " da cui ho tratto il Paese triste ecco invece la poesia di una bambina. Non ha titolo. Sta con altre sotto un titolo unico Buon Natale. Ma del Natale, apparentemente, non parla per nulla. Essa dice soltanto:
Mi piace vivere
giocare e saltare
ridere
e avere vicino
la mamma e il papà.
Ti ringrazio, Signore.
Come sentite, siamo ben lontani dall’esibizione del solito "bravo in italiano", che orecchiando un modo qua un altro là, imitando, sfoggiando, compone la poesia di cui i genitori andranno fieri. Esibizioni del genere, s’intende, andranno scoraggiate. Ma questo di Primarosa è, mi sembra, un frutto genuino: è la sua preghiera, tutta personale, schietta. Primarosa non può pensare al Bambino che ha freddo: per lei la nascita, la sua nascita, il suo Natale, è un dono gioioso. La struttura è cosi semplice che quasi, si può vedere rampollare quel ridere dal vivere, e ancora dal vi di vivere sentir nascere quel vicino. La parola che ha il maggiore spicco e "ridere", eppure anche in questa parola si sente una commozione vera. E com’è lontano quel "ti ringrazio, Signore" da ogni formula rituale o devozionale: esso rappresenta invece la scoperta di un sentimento di gratitudine che vive di se stesso.
Mi si dirà: restiamo col solito Lodi. Lodi, si sa, è un poeta. Nella sua classe tutti diventano poeti. Ma si sente bene che è merito suo quella scrittura chiara, senza banalità, fervida e misurata insieme. Certo, è cosi: ma non nel senso che Mario Lodi sia intervenuto nella creazione di questa poesia, suggerendo, correggendo. Il suo intervento è stato ben altro: è stato quello che ogni giorno, la lunga pazienza, la lunga premeditazione con cui è arrivato a creare per i suoi ragazzi la condizione di libertà e di felicità necessaria per trovare quelle parole.
Del resto, sentite ora questa filastrocca al sole
Sole, sole splendi
che tutti saremo contenti;
sole che hai tanti raggi lucenti
danne un po’ a noi
che saremo contenti.
Sole, tu fai splendere i vetri,
tu fai splendere il cielo.
E’ di una bambina di quarta elementare di una scuoletta di campagna, Oira di Nonio, sul lago d’Orta. E il maestro non si chiama Mario Lodi, si chiama Claudio Boldini.
E questi quattro versi, che vengono da una scuola elementare di Mariano di Valmozzola, in provincia di Parma:
Scende la notte
buia buia
la luna ascolta
i canti delle mamme.
E dalla stessa scuola, di un altro bambino:
Alzo la testa e vedo
cielo, cielo blu.
Guardo nel secchio con l’acqua
e vedo cielo, cielo blu
voltato all’ingiù!
Quando semplici momenti della vita, piccole scoperte, occasioni che in sé non hanno nulla di straordinario, diventano parola veramente libera, pretendono la parola che rifletta in se stessa la qualità e il ritmo di quel momento, come il blu del cielo – rimando con l’ingiù – ripete nelle parole il semplice gioco infantile, nasce la poesia. E’ certo una poesia che balbetta, un lumino che lucciola. Ma è un segno sicuro che in quella scuola, tra quei bambini, è nata una civiltà più alta.
Così anche questa poesia, che non vogliamo né idealizzare né
preferire a Leopardi o, se volete, a Zanzotto – sarebbe ridicolo ma soprattutto
superfluo – anche questa poesia esile esile ha aiutato i bambini a sentire, se
non ancora a capire chiaramente, che il loro ruolo nel mondo non dev’essere
quello di chi accetta la realtà bell’e fatta, di chi deve solo eseguire,
consumare e obbedire, ma e un ruolo di produttori, di creatori, di trasformatori
del mondo. Non importa se usciti da scuola non faranno più poesie: certo, è più
facile che conservino il bisogno di poesia; in ogni caso la poesia sarà stata
per loro un esercizio di libertà, un’educazione alla libertà i cui frutti
dureranno a lungo.
|
Per ulteriori informazioni inviate una mail a: |
|
For additional information please email us at: |
[ Home ] [ Up-Su ] [ Mappa del Sito ] [ Site Map ] [ Sponsors ] [ Two minutes ] [ Libri Elettronici ] [ Aiuto! ]