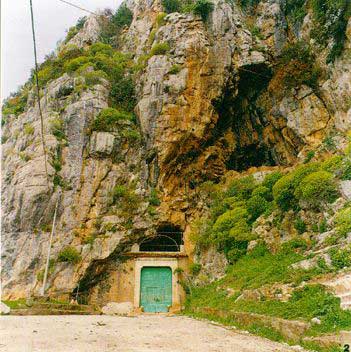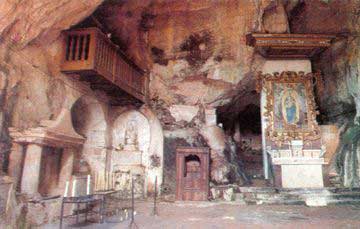|
Meravigliosa
espressione della natura e meta di somma venerazione, la grotta
di S. Michele Arcangelo sorge a circa 500 metri dal centro
abitato di S. Angelo a Fasanella, da dove si può ammirare, in
modo panoramico, l'antico borgo medioevale.
La grotta di S. Michele Arcangelo ospita il più importante
insediamento rupestre dell'area territoriale degli Alburni, che
ha restituito reperti di presenze umane dell'età paleolitica.
Negli Alburni esistono, infatti, numerose grotte scavate nella
roccia calcarea dal lavoro millenario delle acque, alcune
abitate fin dall'epoca preistorica, altre destinate, nel corso
dei secoli, a funzioni di carattere religioso (grotta di S. Elia
e Fra Liberato a Controne, di S. Elia e S. Vito a Postiglione e
S. Lorenzo ad Ottati) altre ancora che hanno mantenuto un
interesse esclusivamente speleologico e naturalistico (grotte di
Pertosa e Castelcivita).
Il Cilento, ricco di antri naturali, aveva conosciuto, sotto i
Longobardi, una forte penetrazione di monaci greci, fuggiti, per
le persecuzioni iconoclaste, dall'Impero d'Oriente. Nel Cilento
appunto i monaci basiliani poterono trovare un ambiente
confacente al loro sistema di vita, creandovi numerosi
insediamenti monastici attorno ai quali si svilupparono spesso
veri e propri villaggi.
|
|
Ampiamente diffuso in Italia
meridionale, e soprattutto in Campania, è il culto
dell'Arcangelo Michele, protettore e guida dei Longobardi (e che
aveva sostituito, dopo la conversione al cattolicesimo, quello
dell'antico dio guerriero Odino) localizzato negli antri e nelle
caverne.
Una leggenda popolare fa risalire la scoperta della grotta e
l'origine del culto per l'Arcangelo Michele, a Manfredo,
probabilmente un principe dell'antica città di Fasanella, che,
cacciando nei boschi che un tempo lambivano la grotta, vide il
suo falcone, lanciato all'inseguimento di una colomba,
scomparire in una fenditura della roccia dalla quale perveniva
una dolce melodia. Tornato con un seguito di servi e contadini
alla ricerca del falcone e allargata la fenditura, scoprì una
meravigliosa grotta con un altare e sulla parete retrostante
un'impronta delle ali dell'Arcangelo Michele. Da allora la sacra
grotta fu tenuta in somma venerazione dal popolo.
L'accesso è costituito da un portale quattrocentesco in pietra,
sollevato su due gradini e con capitelli decorati sul fronte
esterno da un fiore stilizzato a rilievo, le cui basi sono
arricchite dalle figure di un leone e di una leonessa di gusto
neoromanico che reggono l'intera struttura, attribuito a
Francesco Sicignano, maggiore scultore del Quattrocento
cilentano, legato alla committenza dei Sanseverino.
All'interno, a destra dell'ingresso, si trova una vera da
pozzo a base quadrata rivestita da piccole mattonelle di
ceramica napoletana recanti la data del 1614 e sullo spiazzo
antistante lo stemma della famiglia Caracciolo scolpito su un
blocco di pietra.
Nella prima sala, a circa 5 metri dall'attuale piano di
calpestìo, vi è sulla parete rocciosa una edicola con tetto a
due spioventi che presenta nel bordo anteriore una serie di
archetti decorativi che terminano ai lati in due pannelli nei
quali sono effigiati a sinistra l'Angelo Annunciante e a destra
la Vergine Annunciata e al centro una zona affrescata, purtroppo
molto rimaneggiata, dove a stento si riesce a distinguere
l'immagine di S. Giovanni Battista. |
|
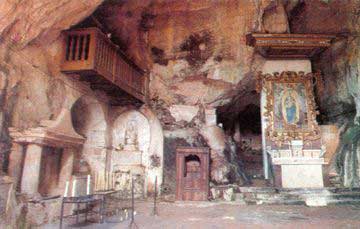
|
All'interno, a destra dell'ingresso, si trova
una vera da pozzo a base quadrata rivestita da piccole
mattonelle di ceramica napoletana recanti la data del 1614 e
sullo spiazzo antistante lo stemma della famiglia Caracciolo
scolpito su un blocco di pietra.
Nella prima sala, a circa 5 metri dall'attuale piano di
calpestìo, vi è sulla parete rocciosa una edicola con tetto a
due spioventi che presenta nel bordo anteriore una serie di
archetti decorativi che terminano ai lati in due pannelli nei
quali sono effigiati a sinistra l'Angelo Annunciante e a destra
la Vergine Annunciata e al centro una zona affrescata, purtroppo
molto rimaneggiata, dove a stento si riesce a distinguere
l'immagine di S. Giovanni Battista. |
|
Figura 5. 51. Interno della
grotta |
Sulla parete di roccia, di fronte all'ingresso, si trova il
monumento funebre dell'abate Francesco Caracciolo, fatto erigere
nel 1585 dal nipote Fabio Caracciolo. Sulla sua sinistra si
trova ancora un dissestato ballatoio per l'organo, al quale si
accede con una scala in muratura, mentre sulla sua destra, in
una cavità profonda, si trova la cappella dedicata alla Madonna
dell'Immacolata, sul cui altare vi è un grande quadro, con
cornice ad intaglio barocco del XVII secolo, raffigurante la
Vergine che schiaccia il dragone infernale, opera di Giovanni De
Gregorio detto di Pietrafesa.
Non lontano da questo altare, probabilmente in quella che viene
indicata come cappella della Pietà, sul pulpito ligneo, è
dipinto il Cristo che sorge dal sepolcro. |
|

|

|
|
Figura 5. 52. Il coro |
Figura 5. 53. Impronte delle
ali |
|
Dietro l'altare dell'Immacolata si apre una
cavità che conserva un arcosolio in stucco databile al
Quattrocento, con al centro la Vergine con il Bambino
benedicente, a sinistra l'Angelo Annunciante in atto di offrire
un giglio e a destra l'Annunciata e sulla parete di fondo Santa
Caterina d'Alessandria e S. Vito.
Continuando sul leggero pendio, scivoloso per l'intensa umidità
e per il continuo stillicidio della volta della grotta, si trova
una bellissima Vergine con Bambino in gesso dei primi anni del
Trecento, assisa su un piedistallo di roccia naturale decorato
in modo da fingere la tradizionale cassapanca.
Nell'altra grande sala della grotta, sulla parete di fondo,
spicca lo stupendo altare marmoreo con la statua di S. Michele
Arcangelo, sempre in marmo, del XVII secolo, attribuita a
Giacomo Colombo d'Este, discepolo di Domenico di Nardo, le cui
opere di chiara influenza napoletana sono diffusissime in tutto
il territorio cilentano.
Alle spalle dell'altare, sulla roccia naturale, sono dipinte due
ali d'angelo; in basso, sotto di esse, si apre una cavità
naturale dove anticamente scorreva acqua a cui la credenza
popolare attribuiva proprietà miracolose.
|
|
|