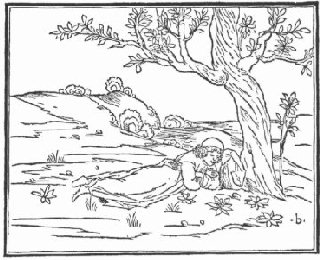
Giovanni Pasetti
Il libro come Labirinto infinito: questioni fondamentali dell’Hypnerotomachia
Iniziando un percorso reso difficile dalla presenza di deviazioni impreviste e dalla simmetrica assenza di punti di riferimento saldi, occorre muovere dai dati di fatto assolutamente certi. E, poiché quest’opera enigmatica resta in primo luogo un racconto, conviene presentare un breve riassunto delle avventure a cui va incontro Polifilo, il protagonista indiscusso della visione allucinata.
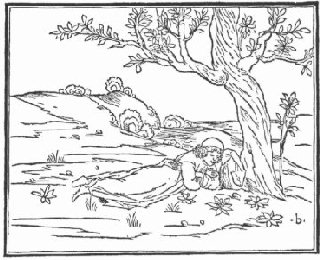
La trama dell’Hypnerotomachia
Dopo una breve dedica alla bellissima Polia, a cui sembra che il libro debba giungere, si apre il romanzo vero e proprio. Polifilo è nella sua stanza, dove trascorre gran parte della notte agitato da mille pensieri d’amore; quando si addormenta, egli sogna di trovarsi nei pressi di una spiaggia abbandonata, che subito lascia per entrare in una fitta selva da cui di nuovo fugge per timore di qualche pericolo non precisato, arrivando nei pressi di un piccolo fiume. Vuole berne l’acqua, ma viene distratto da un canto misterioso. Cercando l’origine del suono, si ferma sotto una quercia, e di nuovo viene colpito dal sonno, e sogna.
Nel secondo sogno, completamente contenuto nel primo, il giovane si muove in un paesaggio ameno, addolcito dalla vegetazione e da piacevoli colline. Un lupo famelico, che sparisce immediatamente, preannuncia lo spuntare fra i colli di una strana costruzione composta da una piramide sormontata da un obelisco. Polifilo incontra così le prime meraviglie architettoniche, per metà edifici sapientemente progettati e per metà rovine. Viene affascinato dalla scultura di un cavallo alato su cui cercano invano di ergersi alcuni putti; dalla statua di un elefante su cui si leva un altro obelisco; da misteriosi geroglifici accompagnati da scritte che in parte li decifrano. Giunto alla magnifica porta della piramide, descritta analiticamente, l’attraversa e penetra all’interno di quello che sembra essere un tempio. Un drago, venuto dalle tenebre, gli vieta di ripercorrere il cammino intrapreso e lo spinge ancor più verso il fondo, un intricato reticolo di locali oscuri al termine del quale egli riesce con grande sollievo a scoprire un’uscita.
La nuova regione che Polifilo esplora sembra accogliente e ricca. Altre antichità e altri geroglifici si offrono al suo sguardo; presso una fontana ornata in modo splendido avviene l’incontro con cinque ninfe, a loro volta sorprese per la sua presenza. Dai nomi delle fanciulle deduciamo che si tratta di un’allegoria dei cinque sensi: esse lo conducono alle terme, dove, in un ambiente magnifico e sensuale, si spogliano davanti al giovane che insieme a loro si bagna. Poi, benché le ninfe si indispettiscano nell’udire che Polifilo significa amante di Polia e non amante di molte, egli viene condotto al cospetto della signora di quel luogo, Eleuterillide, ovvero il Libero Arbitrio. Dopo aver ammirato un sontuoso banchetto, allietato da un ballo ispirato al gioco degli scacchi, il protagonista viene esortato dalla regina a proseguire il suo viaggio alla ricerca di Polia, indirizzando i propri passi verso il reame di Telosia (la Causa Finale, o meglio la Provvidenza). L’accompagneranno, almeno fino alle tre porte che segnano il passaggio da una terra all’altra, due figure femminili: Logistica (la Razionalità) e Telemia (la Volontà). Polifilo, ubbidiente, ha innanzitutto modo di ammirare all’interno dei possedimenti di Eleutirillide un giardino di vetro, un labirinto d’acque e un giardino di seta, prima di venir portato al cospetto di una piramide posta sopra un cubo, che richiama la sua attenzione sulle qualità trinitarie dell’Essere. Lasciate tali visioni, il terzetto approda alle famose porte, ciascuna delle quali è distinta da una scritta: Gloria di Dio, Madre dell’Amore, Gloria del Mondo. Oltre ogni porta sta un gruppo di sei donne governate da una matrona. Nonostante i suggerimenti di Logistica, il giovane decide proprio a favore della via centrale. Mentre Logistica se ne va indignata, Telemia, soddisfatta, abbraccia teneramente Polifilo rivelandogli che presto ritroverà Polia; quindi si allontana a sua volta. Le sei dame della porta prescelta, capeggiate da Filtronia (Pozione d’Amore), hanno tutte appellativi che richiamano l’innamoramento e le sue premesse sensibili. Il giovane, rimasto ancora una volta solo, vede avvicinarsi una graziosa ninfa recante con sé una torcia, e capisce di aver incontrato la compagna del suo cammino.
Insieme vagano per il dominio di Venere, incrociando quattro processioni trionfali illustrate dagli amori di Giove per quattro donne mortali, Europa, Leda, Danae e Semele. Dopo una lunga rassegna delle immagini relative alle passioni celesti, la coppia attraversa i Campi Elisi, dove si trovano le eroine concupite dagli antichi dèi. Mentre Polifilo si invaghisce sempre più dell’aspetto gentile della sua guida, il trionfo agreste di Pomona e Vertumno introduce i due alla celebrazione di un culto priapico, in cui viene sgozzato un asino. Poi, ecco il tempio dedicato alla Venere Naturale o Terrestre: qui, Polifilo prende parte ad una complessa cerimonia officiata da un’anziana sacerdotessa. La ninfa spegne la torcia in una cisterna, e finamente si rivela: ella è Polia, l’amata di Polifilo, a lui finalmente ricongiunta.
La felicità del protagonista è immensa, ma i doveri cerimoniali incombono: è una specie di Santa Messa che si conclude fra miracolose fioriture di rose nate dal sangue. Terminati i riti, i due innamorati vanno ad esplorare le rovine di un antico santuario che ospita un cimitero colmo di lapidi di amanti morti. Attraversandolo, dopo aver contemplato un dipinto in cui si descrivono i regni dell’oltretomba e le punizioni inflitte a chi ha travalicato le leggi di amore, si giunge finalmente al mare, dove la nave di Cupido attende entrambi per imbarcarli verso Citera. Arrivati sull’isola, Polia e Polifilo partecipano al trionfo di Amore, che li conduce ad un anfiteatro. Al suo centro si trova la fontana di Venere, in cui sta la Divina Madre occultata da una cortina. Cupido offre agli innamorati una freccia d’oro grazie a cui penetrare il velame; Polifilo esegue, e Venere appare. Segue un matrimonio mistico fra i due giovani, benedetto dalla divinità e sancito dalla ferita di entrambi, trafitti dalla medesima freccia. L’arrivo di Marte armigero, che si concede agli amplessi della dea, chiude bruscamente l’episodio. Polia e Polifilo escono dall’anfiteatro, insieme a numerose ninfe. Giunti presso un’altra fonte, le stesse ninfe raccontano del sepolcro di Adone e di come Venere ogni anno lo pianga e lo ricordi. Poi, viene chiesto a Polia di narrare l’origine della sua stirpe e del suo amore. Qui termina la prima parte o il primo libro dell’Hypnerotomachia.
La seconda sezione inizia appunto con il racconto di Polia, che dichiara d’essere nata a Treviso, discendente da un nobile romano chiamato Lelio Syliro. Segue una bizzarra favola, che associa la prole di Lelio e della sua sposa Trivisia Calardia Pia ai luoghi della campagna trevigiana, e nel contempo ricorda l’ira di Venere, che distrusse la casata per punire il sacrilegio della primogenita di Lelio, Morgania, tanto presuntuosa da paragonare se stessa alla dea dell’amore. Ma il vero nome di Polia sarebbe Lucrezia (Lucrezia Lelli, dunque); ella infatti dichiara di chiamarsi come l’intrepida moglie che si uccise dopo aver subìto violenza dal figlio di Tarquinio il Superbo (la parola Lucrezia, tuttavia, non appare mai a chiare lettere). Nel 1462 Polifilo la vide, bellissima e nel fiore degli anni, e se ne innamorò perdutamente, senza peraltro essere ricambiato. Quando la peste colpì Treviso, Lucrezia / Polia fece il voto di servire per sempre Diana, se il morbo l’avesse risparmiata. Questo avvenne, ed ella entrò nel tempio della dea; ma qui venne ritrovata dal disperato Polifilo. Ai nuovi rifiuti da lei opposti, il giovane cadde come morto davanti ai suoi occhi. Finalmente la fanciulla, ammonita da una serie di terribili visioni che illustravano la punizione degli amanti ingrati, e ben consigliata da una nutrice, decise di risvegliare il poveretto con un bacio. Sorpresi dalla sacerdotessa di Diana e cacciati, i due si rifugiarono presso il tempio rivale di Venere, dove furono benedetti dalla sacerdotessa di Amore. Così finisce il racconto. Le ninfe soddisfatte se ne vanno, e la felicità sembra trionfare. Purtroppo, quando Polifilo tenta di abbracciare quella che ormai è la sua donna, ella scompare pronunciando un ultimo saluto. Il giovane si risveglia e ricambia tristemente l’addio. È l’alba, il sogno è terminato: siamo a Treviso, il primo maggio del 1467. Segue un epitaffio in latino di Polia, in cui si rammenta che ella, benché sepolta, vive ancora. Ecco la traduzione: ‘‘Felice Polia, che sei sepolta eppure vivi, Polifilo, riposando da Marte e dalle sue imprese, fece sì che tu vegliassi anche assopita.’’ Questo struggente epilogo prelude ad una serie di versi assemblati come una lapide antica. Essi dicono: ‘‘Viandante, ti prego, fa una breve sosta. Qui c’è il miropolio, il negozio dei profumi della ninfa Polia. Quale Polia, dirai tu? Quel fiore da cui nasce il profumo di ogni virtù, meraviglioso fiore che, per l’aridità del luogo, non può di nuovo germogliare, malgrado le lacrime sempre nuove di Polifilo. Ma se tu mi vedessi fiorire, ammireresti un’immagine che vince in bellezza ogni altra, e diresti: - O sole, quel che il tuo ardore aveva risparmiato, l’ombra è riuscita ad uccidere. - Ahimè, Polifilo, desisti: un fiore tanto disseccato non rivivrà mai più. Addio.’’
Giunto al termine del lungo viaggio, anche il lettore più avvertito proverà una sensazione di smarrimento. Al doppio sonno corrisponde un solo risveglio; la data del 1467 è molto lontana dal dicembre 1499 in cui il libro viene stampato; la morte di Polia, se pure è avvenuta, è situata completamente fuori scena; la situazione gioiosa che caratterizza le ultime pagine di entrambe le sezioni viene contraddetta in modo brutale dall’inesplicabile dissolversi dell’amata. Vi è un’evidente mancanza di equilibrio stilistico tra le sezioni medesime, ambedue basate su avvenimenti sognati nella stessa notte, in parziale contraddizione fra loro. Per citare solo il dettaglio più stridente, nella prima parte dell’opera Polifilo a lungo non riconosce una donna a cui è stato appassionatamente congiunto nella vita reale. Come è ovvio, il disagio si accentua per l’assenza di ogni chiara indicazione relativa all’autore, nonostante i minuziosi quanto stravaganti accenni alla geografia trevigiana e alla misteriosa casata dei Lelli, forse collegabile a Teodoro Lelli, morto nel 1466 e per breve tempo vescovo della città veneta.
Il libro e le sue particolarità
Come abbiamo già ricordato, l’Hypnerotomachia apparve a Venezia, nel dicembre del 1499, frutto fra i più celebrati della stamperia di Aldo Manuzio. Si tratta di un in-folio (volume fatto di fogli piegati ciascuno una sola volta) di 312 x 202 millimetri, composto da 234 carte in cui vengono ospitate 172 xilografie, un numero molto elevato in generale ed enorme per le consuetudini di Aldo. Ma il nome di Manuzio si trova soltanto al termine di un lungo errata corrige posto alla fine: Venetiis Mense decembri MID in aedibus Aldi Manutii, accuratissime. La prefazione latina venne invece scritta, in forma di lettera dedicatoria a Guidobaldo di Montefeltro duca di Urbino, da Leonardo Crasso o Grassi da Verona, ovvero il personaggio che detenne i diritti dell’opera, avendo sostenuto - almeno nominalmente - le ingenti spese di pubblicazione; ne troviamo conferma nella richiesta avanzata dal Grassi stesso nel 1509 al Consiglio dei Dieci di Venezia per aver proroga decennale del privilegio di stampa. Egli lamenta in questa supplica la mancata vendita della quasi totalità delle copie impresse nel 1499, che gli erano costate centinaia di ducati: ‘‘et per li tempi, et disturbi di guerra sono state, non habi potuti quelli mandar fuori, et per altre urgenti cause, de essi non sia reussito, immo quelli quasi tuti anchor habi, per li quali spece assai centenara de ducati...’’
Chi era questo Crasso? Non molto si sa di lui. Appartenente ad una ricca famiglia veronese venuta forse da Milano, fu dottore, protonotario apostolico, uomo d’armi, capitano della cittadella di Verona, rettore della chiesa parrocchiale di Sant’Agostino a Treviso, sovrintendente alle fortificazioni di Padova. Uno dei suoi fratelli, Bernardino, ricoprì per due anni (1498 - 1499) la carica di guardiano della Scuola di San Marco a Venezia. Un altro fratello, Francesco, fu anch’egli capitano della cittadella veronese e partecipò sotto il comando di Guidobaldo da Montefeltro alla spedizione veneta contro i francesi che occupavano Napoli, riportando ferite che nel 1496 lo condussero a morte. Un terzo fratello, Lazzaro, si distinse nella guerra del Casentino e nell’assedio di Bibbiena, agli ordini del medesimo Guidobaldo. Ritornando a Leonardo, occorre sottolineare che di lui non si conosce alcuna produzione letteraria, né alcun legame con Aldo Manuzio e gli umanisti del tempo. Fa eccezione un suo rapporto di familiarità con Ermolao Barbaro (1453 -1493), l’insigne amico di Pico, figlio di un cugino dell’omonimo vescovo di Treviso (1443) e di Verona (1453). Tale vicinanza risulta da un documento del 29 maggio 1490: ‘‘familiarem magnifici et facundissimi artium et utriusque iuris doctoris domini Hermolai Barbari’’. È da notare che, sebbene Ermolao morisse troppo presto per collaborare praticamente alle edizioni di Manuzio, proprio nel palazzo dei Barbaro avvenne nell’estate del 1491 il famoso incontro tra Aldo e Poliziano. Quest’ultimo e Giovanni della Mirandola erano stati inviati da Piero dei Medici nell’Italia del nord allo scopo di procurare libri per la biblioteca dei signori di Firenze.
Se passiamo ad esaminare la lettera prefatoria, riscontriamo subito alcuni elementi di fondamentale importanza. Il motivo della dedica a Guidobaldo è triplice: egli è un principe di grandi virtù e di grande cultura, degno erede del padre Federico, egli è legato alla famiglia Grassi dalla milizia che Lazzaro svolse sotto di lui, egli sarà un efficace e degno protettore di un’opera il cui genitore è scomparso. Infatti, Leonardo dichiara in modo inequivocabile di non essere l’autore del romanzo, che gli è giunto da poco, orfano di padre: ‘‘... Mi è venuta fra le mani recentemente l’opera e nuova e meravigliosa di Polifilo - questo nome infatti è stato dato al libro - , che io fatto stampare e pubblicare a mie spese affinché non rimanesse oltre nell’oscurità, e potesse giovare a tutti gli uomini. Ma affinché codesto libro, orbato del padre (parente orbatus), non apparisse come un bambino senza tutela o aiuto, ti abbiamo scelto come suo primo patrono, un patrono nel cui nome potesse con un certo coraggio muovere i primi passi, in modo che tu usi spesso di lui come compagno dei tuoi studi e del molteplice tuo sapere, così come io me ne servo come mezzo e come messaggero del mio affetto e della mia osservanza nei tuoi confronti...’’
La dedica a Guidobaldo, scelto come esempio di principe umanista, si allaccia evidentemente al ricordo del grande Federico da Montefeltro, il condottiero allievo di Vittorino da Feltre la cui biblioteca fu celebre in tutta Italia. A lui vennero offerte innumerevoli opere, fra cui ricordiamo soltanto, per l’importanza che rivestono nel presente contesto, la Cornucopia di Perotti, a cui tanto deve l’autore dell’Hypnerotomachia, il De gentilium deorum imaginibus del Lazzarelli e le Disputationes Camaldulenses del Landino, in cui il duca di Urbino appare anche come protagonista. Anche lo scritto maggiore dell’Alberti, il De Architectura, pare fosse in origine rivolto a Federico, prima che Poliziano lo pubblicasse sotto l’egida ugualmente prestigiosa di Lorenzo il Magnifico. Tuttavia, per tornare a Guidobaldo, nipote di Alessandro Sforza e marito di Elisabetta Gonzaga, sarà necessario ricordare che la raccolta di trattati sull’astronomia stampata da Aldo appena prima dell’Hypnerotomachia (ottobre 1499) reca anch’essa una dedica a Guidobaldo, vergata proprio dall’editore: ‘‘... Mi sembra, illustre duca... che sia opportuno che tutti i volumi dei quali procuriamo la stampa escano in mano al pubblico muniti di qualche prefazione, quasi a mo’ di scudo, e che, per conferire loro maggiore autorità, siano dedicati a personaggi di gran fama, o per l’erudizione, o per l’alta fama o per ambedue... Ecco perché abbiamo voluto pubblicare sotto il tuo nome bene augurante Giulio Materno...’’ È significativo che a queste brevi righe, ricalcate in parte dal Grassi, faccia subito seguito nel volume una seconda premessa, rivolta ad Alberto Pio di Carpi, quasi Aldo volesse associare nella memoria del pubblico i due insigni personaggi.
Quanto alla cosiddetta guerra del Casentino, essa si sviluppa all’interno dei più vasti conflitti provocati dalla discesa in Italia del re francese Carlo VIII, che mirava alla conquista del Regno di Napoli e fu causa diretta della caduta dei Medici. Dopo la battaglia di Fornovo del 1495 e la ritirata del sovrano verso la sua patria, uno dei più seri tentativi di Piero dei Medici per riprendere il potere perduto si manifestò nell’attacco armato contro il Casentino, regione in cui si trovavano molte dimore di famiglie pro-medicee, oltre all’eremo di Camaldoli. Questo tentativo, sostenuto da Venezia nel quadro più generale della guerra tra Firenze e Pisa, fallì abbastanza miseramente, nonostante la capitale toscana non fosse più condizionata dal Savonarola, messo a morte nel maggio del 1498. In un primo tempo, il corso delle operazioni sembrò favorevole a Piero: il 25 ottobre 1498 venne occupata la roccaforte strategica di Bibbiena. Ma i fiorentini reagirono prontamente, dando vita ad una serie di scorrerie e di piccoli scontri che immobilizzò la contesa per mesi e mesi. Così, gli assalitori divennero a loro volta assediati; all’interno di Bibbiena restarono, apparentemente senza scampo, Lazzaro Grassi, Giuliano dei Medici e il comandante Bartolomeo d’Alviano. Solo la stipula frettolosa di una pace che fotografava un nulla di fatto permise alle truppe veneto-medicee di uscire dalla cittadina e lasciare senza perdite il campo nell’aprile del 1499.
Infine, nella prefazione di Leonardo Crasso si tratteggia la figura dell’autore, benché nulla si dica del suo nome e della sua esistenza reale. Si tratta ovviamente di un vir sapientissimus, che ha costruito il romanzo usando la lingua romana, la greca, la toscana e il vernacolo. Costui fece in modo di mostrare nel testo i segreti della natura e i libri degli antichi, pensando che ‘‘l’esprimersi così sarebbe stato l’unico modo affinché nessuno pretendesse perdono per la propria negligenza nell’imparar qualcosa. Ma seppe tanto moderarsi che, benché soltanto un dottissimo possa entrare nel sacrario del suo sapere, anche il non dotto che vi si accosti non deve disperare.’’ Infatti, la difficoltà del contenuto è temperata dalla gradevole esposizione e addolcita dalla ricchezza delle immagini e dei simboli esposti davanti agli occhi del lettore. Leonardo termina le sue quasi accorate parole accennando di nuovo alla protezione che il duca certamente accorderà a Polifilo, così che questi non debba temere alcuna censura e sia ben giudicato da molti. È inutile rimarcare la stranezza di questo componimento, che nulla spiega in merito alle vere ragioni da cui dipese la costosa edizione della bizzarra opera. Resta solo da rilevare che il Crasso sembra consapevole della importanza dell’operazione, e parla del Polifilo - ambiguo appellativo con cui si designa il personaggio, l’autore e il libro tutto - con toni pieni di rispetto e di ammirazione, non disgiunti tuttavia da un certo timore.
Altre prefazioni, altri dettagli
Al discorso del Crasso fa seguito immediatamente nel volume un carme latino di Giovanni Battista Scita, indirizzato al medesimo Leonardo, definito come ‘‘giureconsulto Pontificio esperto nelle arti’’. Lo traduciamo integralmente: ‘‘Questo mirabile e nuovo libretto / deve essere paragonato ai testi degli antichi; / qualunque cosa in esso venga riferita ed esposta / esistente nel mondo di sacro e di nobile / tanto merito porta a te o Crasso / quanta ne ha portato a Polifilo, suo genitore. / Polifilo gli diede vita; ma anche tu gli hai dato vita, / o meglio ne respingi la fine. / Infatti, mentre giaceva riposto nell’oscurità / già temendo il Lete a lui vicino / tu lo offri da leggere a tutte le genti / e non risparmi né spese né fatiche; / Meglio di un padre, tu hai levato verso l’alto/ il nato che ti era stato gettato in grembo. / Dicono che un tempo Dioniso fu generato due volte: / così ora è capitato a questo libro; / Polifilo ha il ruolo di padre / e Crasso di Giove.’’
L’allusione mitologica è sottile: Zeus, invaghito di Semele, figlia di Armonia, si unì a lei concependo Dioniso. Ma, prima che il bambino potesse nascere, la gelosia di Era causò la morte della madre, che pretese di guardare Zeus in tutto il suo splendore e ne venne folgorata. Affinché il feto potesse svilupparsi, Mercurio lo cucì nella coscia del signore degli dèi, che portò felicemente a termine la gravidanza, rivestendo insieme la funzione di padre e di madre. Così, viene stabilita una complessa equazione simbolica in cui Polifilo (l’autore) è assimilato a Semele, Crasso a Giove e il libro a Dioniso.
Questo significa che il misterioso scrittore scomparve tragicamente quando ancora il libro non era del tutto perfezionato; tale morte viene poi implicitamente associata ad un atto di superbia intellettuale, ovvero il tentativo di un semplice uomo - benché intimo di Zeus - di avvicinarsi troppo alla sfera sublime della divinità. Viene inoltre sottolineata l’oscurità in cui giaceva l’opera, prossima all’oblio.
Abbiamo diverse notizie in merito al poeta Giovan Battista Scita, un umanista di Feltre, professore di retorica e di grammatica ben noto a Pierio Valeriano e al Bembo, che ne scrisse l’epitaffio (... funera duxit Amor...). Egli ebbe corrispondenza con Aldo Manuzio e fu soprattutto vicino a Giovanni Pico della Mirandola. In particolare, nella lettera del 6 dicembre 1484 ad Ermolao Barbaro, costui lo definisce Scitam nostrum, e la medesima qualifica amicale viene ribadita più volte nelle missive del 1483 del patrizio veneziano Tommaso Mezzo, che ringrazia Pico per aver preso in esame una sua commedia, l’Epirota: qui si parla ad esempio di Scitham tuum e di ex Scytha tuo. Scita, insomma, appare come un fidato intermediario fra Giovanni e il mondo degli umanisti veneti; in una lettera del Poliziano si allude anche alla sua presenza in qualità di ospite a Mirandola. Sappiamo d’altronde che lo stesso Scita (o Scienza, come forse suonava il suo vero cognome) fu pedagogo di Gian Francesco Pico, nipote della ‘Fenice degli ingegni’, presso la corte di Ludovico il Moro a Pavia.
Dopo il carme dello Scita troviamo tre composizioni anonime, la prima in latino e in versi (un’elegia), la seconda in volgare e in prosa, la terza in volgare e in versi. Si tratta in sostanza di tre brevi riassunti dell’opera, presentati al chiaro scopo di invogliare il pubblico ad una lettura tanto ostica, elencando le meraviglie descritte nel libro stesso. Molto più significativi appaiono i seguenti otto versi latini, firmati da un certo Andrea Marone di Brescia. Essi raccontano un dialogo immaginario tra un lettore curioso e le nove Muse: ‘‘Mi dici di chi è l’opera, o Musa? Mia e delle otto sorelle. / Vostra? Perché allora il merito è stato dato a Polifilo? / Il comune discepolo meritò ancor di più da noi. / Ti prego, qual è il vero nome di Polifilo? / Non vogliamo sia conosciuto. Perché? Prima, è meglio vedere / se il livore rabbioso è capace di divorare anche le cose divine. / Se le risparmierà, cosa avverrà? Sarà conosciuto. Altrimenti? / Non vi giudicheremo degni del vero nome di Polifilo.’’
Pare che Andrea Marone fosse un cultore delle belle lettere, esperto inventore di epigrammi e amico del Valeriano; visse a Roma all’epoca di Leone X (papa fra il 1513 e il 1521), dopo aver insegnato a Ferrara. Come semplice curiosità, si può osservare che Manuzio firmò talvolta il suo marchio editoriale con la sigla AL . MA . RO. (Aldo Manuzio romano), mentre Andrea era il nome del suo socio. In ogni caso, il contenuto dell’epigramma è della massima importanza: viene espressa la ferma volontà di mantenere il segreto in merito al vero nome dell’ingegnoso autore, in attesa di verificare se il livor rabidus osa attaccare un’opera tanto sublime. Nei versi è implicito un duro giudizio che il misterioso Polifilo dà dei suoi tempi, attraversati da invidia e furore, quasi alludendo ad un gruppo di temibili avversari.
Completano le pagine prefatorie altri quattro versi latini in cui si accenna a Polia che vive benché morta, sola ad essere felice fra i mortali grazie alla gloria che le deriva dal sogno di Polifilo. Infine, in una delle copie superstiti dell’Hypnerotomachia, quella conservata nella Biblioteca di Stato di Berlino, appaiono due componimenti aggiuntivi di un tal Matteo Visconti di Brescia, non ancora chiaramente identificato. Nella prosa latina si parla a lungo dell’autore, educato nel grembo di Venere, vicino in spirito agli egizi ed a Platone. Nella poesia in volgare si legge: ‘‘L’innopinata et immatura morte / non pò el to nome, o Polia, far rodibile; / foelice adunque vive in dolce sorte, / eterna, laetabunda, inextinguibile, / chiamando LAUREA nostra ala tua corte. / Poliphilo staranne più risibile / mirando poi Francisco alta columna / Per cui phama immortal de voi rissona.’’
Nonostante quanto si è affermato da parte di autorevoli commentatori, il senso dell’ottava non è immediato. Laurea è probabilmente una Laura amata dal Visconti, che dovrebbe far compagnia a Polia nell’empireo delle donne onorate da eccelsi poeti, allietando anche Polifilo. Quanto al Francesco, alta colonna, mi sembra abbastanza naturale identificarlo nel Petrarca, il cantore per eccellenza della donna amata, e in particolare di una celebre Laura, omonima rispetto alla bella vagheggiata da Matteo. Insomma, il voi finale sarebbe riferito non alla sola Polia (a cui si dà invece del tu, la tua corte); la poesia nel complesso significherebbe: ‘‘Polifilo ha reso immortale Polia; se ella vorrà accogliere la mia Laura nella corte delle donne amate dai poeti, anche Polifilo ne sarà lieto, guardando all’esempio del Petrarca che, come un’alta colonna, innalzò al cielo non solo la propria Laura ma ogni altra Laura ideale.’’ Così, Petrarca spinge Polifilo a poetare, e quest’ultimo induce il medesimo sentimento nel Visconti.
L’acrostico
Il carattere ‘romano’ dell’Hypnerotomachia è il 115R, una leggera variante del famoso ‘tondo’ detto del Bembo (114R), usato appunto per la prima volta nel De Aetna di Pietro Bembo, edito da Manuzio nel 1496. Ma il plurilinguismo del Polifilo condusse ad utilizzare anche il tipo 84 Gr (greco), oltre a caratteri ebraici e arabi. L’autore di queste serie fu il bolognese Francesco Griffo, un geniale artigiano che diede enorme impulso all’attività di Aldo, forgiando tutto ciò di cui la stamperia veneziana necessitava. Lo stesso Francesco è probabilmente l’inventore delle 39 maiuscole fiorite corrispondenti alle 38 iniziali dei capitoletti in cui è ripartita l’opera, più la lettera M che apre la dedica a Polia. Queste preziose maiuscole, alcune delle quali erano già apparse in precedenti libri, si possono dividere a loro volta in due gruppi, a seconda della presenza o meno di uno sfondo a tratteggio.
L’uso delle iniziali decorative è tutt’altro che raro nei volumi di Manuzio, forse perché l’impetuoso e orgoglioso Griffo intendeva lasciare sulla pagina un’impronta evidente della sua arte. È indicativo a tal proposito che la seconda edizione italiana dell’Hypnerotomachia, perfezionata nel 1545 dai figli di Aldo, pur servendosi ancora delle xilografie originali manchi di tutte le lettere decorate. Griffo, che per contrasti non precisati si allontanò da Venezia prima del luglio 1503, le aveva certamente portate con sé.
Oltre alla loro bellezza, che rivaleggia con gli ornati medioevali, le 38 iniziali del Polifilo mostrano un fondamentale acrostico, il celebre POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT, che a molti è sembrato indicare direttamente il nome dello sfuggente letterato a cui si deve il singolare romanzo: frate Francesco Colonna, appunto. Il gioco dell’acrostico è assai antico: ne troviamo esempi significativi nei responsi oracolari greci e, per venire ad epoche più vicine, in molti epigrammi amorosi dell’Antologia Palatina. Boccaccio costruì un enorme acrostico nella sua Amorosa Visione, formando con le iniziali delle terzine del poema tre distinte poesie che celebrano il suo amore per Fiammetta: ‘‘Cara Fiamma, per cui ’l core ò caldo / que’ che vi manda questa Visione / Giovanni è di Boccaccio da Certaldo.’’
Matteo Maria Boiardo, primo cugino di Giovanni Pico, fece spesso ricorso a questa tecnica raffinata, di solito per sottolineare il nome di Antonia Caprara; in particolare, la successione delle prime quattordici liriche del suo canzoniere rivela l’identità dell’amata. Infine, è giusto ricordare che l’arte cabalistica sfrutta proprio le combinazioni e le suggestioni dell’alfabeto per evocare la fitta trama delle relazioni intercorrenti fra le cose del mondo e il cielo.
Affronteremo in seguito i possibili significati della frase polifiliana; per ora, occorre premettere che l’acrostico non è un modo di celare un contenuto e una verità. Al contrario, si tratta di un ulteriore mezzo per mostrare quanto soggiace all’opera nel suo insieme, quasi evidenziando la spina dorsale dello scritto.
La figura di Aldo Manuzio
Aldo è un personaggio universalmente noto; egli fu, tuttavia, più un intellettuale del suo tempo che un maestro della tipografia. Grazie ad amicizie influenti gestite in modo oculato, quest’uomo ingegnoso, nato tra il 1449 e il 1450 a Bassiano, non lontano da Latina, riuscì a dar vita ad un’impresa epocale, poiché il suo nome è divenuto nei secoli sinonimo dell’arte della stampa. Solo nel 1495, però, Venezia vide apparire il primo libro ufficialmente edito da Aldo, una grammatica greca di Costantino Lascaris intitolata Erotèmata, ovverosia Questioni. Prima, molto prima, la carriera di Manuzio fu quella di uno studente che frequentò Roma negli anni in cui i primi torchi approdarono nella capitale papalina: nel 1467, infatti, i tedeschi Sweynheim e Pannartz si spostarono da Subiaco alla città eterna. In seguito egli partì per Ferrara, dove entrò in contatto con un ambiente colto, vicino al mondo fastoso e curioso delle corti padane.
La svolta fondamentale della sua esistenza fu certamente l’incarico di precettore presso i Signori di Carpi. Nella città a mezza strada fra Mantova e Modena, Caterina Pico, sorella di Giovanni, decise di affidargli l’educazione dei piccoli Alberto e Lionello Pio, suoi figli, rimasti orfani di padre dopo la morte prematura del genitore, avvenuta nel 1477. Del 1475 era Alberto, dello stesso 1477 Lionello: Giovanni Pico, probabile ispiratore della scelta di Caterina, fu certamente soddisfatto della dedizione e dell’affetto che Aldo dimostrò subito verso i giovanissimi pupilli. Nel periodo fra il 1479 e il trasferimento a Venezia, datato 1489, venne concepito un sogno, quello delle edizioni aldine. Anche se mancano informazioni dettagliate in merito, e il problema dei finanziamenti dell’impresa rimane aperto, è impossibile che a quest’avventura non abbiano contribuito i consigli degli amici più cari e una certa fiducia nell’appoggio economico da parte della corte carpigiana. Alberto, l’allievo prediletto, è il destinario di numerose prefazioni contenute nelle pubblicazioni di Manuzio. A tal riguardo, appaiono particolarmente significative le parole che Aldo gli rivolge nel volume della Fisica aristotelica (1497): ‘‘... Infatti, oltre a sostenere costantemente con il tuo aiuto la nostra missione, tu prometti pubblicamente di donarmi una vasta e fertilissima campagna, anzi mi assicuri che mi concederai un ameno castello... perché ivi con più agio e comodità io rifornisca tutti di eccellenti volumi in latino e in greco, e perché inoltre vi si istituisca un’accademia...’’ Altrettanto importante è il riferimento contenuto nell’Aristotele del 1495 (Opere Logiche): ‘‘... conosco la tua grande passione per i libri greci: so che per procurartene non badi a spese, imitando tuo zio Pico della Mirandola, uomo di splendido ingegno e di dottrina insuperabile che la morte gelosa ci ha rapito da poco, in compagnia di Ermolao Barbaro e di Angelo Poliziano, i più dotti del nostro tempo...’’
La stamperia doveva probabilmente sorgere nella stessa Carpi o presso la vicina Novi, terra a cui allude il primo scritto; ma le amare vicissitudini del maggiore fra i Pio, più volte colpito nel suo legittimo dominio, impedirono la realizzazione del progetto. Fu Venezia, l’operosa e relativamente libera Venezia, centro di scambi commerciali e letterari, ad ospitare Aldo nei primi anni novanta del quindicesimo secolo. Qui, fu sua fondamentale cura costruire un sistema di alleanze tale da consentirgli di procedere verso una meta ben delineata: la diffusione, grazie alle tecniche moderne, di una collana di volumi in cui i testi fondamentali dell’umanesimo fossero riscoperti e attualizzati, con particolare attenzione per le opere provenienti dal mondo greco.
Egli strinse dunque società con Andrea Torresani da Asola (1451 - 1528), che aveva rilevato nel 1479 la stamperia del famoso Nicholas Jenson; Erasmo tacciò Andrea di smodata avarizia, ma sembra che il mantovano fosse un uomo onesto, solido e da tutti rispettato, anche se l’abilità del buon commerciante non gli faceva certo difetto. Tale fu la vicinanza tra lui e Manuzio che quest’ultimo ne sposò nel 1505 la figlia, installando a casa sua tutta l’officina. Ma un altro socio prezioso fu Pierfrancesco Barbarigo, figlio del doge Marco, che senza dubbio portò in dote denari e conoscenze altolocate. Benché non vi siano prove inoppugnabili in merito, dobbiamo inoltre ritenere che Alberto da Carpi contribuisse in modo più defilato al consolidamento della ditta: sappiamo ad esempio che Andrea nel 1529 aveva in pegno alcune magnifiche tappezzerie di seta appartenenti al principe emiliano. Completava il gruppo il già ricordato Francesco Griffo, responsabile della manifattura di tutti i nuovi punzoni; il suo genio era pari alla sregolatezza se, come risulta, egli fu giustiziato intorno al 1519 a Bologna per aver ucciso con una sbarra di ferro il genero, dopo una lite.
Questi personaggi tipicamente rinascimentali, divisi tra la cultura e la fabbrica, tra la ricerca affannosa di finanziatori e la caccia ai codici rari, bibliofili con l’occhio attento al registro delle entrate e delle uscite, furono responsabili di innovazioni decisive nell’arte tipografica. Fra tutte, menzioniamo soltanto il carattere corsivo o italico, apparso per la prima volta nelle Epistole di Santa Caterina da Siena (1500), e il formato in ottavo, che permise la confezione di libri più piccoli e meno cari, antesignani degli attuali tascabili. Così si giustifica l’orgoglio che traspare nella nota al Virgilio del 1501, dal titolo In lode dell’incisore di lettere (grammatoglyptae): ‘‘I caratteri che Aldo ha offerto ai greci e che ora, come vedete, offre ai latini, sono stati foggiati dalle mani dedalee (daedaleis... manibus) di Francesco da Bologna.’’
Ma su ogni altra considerazione prevale il programma del Manuzio, che traccia il confine tra l’antica stamperia, disponibile a ultimare qualsiasi prodotto, e la moderna casa editrice, capace di pianificare una serie di volumi destinati a formare una rete di affinità reciproche. Naturalmente, le difficoltà del momento, l’eterna esigenza di sottostare a svariati compromessi e la morte dello stesso Aldo, avvenuta nel 1515, non permisero di compiere il progetto originale. Tuttavia, esaminando la lista dei volumi stampati, possiamo rilevare alcune costanti.
Se analizziamo il periodo che più ci interessa, compreso tra il 1495 e il 1499, scopriamo una prevalenza di autori greci, di solito assai illustri: innanzitutto i cinque tomi di Aristotele, poi Teocrito, Aristofane, Esiodo, Museo, i Carmi Pitagorici... A completamento, un gruppo di grammatiche (Lascaris, Gaza, Urbano Bolzani di Belluno) e un dizionario, per offrire al lettore una base sicura nelle sue esplorazioni del territorio classico. Sul versante latino riscontriamo invece un’attenzione più marcata per gli umanisti italiani: il giovane Pietro Bembo e il suo De Aetna, la Cornucopia del Perotti, il Giamblico curato dal Ficino e l’Opera Omnia di Angelo Poliziano, impressa nel 1498. Solo a partire dal Lucrezio del 1500 inizieranno ad apparire i grandi nomi della latinità: Virgilio, Orazio, Giovenale, Marziale, Cicerone, Stazio, Ovidio, Catullo, Tibullo, Properzio.
Quanto alla lingua volgare, la parte quattrocentesca del catalogo si limita ad una sola opera: l’Hypnerotomachia, subito seguita dalle Epistole di Caterina da Siena del 1500, forse collegabili ad un voto di Aldo in relazione all’epidemia di peste che colpì Venezia nel 1498, contagiandolo ma risparmiandogli la vita.
Una pubblicazione anomala
L’Hypnerotomachia occupa una posizione singolare nel quadro della produzione aldina. È anonima, o almeno così sembra; è riccamente illustrata; è in volgare. Inoltre, la sintassi italiana di ogni periodo viene metodicamente impreziosita dall’inserimento di neologismi che riflettono fonti latine e greche, selezionate da un uomo di immensa cultura e di memoria infallibile. Infine, i diritti d’autore non appartengono a Manuzio, ma ad un personaggio che dichiara di non corrispondere all’estensore del testo. Il Manuzio medesimo, che non incluse mai il volume nei suoi cataloghi, decide di firmarlo in fondo all’errata corrige.
Egli aveva già accettato d’essere un semplice esecutore per conto terzi: ricordiamo i Diaria de Bello Carolino di Alessandro Benedetti, che richiese personalmente il privilegio di stampa nel 1496. In altri casi, (ad esempio il De Gradibus Medicinarum di Lorenzo Maioli), le pagine non recano traccia del nome di Aldo. Ad alcuni studiosi questo è bastato per dedurre la completa estraneità del Manuzio rispetto al progetto polifiliano. Altri hanno addirittura concluso che egli avesse accettato l’incombenza con un certo fastidio, dovuto ad un malcelato timore per i contenuti scabrosi dell’opera.
Così nasce il paradosso: il più celebre libro a stampa del rinascimento, che rappresenta una fantastica sintesi del pensiero antiquario umanista, sarebbe stato impresso controvoglia dal più celebre editore rinascimentale. Da qui deriverebbe, nonostante una tiratura di almeno 500 copie, l’insuccesso dell’impresa; insuccesso, benché un esemplare dell’Hypnerotomachia sia appartenuto al Dürer e un altro a Francesco I re di Francia; insuccesso, nonostante la ristampa disposta dai figli di Aldo e le numerosissime traduzioni europee; fallimento, per un mito che si dipana già nei primi anni del cinquecento.
Ecco innalzarsi un muro di enigmi che ancora oggi attende risposta.