|
|
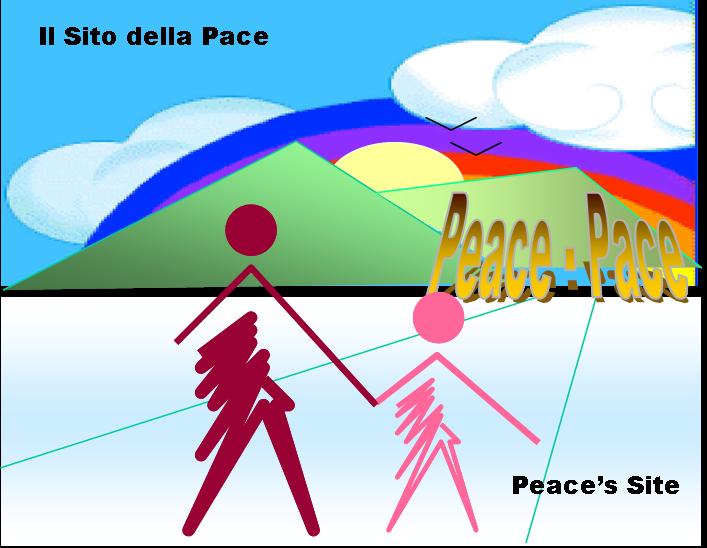 |
![]()
FAVOLE AL TELEFONO
C’era una volta.... ...il ragionier Bianchi, di Varese. Era un rappresentante di commercio e sei giorni sua sette girava l’Italia intera, a Est, a Ovest, a Sud, a Nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua, e il Lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina diceva: "Mi raccomando, papà: tutte le sere una storia. Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia, e la mamma, quelle che sapeva, gliele aveva già raccontate tutte anche tre volte. Cosi ogni sera, dovunque si trovasse, alle nove in punto il ragionier Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro contiene appunto le storie del ragionier Bianchi. Vedrete che sono tutte un po' corte: per forza, il ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Solo qualche volta, se aveva concluso buoni affari, si permetteva qualche "unità" in più. Mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava Varese le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. Sfido: alcune sono proprio belline.
GIP NEL TELEVISORE E ALTRE STORIE IN ORBITA
Questo racconto, prima, era una poesia, nella quale un medico appassionato di televisione cadeva nel suo televisore e vi restava prigioniero; di là riceveva i clienti, scriveva le ricette, eccetera. I bambini ascoltavano, ridevano. Però risero molto di più quando, al posto del medico, feci cadere nel televisore uno di loro: raccontavo la storia nella scuola di una maestra mia buona amica, e scelsi uno dei suoi scolaretti per il capitombolo.
Allora riscrissi la storia e diventò questo libro.
Quasi tutti i nomi hanno un riferimento. Per esempio, c'è un medico svedese: gli ho dato il nome di un campione di calcio per il quale una volta facevo il tifo. C'è uno scienziato sovietico: gli ho dato il nome del figlio di un mio amico, per fargli uno scherzo. C'è anche uno scienziato giapponese: gli ho dato il nome di Yamanaka... C'erano le Olimpiadi, mentre scrivevo, e questo grande lottatore era molto simpatico.
Perché ho messo un personaggio giapponese, a una svolta del racconto? Perché qualcuno doveva dire che una vita umana è più importante e vale di più di tutte le macchine, terrestri e spaziali: mi sembrava giusto che a dirlo fosse il figlio di un paese che ha provato nelle proprie carni l’orrore della bomba atomica.
Questo, in generale, non è un libro istruttivo, ma un libro divertente. Si capisce che può insegnare anche qualcosa, ma bisogna indovinarlo. La morale della storia, comunque, non è che due televisori è meglio di uno... Le altre storie in orbita che completano il volume sono apparse quasi tutte sul Corriere dei piccoli. Alcune di esse sono in realtà "storie per giocare a inventare le storie". "Delfina al ballo", per empio, è una traduzione spaziale della vecchia fiaba di Cenerentola. Chiunque può fare lo stesso con la fiaba di Pollicino, se crede: basta che Pollicino e i suoi fratelli, invece che nel bosco, si perdano nella Via Lattea e arrivino con la loro astronave nel pianeta degli Orchi. Provate: è facilissimo.
IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE
Ho rivelato per la prima volta l'esistenza del "Pianeta degli alberi di Natale" nel mio libro "Filastrocche in cielo e in terra". In un altro libro "Favole al telefono", ho poi descritto le più curiose caratteristiche di quel mondo bizzarro, pur senza nominarlo, dando notizia di strabilianti invenzioni come: la caramella istruttiva, lo staccapanni, la tristecca ai ferri. Sono lieto ora di fornire la prova definitiva che il "Pianeta degli alberi di Natale" esiste.
Nella prima parte di questo libro potrete leggere la storia della sua esplorazione (ricavata dal giornale di Roma "Paese Sera" del 26 dicembre 1959.) Nella seconda parte troverete altri documenti interessantissimi: il calendario di quel pianeta, con oroscopi e proverbi; le "poesie per sbaglio" che lassù vanno molto di moda, e che comprendono anche alcuni simpatici giochi. Spero così di metter finalmente a tacere certi critici dubbiosi. Il libro, dalla prima pagina all’ultima (ma anche dall’ultima alla prima) è dedicato ai bambini di oggi, astronauti di domani.
NOVELLE FATTE A MACCHINA
Nel luglio del 1972 il direttore del quotidiano in cui lavoravo e lavoro, il "Paese Sera" di Roma mi chiese dei "testi estivi" a mia scelta, qualcosa di leggero, rinfrescante e adatto al clima delle vacanze, per rallegrare i lettori che stavano al mare e ai monti e consolare quelli che erano rimasti in città. Feci un rapido calcolo e risposi che gli avrei potuto dare delle favole. Così dissi per due motivi: prima di tutto perché disponevo di molta "materia prima" per un certo tipo di storie che avevo già in mente; poi perché una favola richiede naturalmente più lavoro di un articolo qualunque, dunque suggerendo le favole mi conquistavo del tempo, mi sottraevo ad altri incarichi per me in quel momento meno interessanti, mi procuravo un alibi per stare in campagna a scrivere.
- Va bene - disse il direttore - le chiameremo Favole per l'estate.
Per alcune settimane, dall'agosto in poi, le favole uscirono difatti sotto quell'insegna. Una domenica, aprendo il giornale alla terza pagina, vidi che l'insegna era cambiata. Ora le Favole per l'estate erano diventate Favole della domenica. Telefonai al direttore.- Cosa vuol dire? Pensi che io possa andare avanti per un pezzo a scrivere una favola alla settimana? - Non ti preoccupare - rispose conciliante - andrai avanti fin che ne avrai voglia. Ero piuttosto incline a darmi arie da vittima e a minacciare sanzioni. Ma la sfida era abbastanza eccitante. Era come scommettere che ogni sette giorni sarei riuscito a inventare, scrivere, riscrivere e correggere una storia nuova. - Non sono mica una macchina per inventare storie, - borbottavo ipocritamente. Decisi che le favole sarebbero state trentasette e che, una volta giunte al traguardo, si sarebbero chiamate Storie fatte a macchina: non per indicare la fretta, ma proprio per significare che uscivano da una fabbrica. Un giornale è una fabbrica. Il giornale mi dava lo stipendio per scrivere le storie. Arrivai fino alla storia ventiseiesima e dissi basta. Però l’ultima storia è composta di dodici storielline: al trentasette, con quel piccolo trucco, si arriva lo stesso. Perché poi proprio trentasette, non so.
La raccolta, uscita in volume l'anno successivo, prese il titolo di "Novelle fatte a macchina". Ecco perché. Quelle storie, oltre a scriverle, io le andavo raccogliendo qua e là per le scuole, elementari e medie, dove mi invitavano. In un paesino presso Arezzo, dopo che ne ebbi raccontato una e se ne fu discusso con i ragazzi, uno di loro chiese: - Ci dice un altra novella? Cosi scoprii che per quanto "fatte a macchina" - cioè moderne come un prodotto dell'industria editoriale - quelle storie conservavano ancora qualcosa delle vecchie fiabe. In Toscana, per l'appunto, le fiabe si chiamano "novelle". Giosuè Carducci: "Ditela a quest'uomo savio la novella - di lei che cerca il suo perduto amor". Il titolo è cosi risultato una mescolanza di vecchio e di nuovo, come quello di un altro mio libro che si chiama "Favole al telefono".
Il tempo presente
Detto questo dell'occasione e del titolo, dirò qualcosa delle novelle. Disponevo, come ho già ricordato, di molta "materia prima": spunti, immagini, intrecci, appunti, scartafacci, schemi, scalette, eccetera. Quell'anno lavoravo ad un altro libro che uscì poi con il titolo di "Grammatica della fantasia - Introduzione all'arte di inventare storie", ed è qualcosa come un trattatello per l'uso dell'immaginazione.
Per prepararlo, avevo raccolto materiale, fatto esercizi, provato sistemi per inventare, trovato personaggi, costruito situazioni, allineato titoli curiosi.
Avevo anche un altro progetto: scrivere un gruppo di storie tutte al presente dell'indicativo. Così, per esperimento. I fumetti sono scritti al presente. Lo spettacolo televisivo si svolge, davanti agli occhi del telespettatore, al presente. Si raccontano al presente le barzellette. Al presente non si possono fare periodi lunghi e complicati: bisogna raccontare svelti svelti, evitare i fronzoli, saltare le descrizioni. Il presente vuole un'azione continua.
Queste novelle sono scritte al presente, con pochissime eccezioni. Sono, in qualche modo, un fumetto "parlato".. anziché disegnato. Il presente, ripetuto all'infinito, può anche diventare noioso, figurare piatto, ridursi a un balbettio. Scrivendo al presente dovevo moltiplicare l'attenzione ai particolari, lavorare sulle frasi, sulle singole parole.
Di qui risulta un'altra caratteristica delle novelle, che mi sembra quella di un linguaggio sempre in bilico tra logico e illogico, tra reale e assurdo, tra senso e non senso. Le novelle sono piene di giochi di parole, trucchi verbali, citazioni nascoste, sequenze meccaniche, proverbi rovesciati, caricature o deformazioni di luoghi comuni e frasi fatte, vocaboli nuovi come "minisgorbio" e "microscarabocchio", espressioni del gergo giovanile, tipo "quanto sei fico", immagini e moduli presi dal mondo della pubblicità e dello spettacolo. Molte cose del nostro mondo appaiono assurde: si può mostrare l'assurdità anche con un linguaggio che usi le risorse dell'assurdo.
Per esempio, in una novella è detto: "spunta l'alba del venerdì sera". Sembra una battuta insensata, invece è anche un modo di alludere a un'insensatezza ben maggiore: il fatto che un’intera nazione consideri la giornata solo come un'attesa dello spettacolo televisivo serale. In un’altra novella un personaggio "borbotta una risposta con firma illeggibile". E’ un modo un po' stravagante di dire che ha borbottato qualcosa di incomprensibile. Ma ci si può vedere anche uno sberleffo all'indirizzo di certi personaggi importanti che sottoscrivono importanti documenti con firma illeggibile, come se tutti dovessero sapere che un certo scarabocchio vuol dire "professor Teodolindo Saltinfrasca". A quando il dizionario delle firme illeggibili? I due esempi valgano per le centinaia che si potrebbero fare.
Edizione scolastica per la Scuola Media
Una parola ancora sulla presente edizione. E’ destinata alla scuola media ma, come si vedrà, è priva di note (cioè, è priva delle solite note che spiegano le "parole difficili", danno informazioni sui nomi propri, illustrano i riferimenti, eccetera).
Mi è sembrato che note del genere avrebbero appesantito il testo e tolto ai ragazzi il piacere della scoperta personale. Per le parole che non si conoscono, non c’è il vocabolario? Secondo me il lettore ha diritto ad essere disturbato il meno possibile.
Ho invece premesso ad ogni novella un’unica nota, lunghetta ma non troppo, nella quale spiego o racconto come è nata, com’è stata costruita per modo che il lettore, se vuole, possa impadronirsi di un minimo di "grammatica della fantasia" e provarsi ad usare la tecnica esposta per inventare egli stesso altre storie. Mi sembrava più interessante che suggerire "spunti per le ricerche".
Anche inventare è una ricerca. Anche giocare. Le note che suggeriscono dei giochi non dovrebbero annoiare. Però neanche loro sono obbligatorie. Si possono saltare. Se alla lettura risalteranno dei punti oscuri, niente può chiarirli meglio di un'amichevole e allegra conversazione tra insegnante e ragazzi.
C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO
Ho scritto questa storia dopo averla raccontata a voce decine e decine di volte ad altrettante scolaresche, delle elementari e delle medie, da un capo all'altro della penisola. Ogni volta ricevevo critiche, suggerimenti, proposte. Ogni volta arricchivo la storia di nuovi episodi, vi scoprivo nuovi significati, scoprivo anche nuovi problemi (fantastici) da risolvere.
Dovendo preparare un'edizione della storia per le scuole medie ho subito rinunciato ad aggiungere, pagina per pagina, note esplicative, chiarimenti di parole, informazioni sui luoghi e simili. Non mi sembrano indispensabili: per i luoghi, basterà dare un'occhiata alla carta geografica del Piemonte, per le parole, basterà un vocabolario, e il piacere di sfogliarlo.
Ho preferito aggiungere ad ogni capitolo un "poscritto" nel quale chiacchiero un po' col lettore, racconto un episodio soppresso, recito una poesia, suggerisco un gioco, insomma, giro intorno al racconto principale con alcuni raccontini secondari. Secondo me i poscritti sono meno noiosi delle note. Ma chi li trovasse ugualmente noiosi può anche saltarli.
Il barone Lamberto è nato diversi anni fa, in un appunto a margine di un libro sulla religione dell'Antico Egitto. In quel libro avevo trovato un versetto che mi aveva colpito: "L'uomo il cui nome è detto resta in vita". Lì per lì sembrava solo una poetica immagine dei rapporti tra vivi e defunti: questi, in qualche modo, continuano a vivere fin che si parla di loro, fin che il loro nome e la loro memoria tornano nei discorsi dei loro cari. Io però ho preso il versetto alla lettera come si vedrà. Così è nato il libro. Di più non posso dire, altrimenti toglierei ogni sorpresa al racconto.
Qualche altra spiegazione sarà data nei "poscritti". Nel racconto vi sono allusioni a questioni del nostro mondo e del nostro tempo: alcune scoperte, alcune nascoste, sepolte in profondità sotto le parole. Chi avrà voglia di scavare un po', le troverà senza sudare, perché a scavare sotto le parole si fa molta meno fatica che scavare gallerie sotto le montagne, o a zappare la terra. Chi non ha voglia di significati nascosti è libero di trascurarli e non perde nulla: secondo me la storia sta tutta quanta nelle parole visibili e nei loro nessi.
E così, buon divertimento.
|
Per ulteriori informazioni inviate una mail a: |
|
For additional information please email us at: |
[ Home ] [ Up-Su ] [ Mappa del Sito ] [ Site Map ] [ Sponsors ] [ Two minutes ] [ Libri Elettronici ] [ Aiuto! ]