| ROMA
AL TIMAVO APPUNTI DI RICERCA |
 |
Indice |
ABITARE SUL LACUS TIMAVI
Valentina
Degrassi
| Le modalità d'insediamento che caratterizzano il Lacus Timavi e l'area limitrofa in epoca romana si basano sull'adozione del sistema della "villa rustica": specie di microcosmo autosufficiente, composto dall'edificio in se stesso e da una proprietà terriera annessa, che oltre a soddisfare il fabbisogno interno, provvedeva alla produzione di un surplus destinato all'esportazione di piccola e media portata. |
Gli scavi archeologici, recenti e passati, condotti nella nostra
zona, hanno evidenziato resti riferibili a parecchie ville delle
quali sono state indagate soprattutto le aree residenziali (pars
urbana): non va tuttavia dimenticato che quasi mai è stata
riportata alla luce la totalità dei complessi, fatto che avrebbe
potuto illuminare sulle capacità di sfruttamento delle risorse
di terra e di mare annesse alle proprietà (pars rustica). E'
infatti possibile che sul Lacus Timavi si affacciassero anche
ville maritimae, caratterizzate quindi da un maggior sviluppo
delle aree residenziali e da un sistema di produzione incentrato
sull'attività ittica, data la vicinanza del mare1. In tal senso non va
sottovalutata la piccola portualità che caratterizza tutte le
ville "di costa" riportate alla luce, fatto che pone
l'accento sulla mobilità che le caratterizzava rispetto le ville
dislocate lungo percorsi di terra2 e di conseguenza, sulle
capacità di stoccaggio e di smistamento di prodotti anche
estranei alle singole produzioni di ciascuna di esse.
Il modello abitativo che gli scavi, recenti e passati, hanno
riportato alla luce, è caratterizzato dalla villa di media
grandezza: l'isoletta che divideva il Lacus Timavi dal mare
aperto, la prima delle Insulae Clarae della costa nord orientale
dell'Adriatico, ospitava ville dotate di complessi termali,
famosi per le proprietà medicamentose delle loro acque. Altre
ville contornavano la sponda settentrionale del Lacus, sfruttando
le estreme pendici del Carso monfalconese; altre ancora si
susseguivano lungo la zona costiera che proseguiva verso Trieste.
Un gruppo a se, forse strettamente legato all'organizzazione
delle vicine cave, era dislocato presso Aurisina, lungo la via
publica che dirigeva verso Prosecco.
Allo stato attuale delle ricerche sembra difficile proporre
tipologie architettoniche fisse, causa soprattutto la parzialità
delle indagini archeologiche fatte su ogni singolo complesso. In
linea generale sembra aver goduto particolare fortuna la villa
sviluppata su terrazze, scelta favorita dalla morfologia del
Carso giuliano, o con planimetria ad U, cioè articolata intorno
ad un'area scoperta centrale, porticata o meno, modello questo
ampiamente attestato in tutta l'Italia Nord-orientale3.
Una caratteristica che ricorre costante in questi complessi è la
cura generale prestata alla realizzazione delle aree
residenziali, testimoniata dall'introduzione di ampliamenti e
migliorie tecnologiche nelle fasi successive ai primi impianti4, dalla costante presenza
di mosaici, dal riconoscimento di avancorpi panoramici o di
portici, provati dal rinvenimento di basi calcaree di colonna,
seppur in fasi di distruzione.
Un'altra evidenza che si ripete con continuità è la presenza di
strutture che testimoniano forme di interazione con il mare:
piccoli bacini-vivai o approdi privati che permettevano di
prolungare, fino alla parte più interna dell'arco adriatico,
quel sistema di lagune e di navigazione a piccolo cabotaggio ad
esse collegata, che prendeva avvio da Ravenna5 ed aveva il suo naturale
proseguimento, pur nelle mutate condizioni ambientali, nella
fitta rete portuale che caratterizzava la costa istriana. In tal
senso, l'area del Timavo con il suo porto si poneva come cerniera
tra due mondi diversi e complementari: tra i navicularii che
seguivano la costa frastagliata dell'Adriatico orientale, ricca
di promontori ed insenature, ed i nautae che con le loro
imbarcazioni a fondo piatto, solcavano i canali delle lagune
venete nord-occidentali e che già agli occhi dei contemporanei
parevano navigare fra i prati (Cassiodoro, Variae XII, 24)6.
Dati sulla presenza di un fundus, in termini di aree coltivabili
annesse alla villa, sono stati desunti, a livello archeologico,
solo per la villa dell'Enel di Monfalcone, grazie al
riconoscimento dei magazzini per lo stoccaggio di derrate
alimentari e, per via trasversale, dal ritrovamento della fornace
del Locavaz che, con ogni probabilità, produceva anfore anche
per la commercializzazione di prodotti dell'entroterra. A ciò si
aggiunga l'ultima fase della villa del Randaccio, a carattere
produttivo anche se di dubbio riconoscimento, mentre pur
nell'assenza di dati archeologici sicuri, va ricordata la villa
segnalata dal Puschi presso Canovella degli Zoppoli, dotata di
vani con dolii incassati nel pavimento, quindi ancora a scopo
conservativo, e il Praedium Sextilianum (da cui Sistiana),
proprietà terriera dei Sextili annessa ad una villa, la cui
localizzazione andrebbe a colmare il vuoto archeologico
rappresentato dall'omonima baia, ben percepibile alla sola
lettura cartografica7. Anche nella villa della Punta a
Monfalcone, in un complesso nettamente separato dalla pars
urbana, sembra di poter riconoscere l'area riservata alla
produzione, dove alcune strutture
possono forse essere riconducibili ad un torchio8.
Qualche elemento in più sul potenziale produttivo dell'area
viene fornito dalle fonti: grazie a Plinio (NH.XIV.3.50;
NH.IV.6.60; NH.XVII.4.31) molto conosciamo sulla produzione in
età augustea del Pucino, vitigno coltivato esclusivamente nella
zona tra il Villaggio del Pescatore e Duino9, mentre forme di attività
ittica sono desumibili sulla base di Marziale (Ep.XIII.89), che
decanta il lupus (branzino) del Timavo, pesce famoso per la
qualità delle sue carni bianche10, e di Cassiodoro (Variae,
XII, 22) che, sebbene in epoca molto più tarda ed in un contesto
esteso all'Istria, sottolinea la facilità di allevamento di
molluschi e pesci11. Molto diffuso doveva essere inoltre
l'allevamento ovino: ancora da Marziale (Ep.VIII.28.7-8) sappiamo
infatti che nella zona limitrofa al Timavo si producevano grandi
quantitativi di lana12. E' probabile che le prime fasi del
processo di lavorazione si svolgessero direttamente nelle ville13, che quindi dovevano
essere attrezzate per garantire tosatura, lavaggio preliminare,
cardatura e pettinatura della lana. Per quanto concerne invece,
le complesse fasi di tinteggiatura, nelle quali era basilare
l'impiego del "succo" del murex, mollusco ampiamente
attestato, ad esempio, nello scavo della via di via Colombo di
Monfalcone o nella "casa Pahor" al Villaggio del
Pescatore, vanno ricordate le ville della costa triestina ed
istriana14, spesso dotate di
strutture interpretabili come fulloniche, alle quali, proprio in
virtù di questa fitta rete di piccoli scali, facilmente
arrivavano la lana "grezza", se non addirittura
quantitativi del prezioso mollusco.
Anche le cave di Aurisina si integrano in un quadro di
sfruttamento di ogni risorsa esistente nel fundus: durante gli
scavi all'omonima villa, il rinvenimento di materiale lapideo
semilavorato ha suggerito la possibilità che vi risiedessero
anche persone in qualche modo legate con lo sfruttamento delle
cave15.
Per quanto concerne la cronologia, possiamo individuare nella
seconda metà del I secolo a.C., con particolare riferimento
all'età augustea, un momento di espansione edilizia iniziale,
forse favorito dal ripristino e dal potenziamento dei
collegamenti stradali voluto da Augusto. Tra I e II secolo l'area
si mantiene vitale: in tale periodo infatti si inquadrano fasi di
ristrutturazione ed ampliamento riconoscibili in numerose ville
della zona, alle quali però fanno riscontro anche alcuni casi di
abbandono dei complessi. Per quanto concerne i secoli successivi,
solo in pochi casi la vita si prolunga fino al III, mentre il IV
secolo sembra caratterizzato da una crisi generalizzata: solo la
villa del Randaccio a Duino Aurisina testimonia il perdurare di
attività produttive anche se di dubbia identificazione.
1 F. Fontana 1993, sul concetto di villa maritima vedi in
particolare pp.201 e ss.
2 Si veda il caso della villa segnalata da A. Puschi (Scoperte
archeologiche, "A.Tr" 18, 1892, pp.264-265) presso la
baia di Canovella degli Zoppoli: chi ha presente la conformazione
della costa in quel punto, può facilmente comprendere come un
collegamento via terra fosse estremamente difficoltoso. Molto
più agevole quello via mare, soprattutto considerando che la
villa, se l'intuizione di F. Scotti (1979, p.361 e nt.41 p.375)
si rivelasse esatta, era posta sul terminale del tragitto
compiuto dai blocchi, provenienti dalle cave di Aurisina, per
raggiungere le aree d'imbarco.
3 M.J. Strazzulla, C. Zaccaria 1983/84, pp.118 e ss.
4 E' il caso della villa di Via delle Mandrie ad esempio, che
introduce in seconda fase il sistema di riscaldamento basato
sull'utilizzo dell' ipocausto, adattando a piccola zona termale
un'ala della casa.
5 Sulla navigazione endolagunare, G. Uggeri 1978, Aquileia e
Ravenna: via di terra e vie d'acqua, in AAAd 13, pp. 47-79; Idem
1987, La navigazione interna della Cisalpina, in AAAd 29,
pp.305-354; Idem 1990, Aspetti archeologici della navigazione
interna nella Cisalpina, in AAAd 36, pp.175-196. Vedi anche G.
Rosada 1988, La direttrice endolagunare e per acque interne nella
decima regio maritima: tra risorsa naturale e organizzazione
antropica, in La Venetia nell'area padano-danubiana, le vie di
comunicazione, (Atti del convegno internazionale, Venezia 6-10
aprile 1988) Padova, pp.154-182.
6 A. Mastrocinque 1990/91, Vie d'acqua e battellieri nel Polesine
romano, "Padusa" 26/27 n.s., pp.317-330. Sulla
"stazioni di laguna" vedi A. Marchiori, Sistemi
portuali della Venetia romana, in AAAd 36, 1990, pp.197-226. Il
sistema di lagune in epoca romana si chiudeva con la laguna di
Marano, essendo quella di Grado di formazione più recente: R.
Marocco, Evoluzione tardo pleistocenica-olocenica del delta del
fiume Tagliamento e delle lagune di Marano e Grado (Golfo di
Trieste), "Il Quaternario" 4(1b), 1991, pp.223-232
7 P. Kandler, G. Sforzi 1842, p.4: anche in questo caso i resti
descritti si rifanno ad una realtà residenziale collegata molto
probabilmente ad un piccolo scalo portuale.
8 Fino ad oggi manca una pubblicazione esauriente del complesso:
i pochi elementi interpretativi sono deducibili sulla base del
rilievo pubblicato in L. e P. Bertacchi 1988. Altre preziose
informazioni sono desumibili sulla base delle fotografie di scavo
conservate nell'archivio fotografico del Museo di Aquileia.
9 La localizzazione dell'area di produzione del Pucino va di pari
passo con la localizzazione di Castellum Pucinum, località
nominata nella Tabula Peutingeriana e negli itinerari, e
riconosciuta ora in Prosecco, ora in Duino. Per quanto concerne
l'area di produzione, in C. Marchesetti 1877, Del sito
dell'antico Pucino e del vino che vi cresceva, "A.Tr"
n.s. 5, p.431 e ss., si propone la Val Catino quale unico sito
adatto alla coltura di questo particolare vitigno, in grado di
rispecchiare le caratteristiche riportate dalle fonti. Da ultimo
vedi F. Maselli Scotti 1992, passim.
10 V. Vedaldi Jasbez 1994, s.v. "Timavus", n.141.
11 Strutture forse riconducibili a recinti di allevamento del
pesce sono emerse nella villa di via Colombo a Monfalcone. Vasche
per la preparazione del garum, la nota salsa di pesce, sono state
invece riconosciute nel complesso di Cedas: Fontana 1993 cit.,
p.182 e nt.627.
12 Vedaldi Jasbez 1994 cit., s.v. "Timavus" n.140.
13 A. Giovannini 1993. pp.9 e ss.
14 Fontana 1993 cit., pp.184-185, p.186 nt.641, p.194.
15 F. Maselli Scotti 1976, p.63 e ss.; F. Maselli Scotti 1979
pp.358-360.
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
L. BERTACCHI 1974, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in
AAAd 5, 1974, p.392 e ss.
L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area
meridionale del territorio di Aquileia, in AAAd 15, 1, pp.259-289
L. E P. BERTACCHI 1988, L'imbarcazione romana di Monfalcone,
Udine
A. DEGRASSI 1955, I porti romani dell'Istria, in AA.VV Anthemon,
Scritti in onore di Carlo Anti, Firenze, pp.119 e ss.
A DEPRETIS 1991, Attività del Gruppo di ricerche archeologiche
di Monfalcone negli anni sessanta, in Ad Aquas Gradatas, segni
Paleocristiani a S.Canzian d'Isonzo, S. Canzian d'Isonzo, pp.70 e
ss.
M. DORIA 1985, Noterelle toponomastiche 2, Sistiana,
"QGS" 6, pp.133-136
F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle
villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla
Gallia Cisalpina" 4, Roma
A .GIOVANNINI 1993, L'allevamento ovino e l'industria tessile in
Istria, "AMSIA" 93, 41 n.s., pp.7-34
P. KANDLER, G. SFORZI 1842, Esplorazioni di antichità nella
città ed agro tergestino, Trieste
F. MASELLI SCOTTI 1976, Lo scavo di un edificio romano ad
Aurisina, "AMSIA" 76, p.63 e ss.
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,
in AAAd 15, 1, pp.345-381
F MASELLI SCOTTI- VENTURA 1991, Randaccio - Scavi 1990,
"AMSIA" 91, n.s. 39, pp.264-266
F. MASELLI SCOTTI 1992 (1990), Due fortificazioni tardo antiche
ad oriente di Aquileia, in Felix temporis reparatio, Atti del
convegno "Milano capitale dell'Impero romano", Milano
8-11 marzo 1990, Milano, pp.369-373
A MARCHIORI 1982, Le terme romane di Monfalcone, "Aq.N"
53, 1982, cc. 102-128
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT" Quaderno XIII-2, pp.113-170
V. VEDALDI JASBEZ 1994, La Venetia orientale e l'Histria. Le
fonti greche e latine fino alla caduta dell'Impero Romano
d'Occidente, "Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina"
5, Roma
M. VERZAR BASS 1986, La trasformazioni agrarie tra Adriatico
nord-orientale e Norico, in A. Giardina (a cura di), Società
romana ed Impero tardoantico. Le merci, gli insediamenti, 3,
Roma-Bari, pp.647 e ss.
M. VERZAR BASS 1994, E.A.A. II suppl. 1971-1994, s.v.
"Venetia et Histria"
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
LE VILLE DEL "LACUS TIMAVI"
Valentina Degrassi (VD), Paola
Ventura (PV)
| Il piccolo catalogo abbraccia i territori dei comuni di Duino Aurisina e di Monfalcone, limitato quest'ultimo, all'area strettamente legata al Lacus Timavi. Sono stati considerati inoltre, solo i complessi dei quali si è reso disponibile un rilievo: delle altre ville si forniscono esclusivamente notizie di carattere generale, qui di seguito. |
COMUNE DI DUINO AURISINA
Alcuni rinvenimenti sicuramente riferibili ad una villa sono
stati segnalati dal Kandler e dallo Sforzi nella baia di Sistiana1. In particolare si trattava di frammenti di
suspensurae, quindi riconducibili all'ala termale di un complesso
residenziale, e di scarsi lacerti di mosaico. La località,
segnalata come "Braida Vecchia", è stata localizzata
alla base della baia, vicinissima al mare: è verosimile che il
porticciolo del tipo a mandracchio segnalato dal Kandler e dalla
Scrinari, costituisse l'approdo privato della villa, sull'esempio
di tutti gli altri complessi considerati.
Un'altra villa va sicuramente posizionata a Canovella degli
Zoppoli, sul primo terrazzo prospiciente il mare2. Segnalata dal Puschi, sappiamo che si ornava di un
mosaico "a stelle nere" e di altri tre vani pavimentati
in mosaico monocromo bianco e cornice nera. Il Puschi ne
individuò anche l'ala "rustica", dove vide, prima che
venissero distrutti, alcuni dolia incassati nel terreno
utilizzati, presumibilmente, per la conservazione di derrate
alimentari. Il complesso era dotato anche di un sacello di culto,
come testimonia un frammento di bacile in pietra offerto alla
Bona Dea da parte di Ursa, rinvenuto sul posto3. Con l'individuazione di questa villa prende corpo
il suggerimento espresso da F.Scotti sull'esistenza di uno scalo
romano a Cannovella, forse da collegare all'attività estrattiva
della cava di cui lo scalo poteva costituire il terminale
d'imbarco4.
Un altro complesso di grandi dimensioni è stato segnalato dal
Kandler sulla costa di Santa Croce: attualmente sono in corso
accertamenti per individuarne la posizione ed eventualmente,
rilevarne i resti subacquei. Oltre a questi rinvenimenti, va
infine citata la necropoli segnalata da A. Schmid (1975) presso
Slivia: non è possibile dire se questa fosse riferibile ad una
villa o semplicemente alla via interna che dirigeva verso Fiume.
In ogni caso è probabile che l'area fosse in uso ad una
comunità in qualche modo legata alla stazione doganale di
Prepotto.
COMUNE DI MONFALCONE
Dagli appunti manoscritti di A. Puschi apprendiamo dell'esistenza
di una villa vicino all'attuale stazione ferroviaria di
Monfalcone. Gli scavi da lui eseguiti, inediti e per questo
estremamente difficili da interpretare, hanno messo in luce,
molto probabilmente, l'area di un peristilio ornato da una
balaustra in calcare. Da questa villa proviene un frammento di
iscrizione pubblicato da P. Sticotti, riferibile al genio
tutelare. Il gentilizio, purtroppo frammentario, rimanda alla
gens Pomponia o Pompeia5.
Un altro complesso di grandi dimensioni doveva trovarsi sotto le
pendici del colle della Rocca, nell'area dell'attuale Piazza del
Popolo, del quale ce ne da notizia il Del Ben. Il rinvenimento di
fistulae in piombo con bollo ci permette di inquadrare la villa
nell'ambito del I secolo d.C.
Un altro rinvenimento di estremo interesse va posizionato
nell'area limitrofa alla chiesa della Marcelliana6. Il rilievo, molto frammentario, è riconducibile
ad un cortile porticato sul quale si affacciava un ambiente
mosaicato. Il mosaico b/n con motivo ad ottagoni collegati da
squadre, inquadranti un quadrato (o rettangolo) con losanghe di
risulta agli angoli, è databile nell'ambito del II d.C. La
posizione di questo complesso assume particolare interesse nel
quadro di identificazione di un possibile paleo-delta del ramo
isontino che avrebbe sfociato nel Lacus Timavi: è probabile
infatti che il corso d'acqua scorresse tra l'area della
Marcelliana che, ricordiamo, è sede plebanale, e le pendici dei
colli monfalconesi.
VD
1 Su questa villa vedi F.
Fontana 1993 passim, con bibliografia precedente. Un
ringraziamento a C. Pristavez, socio del GSF, che ci ha fornito
il materiale cartografico necessario alla sua localizzazione.
2 La villa è stata recentemente posizionata grazie ad un
sopralluogo del GSF: frammenti di embrici sono a tutt'oggi
adoperati nei muretti divisori dei campi. Su questa villa e sulla
successiva è in corso uno studio particolareggiato: cfr. S.
Flego, L. Rupel, M. Zupancic, Contributo alla topografia dei siti
archeologici sul declivio tra Sistiana e Grignano (cc. Santa
Croce ed Aurisina), c.s.
3 P. Sticotti, p.210 nt.3: "il nome della località è
Srednje, "campi di mezzo", ma il vocabolo più antico
sarebbe Conovello..."
4 F. Maselli Scotti 1979, p.357.
5 P. Sticotti 1908, p.282 e ss.
6 L. Bertacchi 1979, p.285
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area
meridionale del territorio di Aquileia, in AAAd 15, 1, pp.
259-289
F. DEL BEN 1790, Notizie storiche e geografiche della Desena e
Territorio della Terra di Monfalcone, Manoscritto, Biblioteca
comunale di Monfalcone
P. KANDLER, G. SFORZI 1842, Esplorazioni di antichità nella
città ed agro tergestino, Trieste
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio di sud-orientale di
Aquileia, in AAAd 15, 1, pp. 345-381
A. PUSCHI 1892, Scoperte archeologiche a Trieste e nel suo agro,
"A.Tr" n.s. 18, pp.264 e ss.
A. SCHMID 1975, S. Antonio Abate sopra Slivia. Ricerche storico -
topografiche, "Alpi Giulie" 69/1
V. SCRINARI 1951, Tergeste, Roma-Spoleto
P. STICOTTI 1908, Antichità scoperte a Trieste e nel suo agro,
"A.Tr" 4, s. III, pp.279-288
P. STICOTTI 1911, Recenti scoperte di antichità avvenute a
Trieste e nel suo territorio, "A.Tr" 6, s. III, pp.171
e ss.
1 Su questa villa vedi F. Fontana 1993 passim, con bibliografia
precedente. Un ringraziamento a C. Pristavez, socio del GSF, che
ci ha fornito il materiale cartografico necessario alla sua
localizzazione.
2 La villa è stata recentemente posizionata grazie ad un
sopralluogo del GSF: frammenti di embrici sono a tutt'oggi
adoperati nei muretti divisori dei campi. Su questa villa e sulla
successiva è in corso uno studio particolareggiato: cfr. S.
Flego, L. Rupel, M. Zupancic, Contributo alla topografia dei siti
archeologici sul declivio tra Sistiana e Grignano (cc. Santa
Croce ed Aurisina), c.s.
3 P. Sticotti, p.210 nt.3: "il nome della località è
Srednje, "campi di mezzo", ma il vocabolo più antico
sarebbe Conovello..."
4 F. Maselli Scotti 1979, p.357.
5 P. Sticotti 1908, p.282 e ss.
6 L. Bertacchi 1979, p.285
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DI AURISINA 1
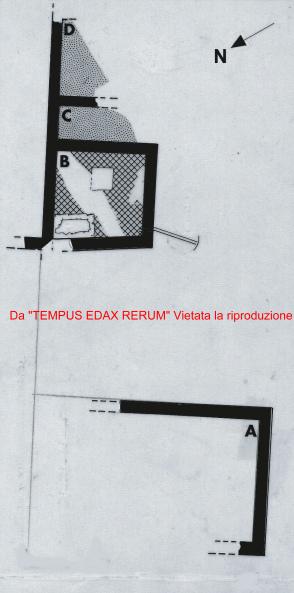 |
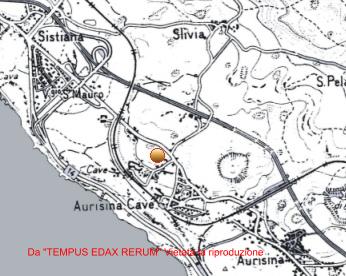 |
Nel 1976, in occasione di lavori edilizi, è stato parzialmente
indagato sul lato destro dell'attuale strada provinciale un
edificio che doveva sorgere già in antichità lungo la via che
si dirigeva dal Lisert verso Trieste sul costone carsico.
Vennero messi in luce tre vani contigui, con muri in conci
calcarei legati da malta; uno degli ambienti era pavimentato con
tessere in cotto e riquadro centrale a mosaico bianco-nero
ornamentale, i due adiacenti in cocciopesto; dal primo si
dipartiva una canaletta. Più ad Ovest sorgeva un altro vano di
maggiori dimensioni, di cui è nota solo parte del perimetro,
probabilmente da collegare ai tre già menzionati, che comunque
trovavano prosecuzione a Nord e ad Ovest.
Una datazione piuttosto antica dell'impianto, oltreché dal tipo
di pavimentazione del primo vano, è resa possibile dai frammenti
di ceramica a vernice nera trovati nelle fondazioni, che
rimandano al I sec. a.C.; la durata dell'edificio, o almeno di
questa sua parte, è limitata a pochi decenni, in quanto nello
strato di crollo si è rinvenuta una moneta di Augusto, databile
fra 10 e 3 a.C.. I restanti materiali rinvenuti negli strati di
frequentazione - particolarmente abbondante la sigillata
nord-italica - confermano una datazione entro la metà del I sec.
d.C.; allo stesso ambito cronologico rimanda una fibula di
tradizione tardo La Tène. Di particolare interesse è il
rinvenimento di una gemma incisa con figura femminile (forse
Diana o Nemesi), databile agli inizi del I sec. a.C., e di due
elementi decorativi bronzei (una cornice curvilinea ed un
elemento circolare a decorazione vegetale), recuperati in una
buca a breve distanza dall'area di scavo.
Tutti questi elementi portano ad una definizione dell'edificio -
per il quale, seppure solo parzialmente indagato, si può
ricostruire un'area di 300 mq c.ca - come zona abitativa di una
villa di elevato livello; è presumibile che la ricchezza del
dominus fosse connessa con l'attività estrattiva delle vicine
cave, il cui sfruttamento inizia come noto in epoca cesariana -
si segnala peraltro la presenza di rocchi di colonna ed elementi
semilavorati.
L'edificio è attualmente interrato, in un'area parzialmente
edificata.
PV
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
A. GRILLI, G. MENG,1978/79, La strada romana sul Carso triestino,
"Atti CeRDAC" 10, p. 70
F. MASELLI SCOTTI 1976, Lo scavo di un edificio romano ad
Aurisina, "AMSIA" 76, pp. 61-80
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,
in AAAd 15, 1, pp. 358-361
F. MASELLI SCOTTI 1981, Villa rustica (scavo 1976): Aurisina,
Duino-Aurisina (Trieste), "Relazioni" 1, pp. 75-80
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT" Quaderno XIII-2, pp.157 n.7
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
CASA
DELLA TORRE PIEZOMETRICA 2
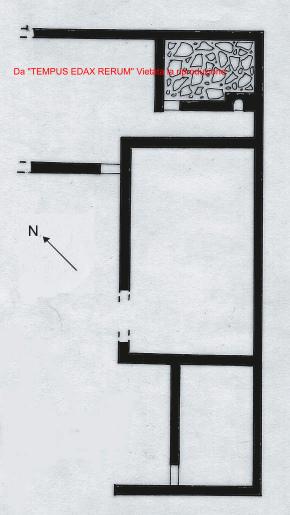 |
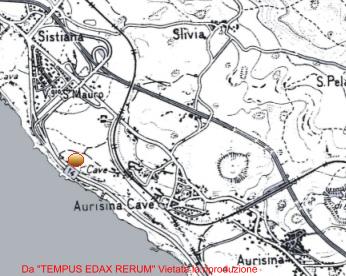 |
Il sito, collocato a monte della strada statale immediatamente
prima dello svincolo autostradale per Trieste ed oggetto di un
rinvenimento casuale nel 1973, era occupato da un edificio
costruito con muri a secco in pietre calcaree ben squadrate,
conservati fino ad un metro in altezza: si sono riconosciuti
quattro vani, di cui due scavati: solo uno di essi presentava il
pavimento in lastre calcaree, mentre degli altri ci si limitava
ad individuare le soglie; veniva inoltre rilevato un probabile
focolare o resti di forno. Tra il materiale recuperato - non più
rintracciabile - si segnalano frammenti di ceramica a vernice
nera (fra cui una coppa Lamboglia 2 ?), che permettono una
datazione dell'edificio alla seconda metà del I sec. a.C.; erano
inoltre presenti ceramica grezza, frammenti di anfora, laterizi.
Mancano elementi più precisi per una definizione tipologica
dell'insediamento; la sua posizione in passato ha fatto
propendere per l'interpretazione come villa costiera, tuttavia le
ipotesi più recenti vi riconoscono un insediamento di genti
locali, con tecniche costruttive di tradizione protostorica.
PV
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
D. CANNARELLA 1975, Guida del Carso triestino, Trieste, pp.
169-170
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,
in AAAd 15, 1, pp. 357-358
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT" Quaderno XIII-2, p. 158 n.9
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DEL RANDACCIO 3
|
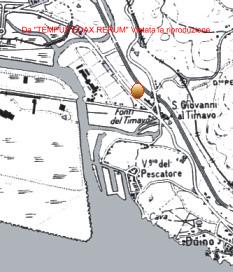 |
A
monte della ss.14, nell'ambito del parco dell'acquedotto
Randaccio, dove è venuto casualmente alla luce a seguito di uno
scasso, è stato indagato a più riprese fra il 1977 e il 1994 un
edificio di notevole levatura, adagiato sul declivio del costone
carsico di cui sfrutta in parte la naturale pendenza, seguendo un
orientamento N65°W-S65°E. Il complesso - del quale si sono
riconosciuti 40 vani, su una superficie totale di oltre 1300 mq -
risulta fino ad ora delimitato solo sui lati NW e NE, mentre non
ne è nota l'estensione in direzione SE e SW. Esso è costruito
su tre livelli, con vani parzialmente incassati nella roccia di
base e circoscritti da muri in conci calcarei legati da malta; a
causa della morfologia del terreno e delle modalità costruttive
- nonché di quelle di abbandono e distruzione, che sembrano
essere state graduali - la sua conservazione e leggibilità non
sono uniformi: nella fascia più alta sono conservati solo i muri
a livello fondazionale e non i pavimenti, in quella bassa le
strutture sono in parte sommerse dall'acqua di falda, alimentata
anche dalle sorgenti carsiche che vengono incanalate
nell'acquedotto.
Una lettura delle strutture e delle loro sovrapposizioni ha
permesso di distinguere quattro fasi principali: la più antica
è caratterizzata da vani di piccole dimensioni, forse pertinenti
al settore rustico, come indicherebbero i pavimenti a cocciopesto
ed un grosso dolio interrato; essa si data ancora all'epoca
repubblicana (inizi I sec. a.C.), in base alla presenza di
ceramica a vernice nera, megarese, anfore Lamboglia 2.
 |
Veduta degli scavi della Villa del Randaccio a San Giovanni di Duino |
In
età augustea vengono costruiti i primi pavimenti a mosaico
bianco-nero a decorazione geometrica, modificati e parzialmente
rifatti in una fase successiva (fine I - inizi II sec. d.C.): si
segnalano in particolare motivi a crocette, a mura merlate, a
stelle di losanghe. Nella terza fase viene anche effettuato un
ampliamento, con l'aggiunta dell'ala occidentale, che comprende
tra l'altro un vano a suspensurae. I materiali relativi alle fasi
alto-imperiali comprendono ceramica a pareti sottili, sigillata
italica (Goudineau 38 e 39) e orientale (ES B Hayes 60 e 63),
vetri; le anfore sono rappresentate principalmente da Dressel 6,
sono attestati inoltre diversi bolli laterizi, fra cui L(UCI)
ABUD(I) RUF(I) SICULEIAN(I), T(ITI) R(EGI) DIAD(UMENIANI), L(UCI)
MINUC(I) PUDENTIS.
Mentre alcuni vani risultano abbandonati già alla fine del II
sec. d. C. per la presenza di sigillata africana A negli strati
di distruzione, alla metà del III sec. d.C. è stato possibile
ricondurre alcuni pavimenti a cubetti; più in generale ad epoca
tarda è ascrivibile la probabile riconversione del complesso a
fini produttivi, con l'inserzione di alcune vasche ed un
focolare; l'uso dell'edificio è comunque proseguito fino ad
epoca costantiniana, cui rimanda una moneta.
Il complesso così individuato può avere assolto nelle sue varie
fasi tanto la funzione di villa - caratterizzata dalla
compresenza di pars dominica e pars rustica - quanto il ruolo di
mansio, connessa al percorso Aquileia - Tergeste, identificato
sul terreno e dalle fonti antiche: in rapporto a queste ultime è
stata proposta l'identificazione dell'importante monumento con la
Fons Timavi degli itinerari antichi, raffigurata anche nella
Tabula Peutingeriana.
PV
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
L. BERTACCHI 1988, La Venetia orientale, in La Venetia nell'area
padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Convegno
internazionale, Venezia 6-10 aprile 1988, Padova 1990, pp.
642-643
F. MASELLI SCOTTI 1977, Notiziario archeologico ...,
"AMSIA" 77, pp. 457-459
F. MASELLI SCOTTI 1977, Notiziario. Trieste, "AqN" 48,
cc. 370-371
F. MASELLI SCOTTI 1978, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, "AMSIA" 78, pp. 385-386
F. MASELLI SCOTTI 1978, Notiziario. Trieste, "AqN" 49,
cc. 241-242
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,
in AAAd 15, 1, pp. 366-370
F. MASELLI SCOTTI 1980, Notiziario. Area dell'Acquedotto
Randaccio, "AqN" 51, cc. 385-386
F. MASELLI SCOTTI 1981, Notiziario. Comune di Duino Aurisina,
"AqN" 52, cc. 234-235
F. MASELLI SCOTTI 1981/82, Scavi della Soprintendenza
archeologica di Trieste, Anni 1979-80. Comune di Duino-Aurisina.
Acquedotto Randaccio, "AMSIA" 81/82, p. 491
F. MASELLI SCOTTI 1982, Notiziario. Trieste - Comune di
Duino-Aurisina. Area dell'Acquedotto Randaccio, "AqN"
53, c. 309
F. MASELLI SCOTTI 1983, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, Anni 1980-82. Comune di Duino-Aurisina. Acquedotto
Randaccio, "AMSIA" 83, p. 245
F. MASELLI SCOTTI 1985, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, Anni 1983-1985. Comune di Duino-Aurisina. Acquedotto
Randaccio, "AMSIA" 51, p. 241
F. MASELLI SCOTTI 1985, Notiziario. Duino-Aurisina - Area
dell'Acquedotto Randaccio (Trieste),
F. MASELLI SCOTTI 1986, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, Anno 1986. Comune "AqN" 56, cc. 449-450di
Duino-Aurisina. Acquedotto Randaccio, "AMSIA" 86, pp.
157-158
F. MASELLI SCOTTI 1991, Duino Aurisina, fraz. S. Giovanni di
Duino, "Relazioni" 8, p. 203
F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 1991, Randaccio - Scavi 1990,
"AMSIA" 91, pp. 263-266
M. MIRABELLA ROBERTI 1990, Via Gemina, in AAAd 36, p. 70
M.J. STRAZZULLA-RUSCONI, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per
un'indagine sugli insediamenti rustici di età romana nel
territorio aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2,
pp.121-122, p. 157 n.9
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
STRUTTURE
"CASA PAHOR" 4
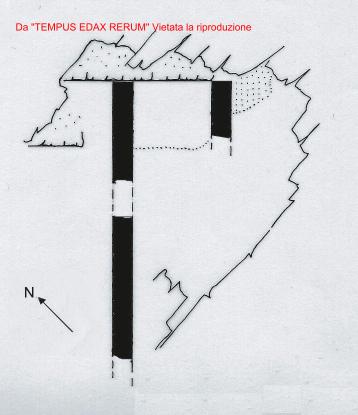 |
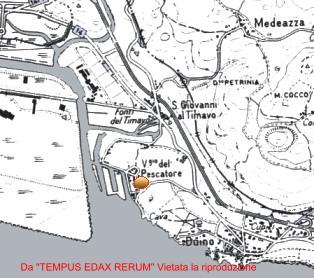 |
In seguito a lavori edilizi, a margine della strada che scende al
Villaggio del Pescatore, è venuta alla luce parte di un
edificio, indagato in due riprese (1981-1982, 1989), anche in
questo caso solo parzialmente, con l'esecuzione di trincee
esplorative. Nella più settentrionale di esse (trincea G) si
sono rinvenuti i resti di un ambiente, che confinava con almeno
altri due, con orientamento N38°E; i vani erano perimetrati da
muri in conci calcarei legati da malta e costruiti sfruttando in
parte il pendio, gradonato con incisione del substrato: ciò ha
comportato in generale una conservazione solo a livello
fondazionale. Né in pianta né in alzato sono pertanto
riconoscibili diverse fasi. Tuttavia si è dimostrato
interessante lo studio dei livelli sottofondazionali, sia
esternamente all'ambiente meglio delimitato (con la presenza di
battuti, nonché di mattoncini da suspensurae in uno strato di
crollo e forse tracce di una canaletta), sia al suo interno: il
materiale di riempimento è infatti rappresentato da elementi
troncopiramidali in terracotta, probabili divisori di fornace,
qui in posizione secondaria; è significativa per la cronologia
dell'impianto la presenza di terra sigillata italica, ceramica a
vernice rossa interna, ceramica comune e anfore Dressel 6A e 6B,
forse ovoidali adriatiche: l'insieme del materiale consente una
generica datazione al I sec. d.C.
|
Veduta degli scavi di Casa Pahor al Villaggio del Pescatore |
Leggermente
diverso si presenta il quadro nella zona immediatamente a S-SW,
separata dalla precedente da una rottura di pendenza delle
bancate di strato: ciò conferma da un lato una costruzione a
più livelli lungo il pendio, benché non si riesca in questo
caso nemmeno ad individuare una serie di vani, trattandosi
solamente di tre monconi di muri paralleli alla linea di massima
pendenza e di una superficie a cocciopesto, ad essi non
correlata, forse preparazione per una pavimentazione maggiormente
rifinita; d'altra parte si distingue la tecnica costruttiva, per
l'utilizzo di muri con paramento in laterizi e riempimento a
sacco in calcare. In quest'area si è inoltre definito un più
lungo arco cronologico, in quanto si sono individuati - sempre
nei livelli basali - ceramica grigia, ceramica a vernice nera
(coppa Lamboglia 28, Lamboglia 5, Lamboglia 6?, Lamboglia 8?),
generalmente ascrivibile a produzioni padane ed adriatiche,
lucerna cilindrica a vernice nera ed anfore Lamboglia 2, che ci
riportano nell'ambito del I sec. a.C., accanto a sigillata
nord-italica decorata, ceramica a pareti sottili, anfore Dressel
6A, 6B ed italiche forse a fondo piatto (Forlimpopoli ?). Il
termine cronologico più recente è rappresentato da rari
frammenti di sigillata chiara A rinvenuta nei livelli
superficiali. Una connotazione maggiormente utilitaria di questo
settore è ipotizzabile per la presenza di fusaiole e rari resti
di fauna (rare ossa, più abbondanti conchiglie di Murex).
E' infine da segnalare che altri due saggi hanno restituito
solamente sacche di terra rossa con materiale ceramico
protostorico (età del Ferro evoluto) e romano.
Allo stato attuale i dati in nostro possesso sono del tutto
insufficienti per una definizione tipologica dell'edificio, pare
trattarsi comunque della parte rustica di una villa, la cui
durata si può indicare dal I sec. a.C. al III sec. d.C. E'
altresì probabile che facesse parte di un unico complesso
assieme ai resti del cosiddetto Palazzo di Attila.
PV
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
F. MASELLI SCOTTI 1982, Trieste - Comune di Duino Aurisina.
Villaggio del Pescatore, "AqN" 53, c. 310
F. MASELLI SCOTTI 1983, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, Anni 1980-1982. Comune di Duino Aurisina. Villaggio
del Pescatore (p.c. 103/1, 103/2, 104/2, 104/3),
"AMSIA" 83, p. 248
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, p. 157 n.11
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
PALAZZO
D'ATTILA 5
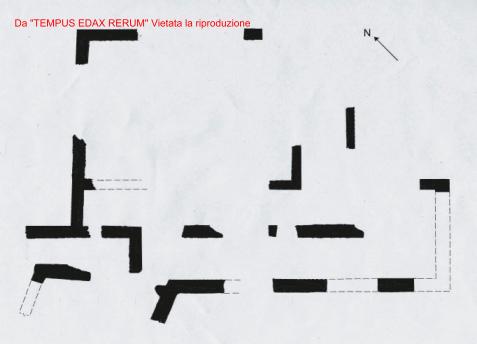 |
 |
Il
sito si estende sulla cima del rilievo carsico dominante sulla
baia detta "del Boccatino" o "Val Catin",
interrata negli anni '50 per permettere l'estendersi del
Villaggio del Pescatore. I resti attualmente visibili, attribuiti
per lungo tempo ad epoca medievale, sono situati sulla cima del
rilievo retrostante l'area corrispondente a Casa Pahor,
precedentemente descritta. Fino al 1880 circa, tra i resti
imponenti sopra la scogliera, era visibile una cavità,
interpretata allora come volta di una chiesa, oggi non
riconoscibile perché probabilmente interrata.
L'area fu "riscoperta" intorno agli anni '70 ad opera
del CAI che vi rinvenne alcune tessere di mosaico bianche e nere.
Allo stato attuale sono visibili alcuni resti di strutture
murarie e pavimentali. Nella zona più occidentale sono
riconoscibili due muri congiunti ad angolo retto, costruiti in
pietre squadrate legate con malta, conservate per un altezza
massima di sette filari. Circa sette metri ad ovest di queste
strutture si osserva la presenza di un piano pavimentale in
cocciopesto realizzato con pietra carsica e malta e con inclusi
laterizi. In tutta l'area si notano ancora sporadici frammenti di
elementi strutturali in laterizio.
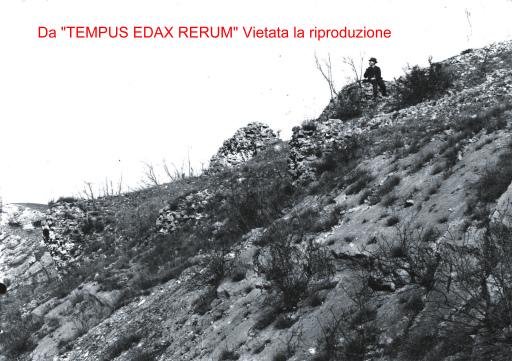 |
Rovine del palazzo d'Attila prima della grande guerra |
Alcune
fotografie inedite, conservate presso i Civici Musei di Storia ed
Arte di Trieste, risalenti a tempi precedenti alla Prima Guerra,
mostrano il sito in un momento in cui lo stato di conservazione
era certamente migliore: al tempo del Puschi, che scattò le foto
in oggetto, l'acqua giungeva fin sotto la scogliera, alle cui
estreme pendici la tradizione popolare ed il Kandler vogliono si
trovassero anelli di ferro infissi nella roccia per permettere
l'attracco delle navi. Le rovine, che si conservano ancora oggi
con alzati di c.ca 50-80 cm, sono difficilmente interpretabili,
per quanto l'estrema vicinanza delle strutture di casa Pahor
lascia presumere che si tratti di un terrazzo superiore
pertinente forse al medesimo complesso, considerando anche il
fatto che tutta la metà settentrionale della baia fu adibita a
necropoli.
Il Puschi vi riconobbe le rovine del Castellum Pucinum, seguendo
quindi l'ipotesi di P. Kandler, che a più riprese collocò il
borgo nella Val Catino. In effetti la consistenza delle rovine
come riportata dalla foto, la datazione "alta"
attribuita al complesso Pahor e soprattutto la visuale completa
sia sul mare che sulla strada, assicurata dalla posizione
strategica sul ciglio della scogliera, ben si adatterebbero ad un
sito di carattere militare.
VD
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
R.F. BURTON 1992 (1881), Le terme romane di Monfalcone (aqua dei
et vitae), Monfalcone
P. KANDLER, G. SFORZI 1842, Esplorazioni di antichità nella
città ed agro tergestino, Trieste
P. KANDLER 1874, Discorso sul Timavo, Trieste
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,
in AAAd 15, 1 pp. 345-381
Abitare sul Lacus Timavi
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
CASA
DEL LOCAVAZ 6
 |
In
località Poloska, fra le ss. 14 e 55, nei pressi di una delle
due fornaci situate nel solco di Moschenizze, in occasione dello
scavo di un tratto di oleodotto è stato individuato e
parzialmente scavato - nel 1978 - un edificio con orientamento NO
- SE, per una superficie riconosciuta di 300 mq c.ca. Si sono
messi in luce tre vani contigui, in parte ricavati nella roccia
di base, con muri in conci calcarei legati da malta; un ambiente
era pavimentato in cocciopesto con sottofondo in scaglie
calcaree, un altro - fiancheggiato da una canaletta - da un
mosaico, di cui si sono potuti riconoscere solo una larga fascia
bianca lungo uno dei lati brevi del vano ed una fascia nera che
incorniciava sui due lati lunghi il riquadro centrale non
conservato.
Fra i materiali recuperati nel corso delle indagini si segnalano
frammenti di ceramica a vernice nera e a pareti sottili, di
sigillata nord-italica, di vetro, oggetti in bronzo, laterizi ed
elementi in marmo.
La presenza di materiali di un certo pregio può far ipotizzare
un uso abitativo dell'edificio, presumibilmente connesso alla
fornace individuate immediatamente a monte (di cui non si è
potuta però determinare la produzione): una vasca rettangolare
è stata ricollegata al deposito e decantazione dell'argilla. Non
si può tuttavia escludere che tanto la villa che la fornace
facessero parte di un più vasto complesso, includente anche una
seconda fornace localizzata a Nord della prima e più ampiamente
indagata, individuando anche uno scarico ad essa relativo: è
stata così accertata la fabbricazione di laterizi, anfore
Lamboglia 2 e ceramica comune.
PV
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
F. MASELLI SCOTTI 1978, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, "AMSIA" 78, pp. 387-389
F. MASELLI SCOTTI 1978, Notiziario. Trieste, "AqN" 49,
c. 242
F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,
in AAAd. 15, 1, p. 371
F. MASELLI SCOTTI 1987, La produzione del vasellame fittile nel
territorio di Aquileia, in AAAd 29, 2, p. 439
M. MIRABELLA ROBERTI 1990, Via Gemina, in AAAd 36, p. 69
A. SCHMID 1979, Vecchie e nuove scoperte lungo l'antica rete
stradale del Timavo, "Alpi Giulie" 73, p. 37
M.J. STRAZZULLA-RUSCONI, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per
un'indagine sugli insediamenti rustici di età romana nel
territorio aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, p. 157,
n. 10
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DEI TAVOLONI 7
 |
La
villa fu inizialmente indagata da Mirabella Roberti negli anni 50
che ne descrisse i resti, consistenti in un lungo corridoio lungo
c.ca 15 metri fiancheggiato da alcune stanze. Ogni passaggio
aveva una soglia in pietra, i pavimenti erano in cocciopesto,
opus spicatum, e "battuto" realizzato con piccole
pietre "triangolari o poligonali" irregolari bianche,
inquadrato da una cornice in tassellato monocromo nero.
Successivamente l'area fu ripresa dal Gruppo Archeologico
Monfalconese che vi condusse alcune indagini nel 1962. In
quell'occasione, si verificò che la superficie in battuto era
fortemente danneggiata e fu portato alla luce un ulteriore
pavimento in spicato.
Negli anni 70 la villa fu indagata quasi interamente sotto la
direzione della Soprintendenza di Padova e la supervisione di L.
Bertacchi. Di quest'ultima indagine esiste un'ampia
documentazione fotografica ed un rilievo planimetrico, incompleto
se rapportato alle fotografie, depositato presso l'archivio
disegni del Museo Nazionale di Aquileia, rilievo che, ancora una
volta, risulta caratterizzato da un' ampia area scoperta
pseudo-quadrata attorno alla quale i vani, destinati ad uso
rustico, si dispongono regolarmente.
In base ad alcune fotografie si potrebbe ipotizzare che il
cortile fosse pavimentato in cocciopesto decorato da scaglie
(definite nella didascalia della foto come "ciottoli di
fiume"), fatto che unitamente alla descrizione di Mirabella
del pavimento "a terrazzo", del tutto simile a quello
della limitrofa villa di via delle Mandrie, alzerebbe la
datazione del complesso alla seconda metà del I sec.a.C. Una
datazione piuttosto alta è confermata dal rinvenimento, durante
gli scavi del 1950, di frammenti di vetro policromo del tipo
"murrino", mentre sulla base di una moneta di Claudio
databile al 41 d.C. -TI. CALUDIUS CAESAR AUG. P.M.TR.P. IMP
(EVENT. P.P.). Testa rivolta a sx V\ LIBERTAS AUGUSTA S.C.- si
può ipotizzare che nella villa la vita perdurò almeno fino al I
d.C.
Probabilmente legata a questa villa è la serie di rinvenimenti
annotati da A. Puschi su uno dei suoi manoscritti: a partire
dalla "vasca romana", segnalata a nord degli attuali
magazzini Rosso ancora in carte del 1917, egli mise in luce un
lungo muro con direzione sud-ovest provvisto o ornato da
semicolonne, poste a distanze regolari verso il lato "a
monte" (e quindi verso i colli), intonacate. Il muro si
legava in prossimità delle Fontanelle, ad altre strutture di
cotto che Puschi descrisse come "specie di molo". E'
possibile che ci si trovi di fronte ad una struttura di
recinzione della villa, collegata, analogamente ai complessi
limitrofi, ad un piccolo scalo portuale.
VD
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
A. DEPETRIS 1991, Attività del gruppo di ricerche archeologiche
di Monfalcone negli anni sessanta, in Ad Aquas Gradatas, Segni
romani e paleocristiani a S. Canzian d'Isonzo, S. Canzian
d'Isonzo, pp. 71-72
L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area
meridionale, AAAd 15, 1, pp. 259-289
M. MIRABELLA ROBERTI 1954, Monfalcone, Venetia, Trieste,
"Fasti Archeologici" VII, p.289 c. 3731
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, pp.113-170
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DELL'ENEL 8
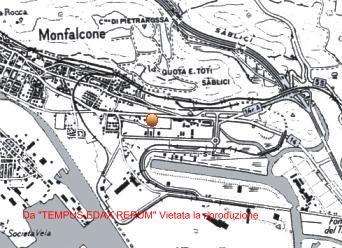 |
La
villa è stata distrutta dalla costruzione della statale 14 e poi
da quella della centrale ENEL, durante i lavori della quale andò
perduto un intero mosaico. Nel 1965, su segnalazione del Gruppo
Archeologico Monfalconese, la Soprintendenza di Padova condusse
gli scavi nell'area tra la recinzione della centrale e la strada:
l'indagine portò alla luce muri e pavimenti in mosaico, nonchè
"diversi recipienti vinari di terracotta di grandi
dimensioni profondamente ancorati al suolo". Da notizie
orali infine, durante i lavori di recinzione dell'ex officina
Bon, si rinvennero, sempre lungo la statale, alcuni
"orci" che furono distrutti durante la notte: controlli
effettuati durante la costruzione dell'attuale Coop, che occupa
attualmente l'area dell'officina Bon, non hanno tuttavia portato
a risultati.
Ricognizioni in questa zona ne compì il Puschi negli anni tra il
1890 ed il 1907 ca. In un suo manoscritto, conservato nella
biblioteca dei Civici Musei di Trieste, egli riferisce di un
"lungo muro" leggibile tra casa Bonavia e le
Fontanelle, che potrebbe, in via puramente ipotetica, collegare
l'area di Via Colombo a questa.
Anche per questa villa, oltre al rilievo, esiste una buona
documentazione fotografica conservata presso il Laboratorio
fotografico del Museo di Aquileia. Tra i negativi ne va segnalato
uno in particolare, dove appare chiaramente visibile un ambiente,
troncato dal piano della strada statale, più bassa rispetto le
quote di calpestio della villa, pavimentato con un mosaico nero a
crocette (quattro tessere bianche accostate per i vertici),
inquadrato da una fascia a triangoli alternati in bianco-nero e
da ulteriori due fasce di collegamento alle strutture
perimetrali, la prima bianca e la seconda nera ad ordito
diagonale.
Il motivo a crocette, nella variante a crocette bianche su fondo
nero, appare ben attestato in tutta l'area limitrofa in contesti
tardo-repubblicani ed augustei: in particolare, si segnalano
confronti stringenti nella villa del Randaccio, nella villa di
Ronchi dei Legionari, dove appare databile nella seconda metà
del I .a.C. sulla base di associazioni con tassellati ad
inserzioni di scaglie, e nella villa di Barcola, dove lo si
ritrova in contesti di seconda metà del I sec. a.C.
VD
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
A. DEPETRIS 1991, Attività del gruppo di ricerche archeologiche
di Monfalcone negli anni sessanta, in Ad Aquas Gradatas, Segni
romani e paleocristiani a S. Canzian d'Isonzo, S. Canzian
d'Isonzo, pp. 71-72
F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle
villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla
Gallia Cisalpina" 4, Roma
F. MASELLI SCOTTI 1978, Scavi della Soprintendenza archeologica
di Trieste, "AMSIA" 78, pp. 385-386
F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 1991, Notiziario archeologico.
Ronchi dei Legionari. Scavo di una villa romana, "Aq.N"
62, cc. 237 e ss.
F. MASELLI SCOTTI 1995, Mosaici dell'Agro sud-orientale di
Aquileia, "AISCOM", Atti del II Colloquio, Bordighera,
pp.9-16
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DI VIA COLOMBO 9
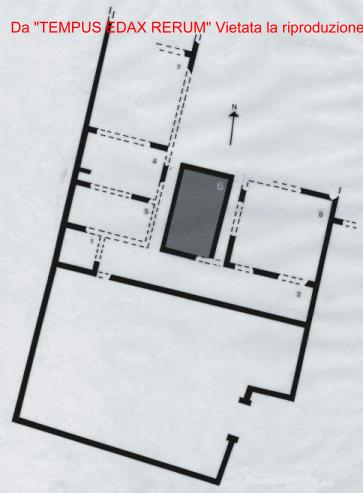 |
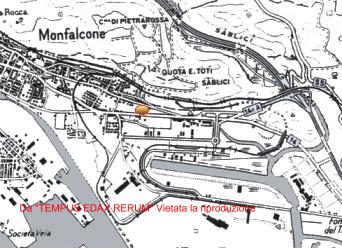 |
La
villa, indagata dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. del Friuli
Venezia Giulia nel corso di tre campagne di scavo nel 1992, 1994
e 1996, può essere strutturalmente divisa in due parti: una
abitativa, confinata a Nord lungo le propaggini della dorsale
carsica, ed una adibita ad attività produttive o di appoggio al
sistema centrale, impostata in area umida. Quest'ultima si
configura come un ampio bacino di 20 metri X 15, delimitato da
strutture in blocchi calcarei alte c.ca 1 metro e 60, provvisto
di un ampio varco d'entrata ad Est, e di un'apertura di sfogo di
c.ca 50 cm., aperta sul lato Sud. Al momento dello scavo questa
risultava in parte chiusa con un muretto a secco: se essa
serviva, come probabile, a regimentare il livello delle acque
interne, doveva necessariamente essere completata da strutture
se-movibili in legno o in altro materiale deperibile sul tipo
documentato nell'insediamento romano di Corte Caravella, dove
sono stati riconosciuti con certezza sistemi di regimazione
idraulica in ambiente di laguna, anche in questo caso legati ad
attività di peschiere.
La sedimentazione interna del bacino è apparsa caratterizzata al
letto da un orizzonte tabulare di argille torbose, fatto questo
che ha permesso di ricostruire un ambiente di tipo lagunare
caratterizzato da acque calme e miste: il cospicuo materiale
archeologico restituito da questa unità è inquadrabile nel suo
insieme alla prima metà del I secolo d.C., come provato dal
rinvenimento di bolli su tegola tipo TI.NUCI; L.KARMINI;
(...)TROSI; (...)RARI (GOMEZEL 1996). Nella medesima unità,
l'elevata percentuale di resti malacologici riferibili a muricidi
(oltre che a Cardium ed a Ostrea), ha fatto avanzare l'ipotesi
che il bacino assolvesse anche a funzioni vivaistiche finalizzate
alla produzione di questo mollusco, apprezzato per il suo impiego
in ambito tessile.
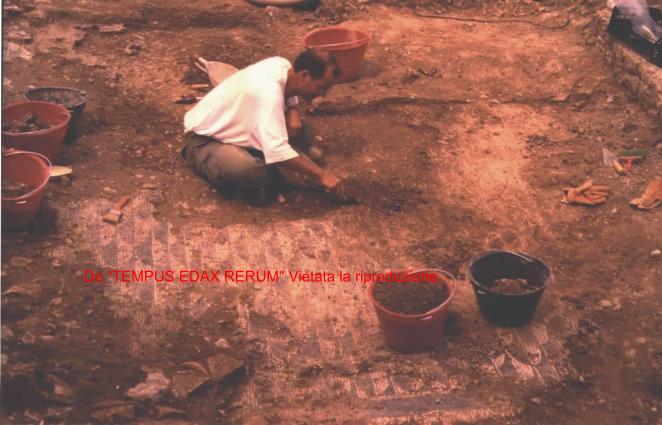 |
Villa di Via Colombo a Monfalcone |
L'area
abitativa si estende a Nord e, analogamente a quanto riscontrato
per le ville limitrofe, si può presupporre che anche il
complesso di via Colombo si articolasse su piani diversi,
conferendo mobilità strutturale all'edificio: sulla base dei
rinvenimenti del 1996 è possibile proporre la presenza di un
cortile o comunque di un'area scoperta a Nord dei vani 2 e 6,
aperti su di esso con varchi di ampie proporzioni, dotati di
soglie calcare delle quali si sono rinvenute le fondazioni. E'
possibile quindi che la villa si estendesse ulteriormente a Nord,
verso la via publica, racchiudendo con un altro avancorpo il
cortile centrale.
Il collegamento con il bacino si attuava attraverso un corridoio,
3, sul quale affacciavano i vani 1, 2 e forse 6. Di questi il
vano 1, con soglia calcarea provvista dell'incavo per una porta a
battente, presentava lacerti di mosaico in tassellato bianco
mentre nel vano 2 si conservava pressoché completo un mosaico a
tappeto con motivo geometrico a squame bipartite. Una cornice a
doppia fascia nera divideva il tappeto dalla balza marginale
bianca a campitura diagonale, e presentava a contatto del disegno
geometrico una sottile fascetta di tre file di tessere rosa,
particolare questo la cui maggior incidenza nella nostra area ha
indotto ad ipotizzare che gli artigiani potessero in qualche modo
essere collegati con l'attività estrattiva delle cave di
Aurisina (MASELLI SCOTTI 1994; FONTANA 1993). Rimane qualche
perplessità circa la posizione di questo vano nel contesto
planimetrico generale: appare infatti isolato dagli altri vani
attraverso due "corridoi" di c.ca un 1 metro, fatto non
facilmente spiegabile anche in un contesto di più fasi edilizie,
del resto provate dal rinvenimento di strutture rasate, come nel
vano 6, originariamente diviso in due, dove in seconda fase viene
creato una sorta di piccolo atrio comunicante con il cortile
centrale, che introduce al corridoio 3 attraverso un vano di
passaggio fiancheggiato da due colonne delle quali sono stati
rinvenuti i due pilastri calcarei, in parte fondati sulla
rasatura della precedente struttura.
Sulla base del materiale rinvenuto negli strati fondazionali, il
primo impianto della villa andrebbe fissato nel terzo quarto del
I sec. a.C., datazione peraltro confermata dal mosaico del vano
2, mentre la seconda fase di espansione, che previde anche la
costruzione del bacino, è databile intorno alla metà del I d.C.
L'abbandono del complesso deve comunque essere avvenuto piuttosto
precocemente, nell'ambito del II d.C.: non è stato infatti
rinvenuto materiale archeologico più tardo, a differenza della
vicina villa di via delle Mandrie.
Un complesso di depositi massivi di franca origine alluvionale
sigillava uniformemente le strutture archeologiche: in area
limitrofa alla villa è stata portata alla luce una lunga
struttura isolata, a riprova dell'interazione con l'ambiente
umido, che in più punti risultava letteralmente
"divelta" da un'ondata di piena fluviale. Essa aveva
agito da "trappola stratigrafica" favorendo la
concentrazione di depositi eterogenei portati in carico dal
flusso d'acqua: tra di essi, il materiale ligneo, sottoposto a
datazione al radiocarbonio, ha fornito una datazione compresa tra
II e IV d.C.
Su come variasse il paesaggio idrogeologico dall'epoca
tardoantica in poi non è dato sapere sulla sola base
archeologica: le fonti parlano del disastro del 589 d.C.,
paragonato dai cronisti al Diluvio Universale, ma bisogna
scendere appena al 1490 per ritrovare notizie su rotte
catastrofiche dell'Isonzo: in tale data il fiume in piena
modificò l'ampia curva del suo alveo verso Villesse, tanto da
distruggere la chiesa e la canonica di San. Pier d'Isonzo,
invadendo addirittura Aquileia e riversandosi poi in mare
attraverso l'Isonzatto, detto anche Vecchio Isonzo, presso Isola
Morosini.
VD
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
C. BALISTA 1986, Letture sedimentologiche e geoarcheologiche
relative all'insediamento romano di Corte Caravella (Loreo),
"Q. Arch. V." 2, pp.31-37
L. BERTACCHI 1974, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in
AAAd 5, pp.385-399
V. DEGRASSI, P.VENTURA 1999, Ricerche nell'area del Lacus Timavi,
la rete stradade nelle fonti archivistiche, in AAAd 45,
pp.125-145
F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle
villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla
Gallia Cisalpina" 4, Roma
A .GIOVANNINI 1993, L'allevamento ovino e l'industria tessile in
Istria, "AMSIA" 93, 41 n.s., pp.7-34
C. GOMEZEL 1996, I Laterizi Bollati del Friuli Venezia Giulia
(Analisi, problemi, prospettive), l"Album"4,
Portogruaro
F. MASELLI SCOTTI 1993, Recenti scoperte nel territorio di
Monfalcone, "Atti del III Congresso dell'associazione
culturale bisiaca", Monfalcone, pp.7-12
F. MASELLI SCOTTI 1995, Mosaici dell'Agro sud-orientale di
Aquileia, "AISCOM", Atti del II Colloquio, Bordighera,
pp.9-16
SENESI MASTROCINQUE 1985, L'insediamento romano do Corte
Caravella (Loreo). Rapporto preliminare, "Q.Arch. V".
1, pp.11-28
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, pp.113-170
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DI VIA DELLE MANDRIE 10
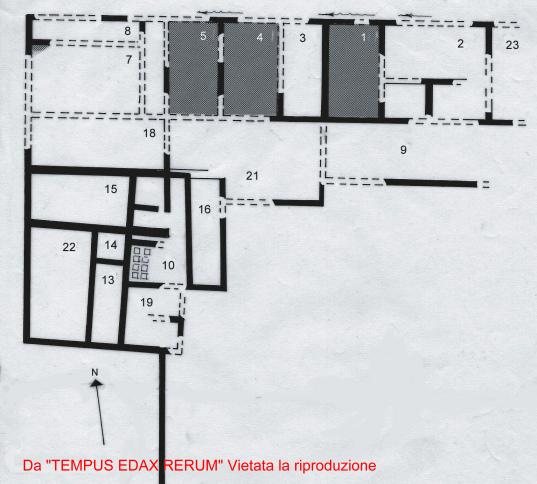 |
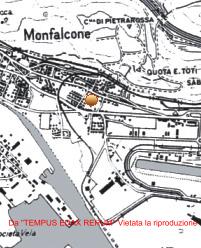 |
La
villa, indagata a partire dal 1990, presenta una planimetria ad
"U", caratterizzata da un corpo centrale articolato su
più livelli e due avancorpi racchiudenti un'area scoperta, tipo
cortile, adibita, almeno nell'ultima fase di vita del complesso,
a rifiutaia. Gli scavi ne hanno portato alla luce tutto il
settore centro occidentale, mentre quello orientale corre sotto
ed aldilà dell'attuale via delle Mandrie.
Il materiale archeologico estremamente eterogeneo, rinvenuto per
la maggior parte durante lo scavo del cortile, copre un
intervallo di tempo che va dal I secolo d.C. a tutto il III. E'
tuttavia possibile rialzare la data di costruzione del complesso
alla seconda metà del I secolo a.C., sulla base del materiale
edilizio -bolli TI.NUCULA e Q.PETILI (GOMEZEL 1996), rinvenuto
reimpiegato nella costruzione di alcune strutture di II fase.
Il corpo centrale della villa si articolava in vari ambienti
disposti l'uno a fianco all'altro, dei quali tre (vani 1, 4 e 5)
presentavano un pavimento costituito da uno strato unico di
scaglie calcaree bianche e nere e cemento, il tutto pressato a
formare un piano compatto, lisciato in superficie con un sottile
velo di calce (la "lorica ex calce et harena"), dove
solo l'inserimento di rari frammenti di cotto sembra rispondere
ad intenti decorativi. Simili pavimenti, che si avvicinano al
tipo di resa dei signini classici pur impiegando materiali
diversi, possono essere datati a partire dalla seconda metà del
I secolo a.C. (DE VOS 1985).
 |
Una veduta del pavimento in opus spicatum nella villa di via delle Mandrie a Monfalcone |
Altri
tre ambienti (vani 2, 2a e 2b), presentavano i pavimenti in opus
spicatum, cioè a piccoli mattoncelli disposti a spina di pesce:
l'utilizzo di questi vani come piccola area termale, suggerita
per la prima fase dal rinvenimento del basamento di una probabile
stufa (Settefinestre 1985 **), è stata confermata per la seconda
fase di utilizzo della villa. Tra la seconda metà del I d.C e
gli inizi del II viene infatti introdotto il sistema di
riscaldamento ad ipocausto: le soglie di passaggio ed i vani
stessi vengono rimpiccioliti, esternamente ai vani vengono
addossate strutture interpretabili come "caldaie" e i
pavimenti in spicatum sfruttati come basamento di suspensurae
atte a sostenere nuovi pavimenti in mosaico. Questi ultimi sono
per noi perduti, ma la loro presenza è stata confermata dal
rinvenimento negli strati di distruzione di tessere sciolte
insieme a spezzoni dei tubi utilizzati per il riscaldamento delle
pareti.
La villa era dotata comunque di altre stanze pavimentate a
mosaico, come testimonia il rinvenimento in un vano di parte di
una fascia perimetrale in tessere nere con orditura diagonale.
L'avancorpo superstite, articolato in più vani dei quali si sono
perse le superfici di calpestio, conserva un piccolo vano dotato
di suspensurae a base quadrata ed. appare caratterizzato da un
lungo muro che si estendeva diritto ed isolato per parecchi metri
in direzione sud. La situazione stratigrafica che lo interessava
ha permesso di ipotizzare la sua funzione di collegamento tra la
villa ed un corso d'acqua, del quale non è stata ancora chiarita
la natura, per quanto l'ipotesi più ragionevole lo colleghi ad
un ramo secondario dell'Isonzo.
Durante un controllo effettuato nel 1999 è stato possibile
verificare che questa struttura si collega ad un'altra ad essa
perpendicolare: il modello ricostruttivo porterebbe ad immaginare
una darsena o simili sull'esempio della vicina villa di via
Colombo.
Il rinvenimento durante gli scavi, di pesi da telaio, tra i quali
uno in pietra, può forse essere ricondotto a forme di attività
legate all'allevamento ovino.
VD
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
M DE VOS 1985, Tecnica e tipologia dei rivestimenti pavimentali e
parietali, in Settefinestre *, pp.74 e ss.
C. GOMEZEL 1996, I Laterizi Bollati del Friuli Venezia Giulia
(Analisi, problemi, prospettive), l"Album" 4,
Portogruaro
F. MASELLI SCOTTI 1993, Recenti scoperte nel territorio di
Monfalcone, "Atti del III Congresso dell'associazione
culturale bisiaca", Monfalcone, pp.7-12
F. MASELLI SCOTTI 1995, Mosaici dell'Agro sud-orientale di
Aquileia, "AISCOM", Atti del II Colloquio, Bordighera,
pp.9-16
M.L. MORRICONE MATINI 1967, (a cura di) Mosaici Antichi in
Italia. Regione Prima, Roma: Reg.X Palatium, Roma
Settefinestre, A CARANDINI, A. RICCI (a cura di), Settefinestre,
Una villa schiavistica nell'Etruria romana, 1-3, Modena, 1985
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
VILLA
DELLA PUNTA 11
 |
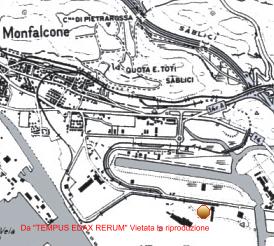 |
La
villa è stata indagata tra il 1970 ed il 1973 a cura del Museo
d'Aquileia sotto la direzione di Luisa Bertacchi. Il complesso, a
parte il rilievo planimetrico, non è stato ancora pubblicato
esaustivamente; esiste tuttavia una notevole documentazione
fotografica degli scavi, conservata presso il laboratorio
fotografico del Museo di Aquileia. In base alla planimetria si
riconoscono una trentina di ambienti articolati in due corpi
contrapposti, collegati da una piccola ala orientale con vani a
disposizione paratattica. La corte interna che ne risulta, sembra
fungere da fulcro organizzativo per l'intero complesso che appare
suddiviso in spazi destinati ad usi specifici.
Nelle ali a Nord ed a Nord-Est va riconosciuta l'area
residenziale: in quest'ultima le superfici dei vani, che
presentano soglie di pietra calcarea, appaiono rivestite da
tessellati in cotto con emblema reso in mosaico geometrico
bianco-nero con motivi a pelte contrapposte inquadrate da
triangoli, combinazioni di squadre inquadrate da una fascia di
tessere alternate bianche e nere. Un vano, probabilmente
triclinare, presenta il riquadro rettangolare, eccentrico, reso
ad esagoni delineati in nero su fondo bianco, motivo questo
tipico del repertorio della prima metà del I secolo d.C.,
presente anche nella villa di Barcola. La fascia in tessellato
nero che riquadra gli esagoni, affianca anche le due strutture
che fiancheggiano l'entrata alla sala. Un lungo corridoio unifica
l'intera ala che nella sua metà Sud sembra essere destinata ad
area rustica: compaiono superfici in cocciopesto (idraulico?) e
in opus spicatum. Apparentemente non sembra ci sia comunicazione
diretta tra le due aree.
L'ala a nord, in base alle superfici, potrebbe costituire il
nucleo più antico del complesso: piccoli vani quadrati
presentano superfici in tassellato di cotto con pseudo-emblemata
centrali resi in tassellato o in battuto impreziositi da tarsie
di marmo di forma geometrica (cerchi, triangoli, quadrati). L'uso
di queste tecniche miste, attestato a Pompei in superfici di
diversa destinazione, ma con particolare frequenza in atri o in
bacini d'impluvio (DE VOS 1984), è particolarmente frequente in
epoca tardo-repubblicana e permette di inquadrare nella seconda
metà del I a.C. la fase iniziale della villa. In area limitrofa
si possono citare a confronto i pavimenti della villa di
Aurisina, sebbene più semplici, e alcuni pavimenti della villa
di Ronchi, caratterizzati dall' associazione di tessellati con
inserzioni di scaglie policrome ed emblema centrale in opus
sectile realizzato con tarsie di marmo geometriche (MASELLI
SCOTTI, VENTURA 1991).
L'ala ad Ovest rimane di problematica identificazione: un suo
utilizzo rustico potrebbe essere proposto sulla base del
rinvenimento di una pressa da olive di forma rotonda con foro
centrale per il montante e di un plinto in pietra con due incassi
rettangolari (visibile nel rilievo), forse riconducibile ad un
lapis pedicinus (Settefinestre 2, 1985), la base per i montanti
esterni di un torcular di cui si sarebbe persa la base di
spremitura, solitamente delineata sul pavimento, che andrebbe
ricercata nell'area antistante, pavimentata in sesquipedali di
cotto.
Più complessa e forse identificabile con un'area termale votata
all'utilizzo delle acque sulfuree che sgorgano spontanee nei
pressi, è la serie di vani che chiude a settentrione l'ala Ovest
e che, in base alla posizione delle soglie, sembra aprirsi su un
altro "cortile" affacciato sulla laguna dove, a poche
decine di metri di distanza, è stata rinvenuta una barca. Il
celebre mosaico con riquadro centrale raffigurante due delfini
neri affrontati ad un tridente in campo bianco, rinvenuto in
questa ala della villa (fine I d.C., BERTACCHI 1979), è
pertinente ad un vano che, in base al rilievo, sembra essere
isolato e non avere comunicazione con i vani limitrofi. Tra
questi va segnalata una grande vasca con rivestimento in
cocciopesto idraulico e gradino d'entrata alla quale se ne
addossano altre tre più piccole, poste ad una quota inferiore.
La barca precedentemente descritta, è ora restaurata e
visitabile in un padiglione del Museo Nazionale di Aquileia:
contrariamente ad altri rinvenimenti di questo tipo effettuati
nel Nord Adriatico, che testimoniano il perdurare della tecnica
detta "a cucitura", le barche di Monfalcone e di Grado
sono del tipo "a mortase e tenoni", a riprova del loro
utilizzo in mare aperto (BELTRAME 1997).
VD
BIBLOGRAFIA
ESSENZIALE
C. BELTRAME 1997, Sutiles naves e navigazione per acque interne
in età romana, "Padusa" 32/33 n.s.,pp.137-143
L.BERTACCHI 1974, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in
AAAd 5, pp.392 e ss.
L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area
meridionale, AAAd 15, 1, p.83 e ss.
L. E P. BERTACCHI 1988, L'imbarcazione romana di Monfalcone,
Udine
M. DE VOS 1984, Pavimenti e Mosaici, in Pompei 79, a cura di F.
Zevi, Napoli, pp.161-176
F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle
villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla
Gallia Cisalpina" 4, Roma
F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 1991, Notiziario archeologico.
Ronchi dei Legionari - Scavo di una villa romana,
"Aq.N" 62, cc.237 e ss.
Pompei 79, F. ZEVI (a cura di), Pompei 79. Raccolta di studi per
il decimonono centenario dell'eruzione vesuviana, Napoli, 1979
Settefinestre, A CARANDINI, A. RICCI (a cura di), Settefinestre,
Una villa schiavistica nell'Etruria romana, 1-3, Modena, 1985
M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio
aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, pp.113-170
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"
TERME
ROMANE di MONFALCONE 12
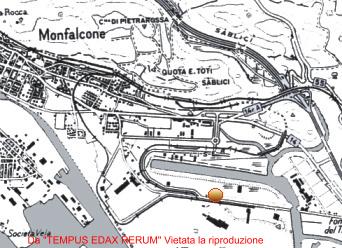 |
Il
centro terapeutico "moderno", oggi abbandonato, sorge
sui resti di quello romano, noto fin dal XV secolo sulla base
delle testimonianze di eruditi dell'epoca interessati al fenomeno
delle sorgenti calde e medicamentose. Sulla base di queste
descrizioni, è stato possibile ricostruire un complesso
suddiviso in più edifici eretti presso le sorgenti dell'isoletta
di S. Antonio: di questi il più importante era dotato di
un'ampia vasca di raccolta per le acque termali, una piscina, con
gradinate d'accesso di marmo, mentre un altro si articolava in
esedre e colonnati, forse interpretabili come giardino annesso ai
bagni o come palestra. Dalla zona vennero recuperate anche alcune
fistulae aquariae di piombo bollate -AQ(uileiensium
servus).DEMET(rius).F(ecit); AQ(uileiensium servus) IUVENAL(is)
F(ecit)-, evidentemente utilizzate per il trasporto dell'acqua,
lacerti di pavimentazione a "mosaico di quadrelloni di cotto
di tre quarte per lato" ed una finestrella in pietra.
Scavi regolari risalgono appena al 1911, diretti da E. Maionica,
effettuati inizialmente nel cortile delle terme romane, dove
"si trovò un edificio con cinque stanze, ben costruite, di
un'area di ca 15 mq ciascuna, con ammattonato di piccoli tasselli
di terracotta e tracce de rivestimento interno ed esterno con
intonaco ricoperto di pitture ad affresco. A sinistra dello
stesso ci sono alcuni lavabo di dimensioni più piccole...".
Il rilievo, conservato nell'archivio-disegni del Museo Nazionale
di Aquileia, mostra una serie di vani articolati attorno ad un
cortile centrale con un portico dotato di basi calcaree davanti
all'ala orientale, probabilmente estendibile anche al corpo
settentrionale. L'ala settentrionale è chiusa da una lunga
struttura che si suppone perimetrale, ripresa anche ad Ovest
dell'edificio termale del 1800. Tutte le superfici risultano
rivestite in tessellato di cotto. Due vani a Nord presentano
infine la soglia calcarea d'accesso.
Dalla zona delle terme provengono anche due iscrizioni con dedica
alla Fons che inducono a ricostruire anche uno spazio sacro
all'interno del complesso terapeutico: il culto è riconducibile
probabilmente a quello di Fons Timavi, connesso con il culto
delle acque, che godette di particolare fortuna con il I sec.
d.C. Legami alla sfera magico-cultuale provengono infine da tarde
leggende della tradizione locale che parlano delle
"Fate", figure che abitavano una grotta nei pressi
delle sorgenti conosciuta anche con il nome di "Diavolo
Zoppo", nelle quali si potrebbe leggere un indizio di
"substrato mitologico comune" (MARCHIORI 1982) con le
popolazioni delle Alpi Orientali ed in particolare con due centri
terapeutici di Lagole di Calalzo in Cadore e Comano in Trentino.
Tale legame verrebbe in qualche modo rafforzato dal rinvenimento
nella chiesa di S. Giovanni di un'iscrizione con dedica alle
Fatae.
Il ritrovamento infine di tre iscrizioni con dedica alla Spes
Augusta per grazia ricevuta, riutilizzate nell'alzato dell'abside
della chiesa di S. Giovanni in Tuba, ha indotto ad ipotizzare uno
sdoppiamento tra localizzazione del centro termale e quella del
centro di culto: quest'ultimo, situato lungo la via Gemina, in
una posizione estremamente favorevole per qualsiasi area sacra,
avrebbe accolto gli ex-voto delle persone che si fossero curate
nelle terme decentrate sull'isoletta del Lacus Timavi.
VD
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE
G. CUSCITO 1976, Revisione delle epigrafi di età romana
rinvenute attorno al Timavo, in AAAd 10, pp.48 e ss.
M. DURIGON 1999, Le grotte del Carso in età romana,
"A.Tr" 59, s. IV
A. MARCHIORI 1982, Le terme romane di Monfalcone, localizzazione
del centro termale, "Aq.N" 53, coll.101-128
E. MAIONICA 1912, Scoperte archeologiche al Timavo e alle terme
di Monfalcone, "Forum Julii" II, 9
E. REISCH 1913, Die Grabungen des Oesterreicheschen
archaologischen Instituts warhend del Jahre 1912-1913,
„Oesterr Jahresh.", XVI, Beiblatt
Tempus Edax Rerum
"Il tempo che divora ogni cosa"