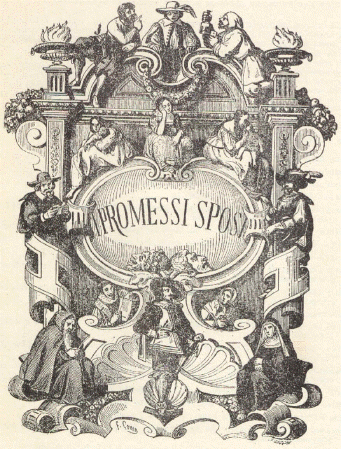|
|
 |
Il riassunto dei
Promessi Sposi
|
|
|
Ipocrisia del padre di Gertrude. – Letta quella lettera, il principe mandò a chiamare Gertrude, che, giunta alla presenza del padre, gli si buttò ginocchioni davanti ed ebbe appena il fiato di dire: «Perdono!». Egli le rispose che il perdono bisognava meritarlo, e cominciò a parlare a lungo del fallo di lei, dicendo che, quand’anche… caso mai… avesse avuto prima intenzione di maritarla, lei stessa aveva messo ora un ostacolo insuperabile, perché a un cavaliere d’onore, come era lui, non sarebbe mai bastato l’animo di regalare a un galantuomo una signorina, che aveva dato un tal saggio di sé, e che essa doveva vedere, in questo triste accidente, come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei… Gertrude si lascia scappare un sé. – La povera Gertrude, scossa dal timore, si lasciò scappare un sì. Allora il principe cambiò tono, mandò a chiamare subito la principessa e il principino, e disse loro che Gertrude non aveva più bisogno di consigli, e che ciò che essi desideravano per suo bene, l’aveva voluto le spontaneamente, e che era risoluta prendere il velo. La principessa e il principino si congratularono, mentre il principe propose di andare subito a Monza per fare la richiesta alla badessa, richiesta che differì al giorno seguente per desiderio di Gertrude. Allora il principe, per non perder tempo, si recò dal vicario delle monache per fissare la data dell’esame, e fu stabilito che esso avrebbe avuto luogo da lì a due giorni. Le congratulazioni dei parenti e degli amici. – Subito dopo partito il principe, la sposina (così chiamavano allora le giovani monache) fu condotta nel gabinetto della principessa, dove fu pettinata ed elegantemente vestita; poi si recò a pranzo, dove trovò alcuni parenti più prossimi, che erano stati invitati in fretta per farle onore e per rallegrarsi della spiegata vocazione; dopo il pranzo andò in carrozza con la madre e con due zii, che si misero a parlare come portava la convenienza in quel giorno; al ritorno, sul tardi, trovò a casa amici e parenti che, essendo corsa la voce dell’avvenimento, erano venuti a fare il loro dovere. Partite le visitie, si cenò in fretta, per ritirarsi subito ed essere pronti il giorno dopo di buon’ora. Gertrude si reca al monastero per chiedere di essere ammessa. – Al mattino seguente Gertrude, dopo che il principe l’ebbe tirata in disparte per dirle come doveva rispondere alla badessa, insieme coi genitori ed il fratello montò in carrozza. Giunti al monastero, videro la porta del chiostro interno spalancata e tutta occupata da monache, tra cui in prima fila la badessa. Questa, dopo i primi complimenti, domandò a Gertrude cosa desiderasse in quel luogo, ed essa, dopo una breve esitazione, rispose che voleva vestir l’abito religioso. La badessa aggiunse subito che bisognava attendere i voti comuni delle suore, ma che poteva prevedere con certezza quele sarebbe stata la risposta. Poi fece venire il principe alla grata del parlatorio, e gli disse che, per ubbidire alle regole, era obbligata ad avvertire i genitori che, se per caso forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica; ma il principe rispose che essa non poteva dubitare. La madrina. – Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, faceva tristemente il conto delle occasioni, che le rimanevano ancora di dir di no; e prometteva debolmente e confusamente a se stessa che, in questa o inquell’altra, sabrebbe stata più destra e più forte. Sulla fine della cena, il principe desse che bisognava pensare a una madrina, che fosse custode e scorta della giovane monacanda nel tempo tra la richiesta e l’entrata al monastero, tempo che veniva speso nel visitare le cose più notabili della città e dei dintorni, affinché le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a cosa dovessero rincinciare. La scelta fu lasciata a Gertrude, la quale indicò la dama che, in quella sera, si era mostrata verso di lei più premurosa; ma tali premure non erano senza motivo, poiché la dama aveva già da molto tempo messo gli occhi addosso al principino per farlo suo genero. L’esame del vicario. – Il giorno dopo Gertrude si svegliò col pensiero dell’esaminatore che doveva venire; e mentre stava ruminando se potesse cogliere quell’occasione per tornare indietro, il principe la fece chiamare e le disse che, se le fosse nato qualche pentimento, avrebbe dovuto spiegarsi, ma al punto in cui erano le cose non era più tempo di far ragazzate, minacciandola oscuramente che, se avesse esitato nelle risposte al dabben uomo, sarebbe stato costretto a svelare il vero motivo della risoluzione di lei, ossia la lettera diretta al paggio. Gertrude divenne rossa e le si gonfiarono gli occhi. Arrivò intanto il vicario, che, dopo i primi compliemtni, incominciò a interrogare Gertrude nella forma prescritta dalle regole; e la giovane rispose che essa si faceva monaca liberamente, che aveva sempre avuto quella vocazione, che voleva servire Dio e fuggire i pericoli del mondo. Finito l’esame, il vicario s’imbattè nel principe, e si congratulò con lui per le buone disposizioni in cui aveva trovato la figliuola. Fu quindi tenuto il capitolo per l’accettazione di Gertrude. Esso ottenne i due terzi dei voti segreti che erano richiesti dai regolamenti, e la giovane fu accettata. Monaca per sempre. – Essa stessa, stanca di quel lungo strazio, chiese di entrare più presto che fosse possibile nel monastero. Fu fatta la sua volontà e vestì l’abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di risentimenti, si trovò al momento della professione, in cui conveniva dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripetè e fu monaca per sempre. Gertrude maestra delle educande. – E’ una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, in qualsivoglia termine, ricorra ad essa. Se al passato non vi è rimedio, essa dà mdo di fare reealmente, ciò che si dice in proverbio, di necessità virtù. Ma l’infelice Gertude, invece di abbracciare con santa rassegnazione il nuovo stato, si dibatteva sotto il giogo, e così ne sentiva più forte il peso e le scosse. Idolatrava insieme e piangeva la sua bellezza, deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio, e invidiava qualunque donna, in qualunque condizione, con qualunque coscienza, potesse liberamente godersi nel mondo quei doni. Poco dopo la professione era stata fatta maestra delle educande, ma, quando le veniva in mente che molte di loro erano destinate a vivere in quel mondo dal quale essa ere esclusa per sempre, provava contro quelle poverette un astio, un desiderio quasi di vendetta; in altri momenti lo stesso orrore per il chiostro scoppiava in accessi d’uomore tutto opposto, e allora non solo si mischiava nei loro giochi, ma lirendeva più sregolati. Così visse alcuni anni, non avendo comodo, né occasione di fare di più; quando la sua disgrazia volle che un’occasione si presentasse. Egidio. – Tra gli altri privilegi che le erano stati concessi c’era quello di stare in un quartiere a parte, che era contiguo a una casa abitata da un giovane, scellerato di professione, di nome Egidio. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduto Gertrude qualche volta passare o gironzolare in quel luogo, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empità dell’impresa, osò un giorno rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. Si videro allora gran novità in tutta la condotta di Gertrude: divenne tutt’a un tratto più regolare, più tranquilla, smise gli scherni e il brontolìo, ma ben presto tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci, tornarono a farsi sentire le imprecazioni e gli scherni contro la prigione claustrale. La scomparsa della conversa. – Un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa, si lasciò andare a maltrattarla fuor di modo, la conversa, dopo essersi un pezzo morse le labbra, perdette la pazienza e buttò là una parola che lei sapeva qualche cosa e che, a tempo e luogo, avrebbe parlato. Da quel momento la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata invano, una mattina, alle sue consuete occupazioni. Furono fatte ricerche dappertutto, ma senza frutto; finchè fu scoperta una buca nel muro dell’orto, che fece pensare che la conversa fosse fuggita di là. Si disse che fosse riparata a Monza, e principalmente a Meda, da dove essa proveniva, o che si fosse rifugiata in Olanda. Ma forse si sarebbe potuto sapre di più se, invece di cercare lontano, si fosse scavato vicino. E quante volte l’immagine di quella donna veniva a cacciarsi d’improvviso nella mente della signora, e si piantava lì e non voleva muoversi! Quante volte la signora avrebbe desiderato vedersela innanzi viva e reale, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile! I signori han tutti un po’ del matto. – Era scorso circa un anno da quel fatto, quando Lucia fu presentata alla signora ed ebbe quel colloquio, durante il quale si sentì fare delle domande, che le sembravano più che nuove e strane in bocca ad una monaca, e che la fecero stupire e arrossire. Appena si trovò con la madre, se ne aprì con lei; ma Agnese, come più esperta, sciolse tutti quei dubbi, dicendo che i signori, chi più chi meno, han tutti un po’ del matto. Don Rodrigo attende il ritorno dei bravi. – Mentre i bravi, come un branco di segugi, che hanno inseguito invano una lepre, tornavano mortificati verso il palazzotto di don Rodrigo, questi, in una stanzaccia disabitata dell’ultimo piano, che rispondeva sulla spianata, camminava innanzi e indietro al buio, pieno d’impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l’incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili, perché quell’impresa era la più grossa e la più arrischiata a cui il brav’uomo avesse ancor messo mano. La relazione del Griso. – Quando vide dalla finestra che i bravi tornavano senza la bussola, comprese che l’impresa era fallita. Il Griso, deposta la sua veste da pellegrino, salì, come richiedeva la sua carica, a render conto a don Rodrigo di quanto era accaduto. Questi, che l’aspettava in cima alla scala, quando lo vide apparire con un’aria di birbone deluso, lo coprì di insulti e di ironie («Signor spaccone, signor capitano, signor lascifareame»); ma quando apprese lo svolgimento dei fatti, gli disse che si era portato bene e che forse vi doveva essere una spia in casa. Il Griso rispose che, da varie cose, gli era apparso di poter rilevare che ci doveva essere qualche altro intrigo, per il momento inspiegabile. La conclusione fu che don Rodrigo ordinò al Griso, per il giorno dopo, tre cose: spedire la mattina presto due uomini a fare al console quella tale intimazione, che fu poi fatta, come abbiamo veduto; due altri al casolare a far la ronda, per sottrarre a ogni sguardo la bussola fino alla notte prossima, in cui si sarebbe mandato a prenderla; andar poi lui, e mandar anche altri, a mescolarsi con la gente, per scovar qualcosa intorno all’imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, don Rodrigo se n’andò a dormire, e ci lasciò andare anche il Griso. Il conte Attilio promette di rivolgersi al conte zio. – La mattina seguente, appena alzato, don Rodrigo cerò il conte Attilio per metterlo al corrente dell’accaduto. Il conte Attilio, vedendo spuntare il cugino, gli ricordò in tono canzonatorio che quel giorno era S. Martino; poi, udito come si erano svolte le cose, avanzò subito l’ipotesi che in quella faccenda doveva aver messo lo zampino fra Cristoforo, e si fece riferire il dialogo avvenuto il giorno prima col frate; infine, dopo aver fatto le sue meraviglie perché il cugino l’aveva lasciato andar via senza la punizione che gli stava bene, promise che, per mezzo del signor conte zio del Consiglio segreto, avrebbe pensato a servire il frate nel modo migliore. Venne intanto la colazione, la quale non interruppe il discorso d’un affare di quell’importanza. Poi il conte Attilio uscì per andare a caccia, mentre don Rodrigo stette aspettando con ansietà il ritorno del Griso. Il Griso riferisce le notizie raccolte in paese. – Il Griso ritornò finalmente sull’ora del desinare a fare la sua relazione. Lo scompiglio di quella notte era stato tanto clamoroso, la sparizione di tre persone da un paesello era un tale avvenimento, che il Griso poté comporre per don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Perpetua non poteva farsi veder sull’uscio, che non fosse tempestata da quello e da quell’altro, perché dicesse chi era stato a fare quella gran paura al suo padrone; Gervaso, a cui non pareva vero d’essere una volta più informato degli altri, crepava dalla voglia di vantarsene; Tonio non aveva potuto dissimulare il fatto a sua moglie, la quale non era muta; i genitori di Menico, quantunque avessero tenuto in casa il figliuolo per quel giorno e per qualche altro ancora, andarono essi stessi chiacchierando con la gente del paese, aggiungendo, come cosa conosciuta, che i tre poveretti si erano rifugiati a Pescarenico. Il Griso informò perciò il suo padrone del colpo tentato dai poveri sposi, il che spiegava naturalmente la casa trovata vuota e il sonare a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in casa ci fosse un traditore; l’informò anche della fuga, che si poteva spiegare col timore degli sposi colti in fallo o con qualche avviso dell’invasione. Disse finalmente che si erano ricoverati a Pescarenico: più in là non andava la sua scienza. Don Rodrigo invia il Griso a Pescarenico. – Don Rodrigo, dopo essersi compiaciuto che nessuno l’avesse tradito e che non erano rimaste tracce del suo fatto, mandò subito il Griso a Pescarenico per sapere che cosa fosse avvenuto dei tre fuggiaschi, e il Griso la sera di quel giorno medesimo poté riportare al suo degno padrone la notizia, messa in giro in tutto segreto dal barocciaio al suo ritorno a Pescarenico, che Lucia e sua madre si erano rifugiate in un convento di Monza e che Renzo aveva continuato la sua strada fino a Milano. Don Rodrigo invia il Griso a Monza. – Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione, e sentì rinascere un po’ di quella scellerata speranza d’arrivare al suo intento. Alzatosi presto al mattino, ordinò al Griso di recarsi a Monza per avere più chiare notizie di Lucia e per sapere se ci fosse da tentar qualche cosa; e poiché il Griso si mostrava titubante a causa di una taglia posta sul suo capo, gli consigliò di prendere con sé un paio di bravacci, lo Sfregiato e il Tiradritto, in modo da far passare ai birri di quella città la voglia di mettere la vita a un gioco così rischioso. Don Rodrigo avrebbe voluto anche trovare il modo che Renzo non potesse più tornare con Lucia, né metter piede in paese. Si poteva, per esempio, dare un po’ di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un’aggressione, un atto sedizioso, e, per mezzo del dottor Azzecca-garbugli, fare intendere al podestà che era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura; ma (come vanno le cose di questo mondo!) il giovane medesimo lavorava di cuore a servirlo, in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputo trovare. Renzo a Milano. – Dopo la dolorosa separazione dalle due donne, Renzo camminava verso Milano in quello stato d’animo che ognuno può immaginarsi facilmente. Giunto nei pressi della metropoli lombarda, vide in lontananza la mole magnifica del duomo, e si fermò sui due piedi a contemplarla; ma, voltandosi indietro, vide all’orizzonte il suo Resegone e si sentì tutto rimescolare il sangue. Quando s’accorse di esser ben vicino alla città, s’accostò a un viandante, chiedendogli la strada più breve per andare al convento dei cappuccini; e quello, con inusitata gentilezza, dopo aver letto sulla lettera del giovane l’indirizzo di Porta Orientale, gliela indicò. Renzo rimase stupefatto ed edificato della buona maniera dei cittadini verso la gente di campagna; ma non sapeva che era un giorno fuor dell’ordinario, in cui le cappe s’inchinavano ai farsetti. Pane e farina per terra. – Renzo fece la strada che gli era stata insegnata e si trovò a Porta Orientale. La strada era deserta, di modo che, se non avesse sentito un ronzìo lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso di entrare in una città disabitata. Andando avanti, vide per terra certe strisce bianche e soffici, come di neve, e, chinandosi su una di quelle, trovò che era farina. Dopo pochi passi, ai piedi della colonna di san Dionigi, vide qualcosa di più strano, cioè alcuni piani tondi e bianchissimi, di quelli che egli era solito mangiare nelle solennità. Si chinò, ne raccolse uno e se lo mise in tasca, ne prese un secondo e se lo mise nell’altra, un terzo e cominciò a mangiare, desideroso di chiarire che storia fosse quella. Si era appena mosso, che vide spuntare un uomo, una donna, e, qualche passo indietro, un ragazzetto: tutti e tre con un carico addosso, che pareva superiore alle loro forze, e tutti e tre infarinati nei panni e stravolti e accesi nei visi. L’uomo reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina, che bucato qua e là, ne seminava un poco ad ogni tratto. La donna, che sembrava avesse un pancione smisurato, tenuto a fatica da due braccia piegate, come una pentolaccia a due manichi, teneva per il lembo la sottana, con dentro farina quanta ce ne poteva stare, e un po’ di più, in modo che, quasi a ogni passo, ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutt’e due le mani sul capo una paniera colma di pane, ma, avendo le gambe più corte dei suoi genitori, rimaneva a poco a poco più indietro, e, allungando poi il passo per raggiungerli, la paniera perdeva l’equilibrio e qualche pane cadeva, provocando le irose minacce della madre. Renzo, da queste e da altrettali cose che vedeva e sentiva, cominciò a capire che era arrivato in una città sollevata. Renzo giunge al convento. – Appena giunto al convento, chiese del padre Bonaventura; ma il portinaio gli rispose che il frate non era al convento e che poteva aspettarlo in chiesa. Il giovane fece pochi passi verso la chiesa, ma poi pensò di dar prima un’altra occhiata al tumulto e si mosse verso l’interno della città, dove il brulichio era più folto e più rumoroso. La carestia a Milano. – Era quello il secondo anno di raccolta scarsa. La contrarietà delle stagioni e il guasto e lo sperperio della guerra per la successione di Mantova e per il possesso del Monferrato avevano subito fatto sentire la carestia, e con la carestia il rincaro. Ma, con suole avvenire, quando il rincaro oltrepassò un certo segno, la moltitudine credette che esso non fosse prodotto dalla scarsezza del grano, ma dagli incettatori e dai fornai che lo tenevano nascosto, e cominciò a chiedere provvedimenti e rimedi. E poiché i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno la virtù di diminuire il bisogno del cibo, né di far venire derrate fuor di stagione, così il male durava e cresceva. Nell’assenza del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova, che comandava l’assedio di Casale nel Monferrato, faceva le sue veci in Milano il gran cancelliere Antimonio Ferrier, pure spagnolo. Egli fissò il prezzo del pane, che sarebbe stato equo se il grano si fosse venduto a trentatré lire il moggio, mentre si vendeva pure a ottanta. Fece come una donna stata giovane, che pensasse di ringiovanire alterando la sua fede di battesimo. La moltitudine, vedendo convertito in legge il suo desiderio, accorse subito ai forni a chiedere pane al prezzo tassato; e sebbene i forni facessero vedere ai magistrati l’iniquità del carico imposto lor, Ferrer rimase fermo su ciò che aveva stabilito. Finalmente don Gonzalo, conosciuta la necessità di un più equo prezzo, nominò una giunta, che deliberò di rincarare il pane. I fornai respirarono, ma il popolo montò su tutte le furie. I primi tumulti. – La sera avanti il giorno in cui Renzo arrivò a Milano, le strade e le piazze brulicavano di uomini, che, trasportati da una rabbia comune, si riunivano in crocchi. Ogni discorso accresceva la persuasione e la passione degli uditori, come colui che l’aveva proferito. Tra essi ve n’erano alcuni, che s’adoperavano per intorbidare le acque, con quei ragionamenti e con quelle storie che i furbi sanno comporre. Migliaia di uomini andavano a letto con il sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare e che qualche cosa si farebbe. Avanti giorno le strade erano ancora sparse di crocchi: non mancava altro che un’occasione qualunque per ridurre le parole ai fatti, e non tardò molto. Uscivano, sul far del giorno, dalle botteghe dei fornai i garzoni che, con una gerla carica di pane, andavano a portarle alle solite case. Il primo comparire di uno di quei malcapitati fu il segnale della rivolta. Il ragazzo fu fatto fermare e la gerla gli fu svuotata in un baleno. Coloro a cui non era toccato nulla, si mossero in cerca di altre gerle: quante incontrate, tante svaligiate. Ma coloro che rimanevano a denti secchi, e quelli che non erano rimasti soddisfatti di prede così piccole, cominciarono a gridare: «Al forno! al forno!». L’assalto al forno delle grucce. – Tutta la gente si avviò allora al forno delle grucce, nella strada chiamata la Corsia dei Servi. Quelli della bottega chiusero in fretta e puntellarono i battenti, mentre la gente cominciava a gridare: «Pane! pane! aprite! aprite!». Pochi momenti dopo arrivò il capitano di giustizia con una scorta di alabardieri, che, dopo essersi fatto largo attraverso la folla, riuscirono a farsi aprire da quelli di dentro e ad entrare nella bottega. Il capitano salì di corsa le scale e, affacciatosi ad una finestra, esortò la folla ad andare a casa, ma, mentre faceva il suo discorsetto a quei buoni figlioli, una pietra, uscita dalle mani di uno di essi, colpì la fronte del capitano, sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica, costringendolo a ritirarsi. Frattanto la folla, con pietre e con ferri, riuscì a sfondare la porta e a svellere le inferriate, mentre i padroni e i garzoni della bottega, che erano alle finestre dei piani di sopra, cominciarono a gettare pietre sugli assalitori. Neppure una ne cadeva in fallo, poiché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. Più d’uno fu conciato male e due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe allora la forza della moltitudine: la porta fu sfondata, l’inferriate divelte, e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta: il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa si rannicchiarono nei cantucci; altri, uscendo per gli abbaini, andarono su per i tetti come i gatti. I vincitori si slanciarono ai cassoni: tutto fu messo a ruba, il pane, il denaro del banco, i sacchi di farina, e perfino la pasta che vi era nella madia. Mentre questo forno veniva così messo sottosopra, anche gli altri della città correvano lo stesso pericolo; ma in alcuni i padroni riuscirono a stare sulle difese, in altri distribuirono il pane gratuitamente, mentre gli alabardieri e la sbirraglia tenevano in rispetto i tumultuanti. Renzo davanti al forno delle grucce e in piazza del Duomo. – A questo punto erano le cose, quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, si avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Mentre procedeva, prestava orecchio ai discorsi svariati e confusi della gente, particolarmente contro il vicario di provvisione, giudicato l’autore di tutti quei mali. Arrivò finalmente davanti al forno delle grucce, e, contemplando quel brutto e recente soqquadro, disse tra sé: «Questa poi non è una bella cosa… se concian così tutti i forni, dove voglion fare il pane? Né pozzi?». Poi, vedendo che alcuni si allontanavano con un pezzo di cassone o di madia o di frullone od altro, e s’incamminavano dalla stessa parte, come a un luogo convenuto, andò dietro ad uno che portava un fascio d’asse spezzate e di schegge in ispalla, e giunse in piazza del Duomo, dove, fra un cerchio di folla schiamazzante, ardeva un mucchio di brace, che veniva alimentato dagli attrezzi detti di sopra. Renzo in piazza Cordusio. – Quando finì la fiamma e la gente cominciava ad annoiarsi, si sparse la voce che al Cordusio, una piazzetta non molto distante, si era messo l’assedio ad un forno. Tutti cominciarono ad avviarsi in quella direzione, mentre Renzo teneva consiglio in cuor suo, se dovesse uscir dal baccano e ritornare al convento, o andare a vedere anche quest’altra. Prevalse di nuovo la curiosità, ma risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia a farsi ammaccare le ossa, ma di tenersi in disparte ad osservare. Giunto al Cordusio, vide alcuni che se ne stavano a qualche distanza dalla bottega, la quale era chiusa, e alle finestre gente armata, in atto di star pronta a difendersi. Quella vista produsse un ronzio confuso di opposti pareri. Ad un tratto scoppiò in mezzo alla folla una maledetta voce: «C’è qui vicino la casa del vicario di provvisione: andiamo a far giustizia e a dare il sacco»; e la folla, al grido «Dal vicario! dal vicario!», si mosse tutta insieme verso la strada, dove era la casa nominata. Il vicario di provvisione in soffitta. – Lo sventurato vicario stava, in quel momento, facendo un chilo agro e stentato, e attendeva con gran sospensione come avesse a finire quella burrasca, lontano però dal sospettare che dovesse cadere così spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo percorse di galoppo la folla, per avvertirlo di quel che gli sovrastava, appena in tempo per chiudere porte e finestre. Il meschino, udendo la folla che lo chiamava tiranno e affamatore, e che lo voleva vivo o morto, girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandando a Dio e ai suoi servitori, che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Salì infine in soffitta, e, vedendo da un pertugio la strada zeppa di furibondi, andò a rannicchiarsi nel più sicuro e riposto nascondiglio. Renzo nel forte del tumulto. – Renzo questa volta, si trovava nel forte del tumulto, non già perché vi fosse portato dalla piena, ma perché vi si era cacciato deliberatamente, col proposito di assecondare coloro che volevano salvare il vicario. Egli si era spinto fin quasi alla porta del palazzo, che i più scalmanati cercavano in ogni modo di abbattere, mentre altri, perfino con le unghie, scalcinavano e sgretolavano il muro per aprirsi una breccia. Il comandate del castello, avvertito di quel che accadeva, mandò un ufficiale ed alcuni soldati, ma essi arrivarono quando la casa era già cinta di vasto assedio, e fecero alto lontano da quella, all’estremità della folla. L’ufficiale non sapeva che partito prendere, e, poiché la sua irresolutezza parve, a diritto o a torto, paura, la gente non badò neppure ad essi, o, se era un po’ lontano, li provocava con visacci e grida di scherno. Il vecchio mal vissuto e l’indignazione di Renzo. – Spiccava tra gli altri un vecchio mal vissuto, che, con un sorriso di compiacenza diabolica, agitava in aria un martello, una corda, quattro gran chiodi, coi quali diceva di voler attaccare il vicario ad un battente della sua porta, dopo che fosse ammazzato. Renzo, a tale vista, non poté trattenere un grido di protesta e di orrore; ma ciò bastò perché fosse scambiato per un servitore del vicario, e perfino il vicario stesso, travestito da contadino. E se la sarebbe vista brutta, se alcuni vicini non l’avessero preso in mezzo, cercando di confondere con alte e diverse grida quelle voci nemiche ed omicide; e soprattutto se non fosse giunta una lunga scala a mano, che alcuni volevano appoggiare alla casa per entrarvi da una finestra, e che, picchiando su spalle, braccia, costole, avanzava balzelloni, scompigliando la folla. Renzo approfittò della confusione per allontanarsi da quel luogo, dove non c’era buona aria per lui, con l’intenzione di uscire dal tumulto e di andare davvero a trovare il padre Bonaventura. L’arrivo di Antonio Ferrer. – Tutt’a un tratto un movimento si propagò per la folla, una voce si sparse: «Ferrer! Ferrer!». Infatti all’estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere, il quale, rimordendogli probabilmente la coscienza di esser stato coi suoi spropositi la causa, o almeno l’occasione, di quella sommossa, veniva ora a cercar d’acquietarla, spendendo bene una popolarità mal acquistata. L’uomo era gradito alla moltitudine per quella tariffa di sua invenzione, così favorevole ai compratori, e per quel sue eroico star duro contro ogni ragionamento in contrario. Gli animi già propensi erano ora ancor più innamorati dalla fiducia animosa del vecchio, che, senza guardie, veniva ad affrontare una moltitudine irritata e procellosa; e faceva poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigione il vicario. I partigiani di Ferrer lo secondavano in cento maniere: quelli che si trovavano vicino a lui, eccitando e rieccitando col loro il pubblico applauso, e cercando insieme di far ritirare la gente, per aprire il passo alla carrozza; gli altri, applaudendo, ripetendo e facendo passare le sue parole, o quelle che a loro parevano le migliori che potesse dire, dando sulla voce ai più furiosi e più ostinati. Renzo partigiano di Ferrer. – Renzo, rammentandosi del vidit Ferrer, che il dottor Azzecca-garbugli gli aveva gridato all’orecchio, chiese a un vicino se quello era quel Ferrer che aiutava a far le gride, e, avendo avuto risposta affermativa, riuscì, con certe sue spinte e gomitate da alpigiano, a farsi largo e ad arrivare in prima fila, proprio di fianco alla carrozza. Ferrer promette di condurre in prigione il vicario. – Il vecchio Ferrer presentava or all’uno, ora all’altro sportello, un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso, un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di don Filippo IV; ma fu costretto a spenderlo anche in questa occasione. Parlava e si aiutava anche coi gesti, ora mettendo la punta delle mani sulle labbra, a prendere un bacio che le mani, separandosi subito, distribuivano a destra e a sinistra in ringraziamento alla pubblica benevolenza; ora stendendole o movendole lentamente fuori d’uno sportello, per chiedere un po’ di silenzio. Prometteva inoltre pane ed abbondanza, e asseriva di esser venuto per condurre in prigione il vicario, per dargli il giusto castigo, soggiungendo sottovoce: «si es culpable». Chinandosi poi verso il cocchiere, gli diceva in fretta: «adelante, Pedro, si puedes». Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine, e dimenando adagio adagio la frusta, a destra e a sinistra, con una grazia ineffabile, chiedeva ai vicini un po’ di luogo per poter passare. Renzo fa far largo alla carrozza di Ferrer. – Renzo, dopo esser stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, mise da parte ogni pensiero di andarsene, e si risolvette di aiutare Ferrer, unendosi a coloro che cercavano di ottenere un po’ di largo. Ferrer, in mezzo ai saluti che scialacquava al pubblico in massa, ne faceva certi particolari di ringraziamento, con un sorriso d’intelligenza, a quelli che vedeva adoprarsi per lui: e di questi sorrisi ne toccò più d’uno a Renzo, al quale parve quasi di aver fatto amicizia con il gran cancelliere. Ferrer giunge alla casa del vicario. – Tra le incessanti acclamazioni, tra qualche fremito anche d’opposizione, che veniva subito soffocato, alla fine Ferrer arrivò alla casa. Egli mise un gran respiro, quando vide la porta ancor chiusa, ma con i gangheri quasi sconficcati. Uscì dalla carrozza, si fermò un momento su predellino, diede un’occhiata in giro, salutò con un inchino la moltitudine, come da un pulpito, e, messa la mano sinistra al petto, gridò: «Pane e giustizia», e franto, diritto, togato, scese in terra, tra le acclamazioni che andavano alle stelle. Intanto quelli di dentro avevano aperto, allargando lo spiraglio appena quanto bastava per far entrare il desideratissimo ospite; e, appena questi fu entrato, riaccostarono i battenti e li riappuntellarono alla meglio. Ferrer porta via il vicario nella sua carrozza. – Il vicario scendeva le scale, appoggiandosi ai suoi servitori, bianco come un panno lavato; ma quando vide il suo salvatore, mise in gran respiro, gli tornò il polso, gli scorse un po’ di vita nelle gambe, un po’ di colore sulle gote, e corse come poté verso Ferrer, dicendogli che era nelle mani di Dio e in quelle di lui, e che non sapeva come avrebbe potuto uscire di lì, dove vi era ovunque gente che lo voleva morto. Ferrer, dopo avergli fatto coraggio, uscì il primo, il vicario dietro, rannicchiato, attaccato, incollato alla toga salvatrice, come un bambino alla sottana della mamma. Il vicario entrò primo nella carrozza e vi si rimpiattò in un angolo; Ferrer salì dopo: la moltitudine vide in confuso, riseppe, indovinò quello che era accaduto, e mandò un urlo d’applausi e d’imprecazioni. Ferrer, durante tutto il cammino di ritorno, riprese il discorso col suo mutevole uditorio, interrompendolo però ogni tanto con qualche parola spagnola, che in fretta si voltava a bisbigliare all’orecchio del suo acquattato compagno. «Sì, signori; pane e giustizia: in castello, in prigione, sotto la mia guardia. Un castigo severo. Esto lo digo por su bien». Già erano vicini a uscire al largo, quando Ferrer vide quei soldati spagnoli, che non gli avevano portato nessun aiuto, ma che non erano stati affatto inutili, giacché, sostenuti e diretti da qualche cittadino, avevano cooperato a mandare in pace un po’ di gente e a tenere il passo libero all’ultima uscita. Essi presentarono le armi al gran cancelliere, il quale fece anche qui un saluto a destra e a sinistra; e all’ufficiale, che venne più vicino a fargli il suo, disse, accompagnando le parole con un cenno della destra: «Beso a usted las manos», parole che l’ufficiale intese per quel che volevano dire realmente, cioè «Mi avete dato un bell’aiuto!». Il cocchiere, nel passare tra quelle due ali di soldati, si riebbe dallo sbalordimento, si rammentò chi era e chi conduceva, e gridando: «Ohè! ohè!» alla gente ormai rada, sferzò i cavalli e fece loro prender la rincorsa verso il castello. Il vicario dichiara di voler dimettersi. – Il
vicario, rassicurato da Ferrer, che gli diceva: «Su, su siamo già fuori»,
dal cessar delle grida e dal rapido moto della carrozza, cominciò a render
grazie, grazie e grazie al suo salvatore; ma manifestò il fermo proposito di
rassegnare la sua carica e di ritirarsi a vivere in una grotta, su una
montagna a far l’eremita, lontano da quella gente bestiale. Che avvenisse
poi di questo proponimento, la storia non lo dice. La folla si disperde. – La folle rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra, per questa e per quella strada. Ma tutte le strade del contorno erano seminate di crocchi, come quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa e gira per l’azzurro del cielo dopo una burrasca, e fa dire a chi guarda in su che questo tempo non si è rimesso bene. Renzo capita in un crocchio e dice la sua. – Intanto si faceva notte e molti tornavano a casa. Renzo, dopo aver aiutato il passaggio della carrozza di Ferrer, uscì anch’egli dalla folla, alla prima cantonata, per respirare un po’ liberamente; e sentendo un gran bisogno di mangiare e di riposarsi, cominciò a guardare in su, da una parte e dall’altra, cercando un’insegna d’osteria, giacché per andare al convento dei cappuccini era troppo tardi. Camminando così con la testa per aria, si trovò a ridosso di un crocchio; e fermatosi, sentì che vi discorrevano di congetture, di disegni per il giorno seguente. Dopo esser stato un momento a sentire, non poté tenersi di non dire anche lui la sua. E persuaso, per tutto ciò che aveva visto in quel giorno, che ormai, per mandar ad effetto una cosa, bastasse farla entrare in grazia a quelli che giravano per le strade, tenne tutto un discorso a modo suo, dicendo che non si facevano solamente bricconerie nell’affare del pane, ma che bisognava mettere rimedio a molte altre scelleratezze, affinché in mondo andasse un po’ più da cristiani. Aggiunse, che, quel che è peggio, le gride vi erano per castigare i prepotenti, ma i dottori non facevano giustizia ai poveri; e, perciò, bisognava andare il giorno dopo da Ferrer, che era un galantuomo, un signore alla mano, e dirgli come stavan le cose: Egli, per parte sua, gliene avrebbe potuto raccontar delle belle, poiché aveva visto coi suoi occhi una grida col nome di Ferrer, che diceva cose giuste, e un dottore, al quale si era rivolto per farsi render giustizia, sembrava che ascoltasse delle pazzie. Renzo parlò tanto di cuore, che gli uditori applaudirono, e fu fissato che il giorno dopo si sarebbero ritrovati tutti insieme in piazza del Duomo per fare qualcosa. Un birro travestito si offre come guida a Renzo. – Renzo chiese chi di quei bravi signori volesse indicargli un’osteria per mangiar un boccone e per dormire, e subito gli si offerse come guida un tale, che aveva ascoltato attentamente il discorso, ma non aveva detto ancor nulla. La radutana si sciolse; e Renzo, dopo molte strette di mano, s’avviò con lo sconosciuto, ringraziandolo della sua cortesia. Durante il cammino lo sconosciuto, che era un birro travestito, fece a Renzo, in aria di discorso, ora una, ora un’altra domanda, e, in tal modo, venne a sapere che egli veniva da Lecco. E forse lo avrebbe condotto direttamente in carcere, se il giovane, vista un’insegna d’osteria, non si fosse rifiutato d’andar più lontano. All’osteria della luna piena. – Renzo con la sua guida entrò in un usciaccio, sopra il quale pendeva l’insegna della luna piena. Trovarono all’interno molta gente, che era seduta su due panche, di qua e di là di una tavola stretta e lunga, e che faceva un gran chiasso. L’oste era a sedere su una panca, sotto la cappa del camino, occupato in apparenza a tracciare con le molle certe figure nella cenere, ma in realtà intento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. Quando i due entrarono, andò loro incontro, e, visto che ebbe la guida, disse tra sé: «maledetto!…… che tu m’abbia a venir sempre tra’ piedi, quando meno ti vorrei!»; poi, data un’occhiata a Renzo, disse ancora tra sé: «non ti conosco: ma venendo con un tal cacciatore, o cane o lepre sarai: quando avrai detto due parole, ti conoscerò». Renzo rifiuta di dare le proprie generalità. – Renzo ordinò un buon fiasco di vino sincero e un boccone, dicendo ad alta voce e ridendo che al pane ci aveva pensato la Provvidenza. E tirato fuori il terzo ed ultimo di quei pani raccolti sotto la croce di san Dionigi, l’alzò per aria, gridando «ecco il pane della Provvidenza!», ma soggiungendo candidamente, tra le sghignazzate dei presenti, ben lontani dal prestargli fede, che non l’aveva come si suol dire, sgraffignato, e che, se avesse potuto trovare il padrone, sarebbe stato pronto a pagarlo. La guida disse poi all’oste che il giovane voleva dormire, e quello ritornò con carta, penna e calamaio, e invitò il forestiero a dare le proprie generalità; ma Renzo, vuotato un terzo bicchiere, non volle assolutamente saperne. L’oste tirò allora fuori la grida, ma Renzo cominciò a imprecare contro quella faccia di ariano con la corda al collo (lo stemma del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova, recante un moro incatenato per la gola), che non aveva fatto andare in galera, il signor don…, soggiungendo che egli non aveva nessuna intenzione di dire i fatti suoi. L’oste, dato uno sguardo d’intesa allo sconosciuto, ritornò a sedere sotto la cappa del camino, pensando tra sé, mentre istoriava di nuovo la cenere: «Altro che lepre! E in che mani sei capitato! Pezzo d’asino!». Renzo si lascia scappare il proprio nome e cognome. – Renzo intanto continuava a bere, diventando sempre più allegro e più loquace, e facendo un gran discorrere di carta, penna e calamaio. La guida, che non vedeva l’ora di andarsene, riattaccò allora il discorso del pane, tirando fuori un suo progetto di tesseramento, che avrebbe dovuto assicurare il pane per tutti, tanto per i poveri che per i ricchi. Egli riuscì in tal modo a farsi dire da Renzo il nome e il cognome («A me, per esempio, dovrebbero rilasciare un biglietto in festa forma: Ambrogio Fusella, di professione spadaio, con moglie e quattro figliuoli. A voi dovrebbero fare un biglietto per… il vostro nome?»); e subito dopo, data la buona notte, se ne andò, mentre Renzo avrebbe voluto che si fosse fermato a bere un altro gocciolino, e, acchiappatolo per una falda del farsetto, tirava forte per farlo sedere di nuovo. Renzo ubriaco. – Renzo riprese a bere, finché, essendo ormai ubriaco, vino e parole continuarono ad andare, l’uno in giù e le altre in su, senza misura né regola. Un poco se la prendeva con l’oste per quel tiro del nome e cognome, un po’ coi signori delle gride e con quel cane assassino di don…; poi accennò al tentativo di matrimonio con quel maledetto ton ton e col signor curato… Infine la mente corse a Lucia, abbassò la testa, e stette qualche tempo come assorto in un pensiero; poi mise un sospiro e alzò il viso, con due occhi inumiditi e lustri, con un certo accoramento così svenevole e sguaiato, che guai se chi n’era l’oggetto avesse potuto vederlo un momento. Egli divenne lo zimbello della brigata; ma per buona sorte, in quel vaneggiamento, gli era rimasta come un’attenzione istintiva a scansare i nomi delle persone, di modo che anche quello, che doveva essere più altamente fitto nella sua memoria, non fu proferito. Renzo va a letto. – L’oste, vedendo che il gioco andava in lungo, si accostò a Renzo, e, dopo molti sforzi, riuscì a trascinarlo nella camera che gli aveva destinata. Mentre l’aiutava a svestirsi, volle fare un altro tentativo per farsi dire il nome e il cognome, ma inutilmente. Quando Renzo si fu levato il farsetto, l’oste l’agguantò subito e, accortosi che vi era il morto, mettendo in opera tutta la sua pratica e tutta la sua pazienza, gli riuscì di fare il conto e di pagarsi. Poi gli stese la coperta addosso, gli disse sgarbatamente «buona notte», uscì dalla camera e chiuse l’uscio a chiave. L’oste si reca al palazzo di giustizia. – Quindi, dopo aver dato alla moglie alcuni avvertimenti sul modo di comportarsi con gli avventori, uscì per recarsi al palazzo di giustizia, brontolando e imprecando contro quel testardo d’un montanaro, quel pezzo d’asino, che, per aver visto un po’ di gente in giro a far baccano, si era cacciato in mente che il mondo avesse a mutarsi, e, su questo bel fondamento, aveva rovinato se stesso e voleva rovinare anche lui. Anch’egli sapeva che vi erano delle gride che non contavano nulla, ma quelle contro gli osti avevano pieno valore, e, se un povero oste non avesse domandato il nome dell’avventore, avrebbe dovuto pagare una pena di trecento scudi, o in caso di impossibilità, cinque di galera…. Al palazzo di giustizia, come in tutti gli altri uffici, c’era un gran da fare, perché si attendeva a dare gli ordini che sembravano i più adatti per sedare i tumulti che si prevedevano per il giorno seguente. Si ordinò a tutti i fornai che facessero pane senza intermissione; si spedirono staffette ai paesi vicini, con ordini di mandar grano alla città; e nello stesso tempo, per rendere più efficaci i consigli con un po’ di spavento, si pensò anche a metter le mani addosso a qualche sedizioso. Il capitano di giustizia, che, dopo l’assalto al forno delle grucce, portava una pezzetta d’acqua vulneraria su uno degli organi della profondità metafisica, aveva fin dal principio del tumulto messo in campo i suoi uomini, come quel sedicente Ambrogio Fusella, che, come s’è visto, aveva tentato il colpo maestro di condurre Renzo caldo caldo alle carceri, come alla locanda più sicura della città, e, sebbene il colpo gli fosse fallito, era riuscito tuttavia a portar ai suoi superiori il nome, il cognome e la patria del giovane. Quando l’oste si presentò a un notaio criminale per fare la sua deposizione, rimase meravigliato nell’apprendere che la polizia ne sapeva già più di lui. Egli dovette subire molti rimproveri per quanto era avvenuto nella sua osteria e l’intimazione di non lasciarsi sfuggire il forestiero. Renzo svegliato dalla polizia. – Allo spuntar del giorno, Renzo russava da circa sette ore, ed era ancora sul più bello, quando due forti scosse alle braccia ed una voce che gridava: «Lorenzo Tramaglino!», lo fece riscuotere. Aperti gli occhi a stento, vide appiè del letto un uomo vestito di nero (il notaio criminale che aveva ricevuto la denunzia) e due armati, uno di qua e uno di là del capezzale. Il suo primo moto fu di sorpresa e di rivolta, ma poi, vedendo che i birri gli mettevano le mani addosso per tirarlo fuori dal letto, cominciò a vestirsi. Mentre si vestiva, diceva che non voleva andare dal capitano di giustizia, perché non aveva a far nulla con lui, ma che voleva esser condotto da Ferrer, perché galantuomo e perché gli aveva delle obbligazioni. Il notaio, che udiva un crescente ronzio che veniva dalla strada, e che perciò desiderava spicciarsi, diceva sempre di sì. Ma anche Renzo si accorgeva del ronzio che proveniva dalla strada, e, guardando in viso il notaio, vi scorgeva in pelle la titubazione che costui si sforzava invano di tener nascosta. Ad un tratto si sentì dalla strada un rumore straordinario. Il notaio non poté trattenersi dall’aprire l’impannata per dare un’occhiatina. Vide che era un crocchio di cittadini, i quali, all'intimazione di sbandarsi, fatta loro da una pattuglia, avevano in principio risposto con cattive parole, e finalmente si separavano continuando a brontolare. Chiuse l’impannata e stette un momentino in forse, se dovesse condurre a termine l’impresa, o lasciar Renzo in guardia dei due birri e correr dal capitano di giustizia per render conto di ciò che accadeva. Ma decise di eseguire gli ordini per non passare per un buono a nulla o un pusillanime. Quando Renzo era ormai tutto vestito, si accorse che dal farsetto mancavano i denari e la lettera di padre Cristoforo; e, rivolgesi al notaio con un volto molto significativo, se li fece restituire. I birri mettono i manichini a Renzo. – Quando giunto in cucina, i birri, ad un cenno del notaio, afferrarono l’uno la destra e l’altro la sinistra di Renzo, e in fretta in fretta gli legarono i polsi con certi ordigni, che, per un’ipocrita figura d’eufemismo, erano detti manichini (=cordicella sparsa di nodi, che aveva all’estremità pezzetti di legno). Il giovane cercò di svincolarsi, ma il notaio lo esortò ad avere pazienza, a procedere diritto per la strada senza farsi scorgere, in modo da conservare il proprio onore; poi, volgendosi ai birri, raccomandò loro di non fargli male, di andare come tre galantuomini che vanno a spasso. Renzo riesce a sfuggire ai birri. – Appena furono in istrada, Renzo cominciò a girar gli occhi di qua e di là, a sporgersi con la persona a destra e a sinistra, a tender gli orecchi, sebbene il notaio gli sussurrasse: «Giudizio, giudizio! il vostro onore; l’onore, figliuolo». Quando Renzo, badando attentamente a tre che venivano con visi accesi, sentì che parlavano d’un forno, di farina nascosta, di giustizia, cominciò a fare anche ad essi dei cenni col viso e a tossire in quel modo che indica tutt’altro che un raffreddore. Quelli guardarono più attentamente la comitiva e si fermarono; con loro si fermarono altri che arrivavano. Il notaio esortò Renzo ad aver giudizio, a badare all’onore, ma il giovane faceva peggio, e i birri, pensando di far bene, gli diedero una stretta di manichini. Renzo cominciò allora a gridare per il dolore; la gente si affollò intorno; il notaio cercò di far credere che si trattasse di un malvivente, di un ladro colto sul fatto, ma Renzo, visto il bel momento, alzò la voce, gridando che era stato arrestato per aver gridato pane e giustizia, e la folle si mise ad incalzare e a pigiare sempre più. I birri, vista la mala parata, lasciarono i manichini, preoccupandosi soltanto di perdersi nella folla; il notaio, che avrebbe desiderato di fare lo stesso, ma che non poteva a causa della cappa nera, fu circondato da ogni parte, e tra grida di «Corvaccio! corvaccio!» e urtoni d’ogni genere, riuscì a stento a trarsi fuori da quel serra serra. Renzo in fuga verso Bergamo. – La folla da ogni parte gridò a Renzo di scappare, di rifugiarsi in un convento o in una chiesa; ma Renzo, in quanto allo scappare, non aveva bisogno di consigli; in quanto al convento e alla chiesa, aveva deciso di andare, senza fermarsi, finché non fosse fuori non solo dalla città, ma dal ducato, perché – pensava – finche posso esser uccel di bosco, non voglio diventare uccel di gabbia. Aveva perciò disegnato di trovare rifugio in quel paese del territorio di Bergamo, dov’era accasato suo cugino Bortolo, che più volte l’aveva invitato ad andar là. Dopo aver chiesto ad una persona, che gli ispirò fiducia, la strada per andare a Bergamo, attraversò la piazza del Duomo, rivide il forno delle grucce, arrivò al convento dei cappuccini, e sospirando disse tra sé che il consiglio di stare in chiesa ad aspettare il padre Bonaventura era stato buono. Giunto alla Porta Orientale, vide un mucchio di gabellieri, rinforzati da soldati spagnoli; ma stavano tutti attenti a non lasciar entrare la gente del contado, così che Renzo poté uscire senza che nessuno gli dicesse nulla, sebbene il cuore gli battesse forte. Vedendo a diritta una viottola, entrò in quella, per evitare la strada maestra, e camminò un pezzo prima di voltarsi indietro. Trovava cascine e villaggi, ma tirava innanzi senza domandarne il nome: era certo di allontanarsi da Milano, sperava di andar verso Bergamo, e questo per il momento gli bastava. Intanto cercava di raccapezzare le cose dette e fatte la sera avanti, di scoprir la parte segreta della sua dolorosa storia, e soprattutto come la polizia avesse potuto conoscere il suo nome. I suoi sospetti cadevano naturalmente sulla guida sconosciuta, alla quale si rammentava bene d’averlo spiattellato. Renzo si tiene lontano dalla via maestra. – Dopo aver camminato un pezzo alla ventura, risolvette di chiedere la strada, come aveva fatto in Milano, al primo viandante la cui fisionomia gli andasse a genio. Costui gli rispose che era fuor di strada e gli indicò quella giusta; ma Renzo, per non battere la via maestra, procedette a zig-zag, così che, dopo forse dodici miglia, si trovava distante da Milano non più di sei, e, in quanto a Bergamo, era molto se non se ne era allontanato. Gli venne allora in mente di scovare, con qualche astuzia, il nome di qualche paese vicino al confine, al quale si potesse andare per strade comunali; e domandando di quello, si farebbe insegnar la strada, senza seminar qua e là quella domanda di Bergamo, che gli pareva puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. Entra in una piccola osteria. – Strada facendo, vide pendere una frasca da una cosuccia solitaria, fuori di un paesello, e poiché sentiva crescere il bisogno di ristorare le sue forze, vi entrò e chiese un boccone. Non c’era che una vecchia, con la rocca al fianco e col fuso in mano, la quale gli offrì un po’ di stracchino e del buon vino, che gli era venuto in odio per quello scherzo che gli aveva fatto la sera avanti. La vecchia tempestò il suo ospite di domande sui gran fatti di Milano; ma Renzo non solo seppe schermirsi dalle domande, ma le chiese come si chiamasse quel paese, piuttosto grosso, sulla strada di Bergamo, vicino al confine, però nello Stato di Milano. La vecchia gli rispose che il paese richiesto non poteva essere che Gorgonzola. Entra nell’osteria di Gorgonzola. – Col nome di Gorgonzola sulle labbra, di paese in paese, vi arrivò un’ora prima di sera, col proposito di farvi un’altra fermatina, per fare un pasto un po’ più sostanzioso e per informarsi della distanza dell’Adda e di qualche traversa che portasse fin là. Fatti alcuni passi, vide un’insegna, entrò; e all’oste, che gli venne incontro, chiese un boccone e una mezzetta di vino: le miglia di più e il tempo gli avevano fatto passare quell’odio così estremo e fanatico. C’erano in quella stanza alcuni sfaccendati, i quali, dopo aver discusse e commentate le grandi notizie di Milano del giorno avanti, si struggevano di sapere un poco come fosse andata anche in quel giorno. Uno di essi si accostò a Renzo e gli domandò se veniva da Milano, ma il giovane rispose asciutto asciutto che veniva da Liscate, cioè da uno dei paesi che aveva attraversato per giungere a Gorgonzola. Quando poi l’oste venne a mettere in tavola, gli domandò quanto distasse l’Adda e quali fossero i luoghi dove poter passare; ma l’oste, dopo avergli detto che il fiume era lontano circa sei miglia, gli ficcò in viso due occhi pieni di una curiosità così maliziosa, che gli fece morire tra i denti le altre domande che aveva preparato. Il mercante di Milano. – Mentre Renzo mangiava e gli avventori discorrevano dei recenti disordini, giunse a cavallo un mercante di Milano, che, andando più volte l’anno a Bergamo per i suoi traffici, era solito passar la notte in quell’osteria. Tutti gli si affollarono intorno, chiedendo notizie di Milano; ed il mercante cominciò a raccontare, con tono di manifesta ostilità contro i rivoltosi, che in quella stessa mattina si era fatto un nuovo tentativo di assalire la casa del vicario (un signore dabbene e puntuale nei pagamenti; ed egli lo poteva dire, che lo serviva di panno per le livree della servitù!), ma il tentativo era fallito per l’intervento dei micheletti; che era stato saccheggiato il forno del Cordusio, e che quei manigoldi vi avrebbero appiccato il fuoco, se un galantuomo del vicinato non avesse messo ad una finestra un Crocifisso, e se non fossero poi arrivati in processione i monsignori del duomo ad ammonire che il pane era a buon mercato e che vi era l’avviso sulle cantonate. Il mercante aggiunse che molti dei più accesi erano stati arrestati e che certamente sarebbero stati impiccati: la giustizia aveva anzi acchiappato uno in un’osteria, che non si sapeva da che parte fosse, né da chi fosse mandato, né che razza di uomo fosse, ma certo uno dei capi, il quale, mentre veniva condotto in carcere, era stato liberato dai suoi compagni, che facevano la ronda intorno all’osteria. Renzo si rimette in cammino. – A questo punto l’oste, che era stato anche lui a sentire, andò verso l’altra cima della tavola, per vedere cosa faceva quel forestiero. Renzo, a cui quel poco mangiare era andato in tanto veleno e gli pareva mille anni d’esser fuori da quella osteria, colse l’occasione, chiamò l’oste con un cenno, gli chiese il conto, lo saldò senza tirare; e, senza fare altri discorsi, andò diritto all’uscio e s’incamminò dalla parte opposta a quella per cui era venuto. Renzo nella notte verso l’Adda. – Le sciagurate parole del mercante avevano accresciuto a Renzo le opposte voglie di correre e di star nascosto. Pensava che chi sa quanti birri erano in campo per dargli la caccia, ma pensava pure che quelli che lo conoscevano erano due soli, e che il nome non lo portava scritto in fronte. Dapprima, sebbene avesse lasciato Gorgonzola che scoccavano le ventiquattro, e le tenebre diminuissero sempre più i pericoli, prese contro voglia la via maestra; ma ben presto, quando vide aprirsi una straducola a mancina, vi entrò. Mentre andava, dialogava nella sua mente col mercante e immaginava di ricacciargli in gola tutte le spudorate invenzioni. Dopo qualche tempo la paura di essere inseguito non gli diede ormai più fastidio, ma quante cose rendevano il viaggio molto più noioso! Le tenebre, la solitudine, la stanchezza, e una brezzolina sottile che non doveva essere affatto piacevole a chi si trovava ancora indosso gli abiti da sposo; e, soprattutto, quell’andare alla ventura, cercando un luogo di riposo e di sicurezza. Quando s’abbatteva a passare per qualche paese, andava adagio adagio, guardando però se ci fosse qualche uscio aperto; ma non vide mai altro segno di gente desta, che qualche lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada fuor dell’abitato, si soffermava ogni tanto, e stava in orecchi per veder se sentiva quella benedetta voce dell’Adda, ma invano. Altre voci non sentiva che un mugolio di cani, che veniva da qualche cascina isolata. L’Adda. – Arrivò finalmente dove la campagna coltivata moriva in una sodaglia sparsa di felci e di scope. Gli parve, se non indizio, almeno un certo quel argomento di fiume vicino, e s’inoltrò per quella, seguendo un sentiero che l’attraversava. A poco a poco si trovò tra macchie più altre, di pruni, di quercioli, di marruche. Andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s’accorse di entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo ad inoltrarvisi, ma lo vinse, e contro voglia andò avanti; ma più che s’inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose; la brezza notturna gli batteva più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote, e penetrava più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza. A un certo punto si fermò sui due piedi a deliberare se proseguire il cammino o tornare indietro per la strada già fatta a cercare un ricovero, anche un’osteria; quando, stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, cominciò a sentire un mormorio d’acqua corrente. Era l’Adda! Fu il ritrovamento d’un amico, d’un fratello, d’un salvatore. E non esitò ad internarsi sempre più nel bosco, dietro all’amico rumore. Arrivò in pochi momenti all’estremità del piano, sull’orlo d’una riva profonda; e guardando in giù tra le macchie, che tutta la rivestivano, vide l’acqua luccicare e correre, e, sull’altra riva, sopra un colle, una gran macchia biancastra, che gli parve dover essere una città, Bergamo sicuramente. Scese un po’ sul pendio, guardò giù se qualche barchetta si muovesse nel fiume, ma non vide né sentì nulla. Renzo dorme in una capanna. – Renzo si mise allora a consultare tra sé, sul partito da prendere, poiché mancavano circa sei ore all’aurora. Gli venne in mente di aver veduto, in uno di quei campi più vicini alla sodaglia, una di quelle capanne coperte di paglia, costruite di tronchi e di rami, dove i contadini del milanese usano l’estate depositare il raccolto. La disegnò subito per suo albergo; ripassò il bosco, le macchie, la sodaglia, e vi entrò. Vide per terra un po’ di paglia, e pensò che anche lì una dormitina sarebbe ben saporita. Prima però di sdraiarsi su quel letto che la Provvidenza gli aveva preparato, vi si inginocchiò a ringraziarla di quel beneficio e di tutta l’assistenza che aveva avuta da essa in quella terribile giornata. Disse poi le sue solite devozioni, e, per di più, chiese perdono a Dio di non averle dette la sera innanzi; anzi, per dir le sue parole, di essere andato a dormire come un cane, e peggio. Appena chiuse gli occhi, cominciò nella sua fantasia una andare a venire di gente, così affollato, così incessante, che addio sonno. Il mercante, il notaio, i birri, lo spadaio, l’oste, Ferrer, il vicario, la brigata dell’osteria, poi don Abbondio, poi don Rodrigo: tutta gente con cui Renzo aveva che dire. Tre sole immagini gli si presentarono non accompagnate da alcuna memoria amara, principalmente una treccia nera ed una barba bianca. Renzo passa l’Adda. – Quando finalmente il martello di un orologio vicino, forse quello di Trezzo, ebbe battuto undici tocchi, cioè erano le cinque, si levò, disse le devozioni del mattino, uscì dalla capanna e prese il sentiero della sera avanti. Il cielo prometteva una bella giornata: quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Renzo giunse sul ciglio della riva, vide una barchetta di pescatore, che veniva adagio, contr’acqua, e diede una voce leggera al pescatore. Questi, dopo aver guardato attentamente in giro, drizzò la prora e approdò presso Renzo, che saltò dentro la barca e pregò l’uomo che lo traghettasse sull’altra sponda. Poi, vedendo sul fondo della barca un altro remo, cominciò anch’egli a remare, mentre si accertava che quella macchia biancastra, che aveva veduto la notte prima, era Bergamo, e che la riva opposta apparteneva alla Repubblica di Venezia. Nella Repubblica di Venezia. – Toccata terra, Renzo scese dalla barca e porse una berlina al pescatore, che, dopo aver dato nuovamente un’occhiata in giro, se la mise in tasca, augurò il buon viaggio e tornò indietro. Il giovane, dopo essersi fermato un momentino a contemplare la riva opposta, rimpiangendo le persone care che era stato costretto a lasciare, s’incamminò verso il paese dove abitava il cugino Bortolo Castagneti. Dal primo viandante, a cui si rivolse, seppe che gli rimanevano ancora nove miglia da fare. Verso il paese del cugino Bortolo. – Quel viaggio non fu lieto, Renzo dovette accorgersi che troverebbe nel paese, in cui s’inoltrava, la penuria che aveva lasciata nel suo. Per tutta la strada incontrava a ogni passo poveri, che non erano poveri di mestiere, e mostravano la miseria più nel viso che nel vestiario. Quella vista, oltre la compassione e la malinconia, lo metteva anche in pensiero dei casi suoi. Entrò in un’osteria a ristorarsi lo stomaco, e pagato che ebbe, gli rimase ancor qualche soldo, che diede in elemosina ad una famigliola, che accattava presso la porta dell’osteria. L’incontro con Bortolo. – Arrivato al paese del cugino, distinse subito una casa alta alta, a più ordini di finestre lunghe lunghe, e, riconoscendo in essa un filatoio, entrò e chiese del cugino Bortolo Castagneti. Questi lo accolse con grandi dimostrazioni di affetto, e, quando apprese da Renzo la sua dolorosa storia, promise di interessarsi presso il padrone affinché, nonostante la scarsità di lavoro, lo assumesse nell’azienda. Il padrone gli voleva bene, perché doveva in gran parte a lui la propria fortuna; ed egli era il primo lavorante, anzi il factotum della filanda. Bortolo raccomandò infine a Renzo di non offendersi se si fosse sentito chiamare baggiano, poiché questo appellativo i bergamaschi, senza intenzione di offesa, chiamavano i milanesi: per essi era come dare dell’illustrissimo a un cavaliere. Il mandato di cattura contro Renzo. – Quello stesso giorno, 13 di novembre, il podestà di Lecco ricevette un dispaccio da Milano, con l’ordine di arrestare un certo giovane, nominato Lorenzo Tramaglino. Il podestà, fatto chiamare il console del villaggio, si fece condurre da lui alla casa del ricercato, con gran treno di notaio e di birri, e poiché la casa era chiusa, fu sfondato l’uscio e fu fatta una diligente perquisizione, cioè si fece come in una città presa d’assalto. La voce di quella spedizione si sparse subito per tutto il contorno e giunse alle orecchie di padre Cristoforo, il quale, attonito non meno che afflitto, domandò al terzo e al quarto, per avere qualche lume intorno alla cagione di un fatto così inaspettato, ma non raccolse altro che congetture in aria, e sperando di ricevere qualche notizia più precisa, scrisse al padre Bonaventura. A poco a poco si venne a sapere che Renzo era scappato dalla giustizia, nel bel mezzo di Milano, e poi scomparso; ma poiché Renzo nel paese era conosciuto per un bravo giovane, i più immaginarono che fosse una macchina mossa da quel prepotente di don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale. Il signorotto, per quanto – come sappiamo – non avesse avuto parte nella sciagura di Renzo, se ne compiacque però come se fosse stata opera sua, e ne trionfò coi suoi fidati, principalmente col conte Attilio. Questi che, secondo i suoi primi disegni, avrebbe già dovuto trovarsi a Milano, quando apprese che la canaglia girava per le strade in tutt’altra attitudine che di ricevere bastonate, aveva creduto bene di trattenersi in campagna; e soltanto quando le cose ripresero il loro corso ordinario, partì immediatamente per la città, animando il cugino a persistere nell’impresa e promettendo che avrebbe cercato di sbrigarlo dal frate. Don Rodrigo apprende dal Griso il rifugio di Lucia. – Appena partito Attilio, arrivò il Griso da Monza e riferì al suo padrone che Lucia era ricoverata nel tal monastero, sotto la protezione della tal signore, e che vi stava sempre nascosta, come se fosse anch’essa una monaca, non mettendo mai piede fuor della porta. Questa relazione mise il diavolo addosso a don Rodrigo, o, per dir meglio, rese più cattivo quello che già ci stava di casa; e infiammò sempre più la sua passione, cioè quel misto di puntiglio, di rabbia e d’infame capriccio, di cui essa era composta. Un monastero di Monza, quand’anche non ci fosse stato una principessa, era un osso troppo duro per i suoi denti; e per quanto egli ronzasse con la fantasia intorno a quel ricovero, non sapeva immaginare né via né verso di espugnarlo, né con la forza, né per insidie. Don Rodrigo pensa di rivolgersi all’Innominato. – Fu quasi per abbandonare l’impresa, ma poi, per non aver la baia dagli amici e dal cugino, e per non darla vinta a un villano e a un frate, gli venne in mente di chiedere l’aiuto di un tale, le cui mani arrivavano spesso dove non arriva la vista degli altri: un uomo o un diavolo, per cui la difficoltà delle imprese era spesso uno stimolo a prenderle sopra di sé. Questo partito aveva i suoi inconvenienti e i suoi rischi, ma don Rodrigo non esitò ad abbracciarlo, quando ricevette una lettera del conte Attilio, che faceva un gran coraggio e minacciava grandi canzonature e quando apprese che padre Cristoforo era partito dal convento di Pescarenico e che Agnese era tornata a casa, lasciando sola Lucia. Ecco la spiegazione di questi due avvenimenti. Lucia e Agnese apprendono la notizia della fuga di Renzo. – Lucia e Agnese si erano appena accomodate- come sappiamo – nel monastero di Monza, quando si sparse la notizia dei disordini di Milano e della fuga di Renzo. Ci si può immaginare come rimanessero la madre e la figlia, finché un giovedì capitò al monastero un pescaiolo di Pescarenico, che andava a Milano, secondo l’ordinario, a spacciar la sua mercanzia, e che era stato incaricato da padre Cristoforo di avvertire le due donne che Renzo si era messo in salvo sul bergamasco. Il buon padre aggiungeva parole di conforto e prometteva che ogni settimana avrebbe fatto loro sapere sue nuove, per quel mezzo o altrimenti. Il secondo giovedì tornò quel pescaiolo coi saluti di padre Cristoforo e con la conferma della fuga felice di Renzo, ma il terzo giovedì non si vide nessuno, ciò che fu per le povere donne cagione d’inquietudine e di cento sospetti molesti. Agnese decide di ritornare al paese. – Allora Agnese, poiché Lucia non correva nessun pericolo in un asilo così guardato e sacro, risolvette di fare una scappata a casa; e il giorno seguente, dopo aver atteso sulla strada il pescaiolo che tornava da Milano, gli chiese per cortesia un posto sul baroccio e si fece trasportare a Pescarenico. Smontò sulla piazzetta del convento, e, giacché era lì, volle, prima di andare a casa, vedere il suo buon padre Cristoforo; ma fra Galdino, quel delle noci, le disse che il padre era stato mandato a Rimini per predicare. Agnese, a tale notizia, si era incamminata verso il suo paesetto desolata e confusa, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone. Attilio dal conte zio. – Ecco come era andata la cosa. Il conte Attilio, appena arrivato a Milano, si era recato, come aveva promesso a don Rodrigo, a far visita al conte zio del Consiglio Segreto, che era una consulta di tredici personaggi, i quali assistevano il Governatore e lo sostituivano in caso di morte. Il conte zio, uno degli anziani del Consiglio, vi godeva un certo credito, ma nel farlo valere, e nel farlo rendere con gli altri, non c’era il suo compagno, come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale, e con su certe parole arabe, e dentro non c’è nulla, ma servono a mantenere il credito alla bottega. Tale credito, che era sempre andato crescendo a lentissimi gradi, aveva fatto ultimamente un passo, come si dice, di gigante, per un viaggio a Madrid con una missione alla corte, dove, per non dir altro, il conte duca l’aveva trattato con una degnazione particolare, a segno d’avergli una volta domandato, in presenza si può dire di mezza corte, come gli piacesse Madrid, e d’avergli un’altra volta dietro a quattr’occhi, nel vano di una finestra, che il duomo di Milano era il tempio più grande che fosse negli stati del re. Il conte Attilio, fatti i suoi complimenti al conte zio, gli raccontò travisati i fatti di don Rodrigo e di padre Cristoforo, dicendo che questi aveva preso a proteggere gelosamente una contadinotta e che s’era cacciato in testa che don Rodrigo avesse dei disegni sulla ragazza, mentre egli aveva divisato di farla sposare a un cattivo soggetto, nientemeno che a quel Lorenzo Tramaglino. Aggiunse che il frate andava dicendo, che ci trovava più gusto a spuntarla con don Rodrigo, perché sapeva che egli era protetto da uno zio di tanta autorità, e che se la rideva dei grandi e dei politici, e che il cordone di san Francesco teneva legate anche le spade. Il conte zio promette di occuparsi della cosa. – Il conte zio, dopo aver preso nota del nome del frate, e dopo essersi lamentato che don Rodrigo avesse lasciato andar le cose tanto avanti senza rivolgersi a lui, promise che si sarebbe occupato della cosa; poi il conte Attilio, dopo aver insinuato che sarebbe stato opportuno pregare, il padre provinciale di far cambiare aria al frate, si congedò con grandi scuse e grandi ringraziamenti. Il conte zio lo salutò con un «e abbiamo giudizio», che era la formula di commiato per i suoi nipoti. Il conte zio e il padre provinciale. – Il conte zio, dopo il colloquio col nipote, comprese che tutto quello che si poteva fare contro padre Cristoforo era di cercar di allontanarlo, e il mezzo a ciò era il padre provinciale, in arbitrio del quale era l’andare o lo stare di quello. Ora, tra il conte zio e il padre provinciale passava una antica conoscenza; s’eran veduti di rado, ma sempre con gran dimostrazioni d’amicizia e con esibizioni sperticate di servizi. Tutto ben ponderato, il conte zio invitò un giorno a pranzo il padre provinciale, e gli fece trovare una corona di commensali assortiti con un intendimento sopraffino. Qualche parente dei più titolati, che col solo contegno riuscivano, anche senza farlo apposta, a imprimere ogni momento l’idea della superiorità e della potenza, e alcuni clienti legati alla casa, che, cominciando dalla minestra a dir di sì, alle frutta avevano ridotto un uomo a non ricordarsi più come si facesse a dir di no. A tavola il conte zio cominciò a parlare del suo famoso viaggio a Madrid, e dei suoi rapporti con la corte, col conte duca, coi ministri, con la famiglia del governatore; ma il padre provinciale, a sua volta, tirò il discorso sul cardinale Barberini, che era cappuccino e fratello, nientemeno, del papa allora sedente, Urbano VIII. Poco dopo, alzati da tavola, il conte zio pregò il padre provinciale di passare con lui in un’altra stanza. Due podestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano a fronte. Il conte zio, dopo un preambolo amichevole, tirò il discorso sul padre Cristoforo, che doveva essere un uomo amico dei contrasti….. e che aveva preso a proteggere un cattivo soggetto, scappato dalle mani della giustizia, quel tale Lorenzo Tramaglino…. Si trattava, insomma, di un affare delicato, per il quale poteva essere fatto dal governo qualche passo a Roma…. Per giunta lo stesso padre s’era messo a cozzare con suo nipote, don Rodrigo, e ne poteva nascere uno scandalo, impegnarsi il puntiglio, l’onore del casato… Il padre provinciale, dal canto suo, tentò difendere padre Cristoforo, dicendo che, se si era interessato per quel soggetto, non aveva potuto farlo che a fin di bene, per ridurre un traviato, e che il passato del padre era una gloria dell’abito, poiché questo lo aveva fatto diventare un tutt’altro uomo, e che egli avrebbe preso informazioni. Ma il conte, che non intendeva questa faccenda delle informazioni, invitò il suo interlocutore, per amor di pace, ad accomodare la cosa: «Sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire». La conclusione fu che il padre provinciale, approfittando dell’occasione che gli veniva chiesto un predicatore da Rimini, pensò bene, in cambio di una vaga dimostrazione di amicizia che don Rodrigo avrebbe fatto per i cappuccini, di spedire padre Cristoforo da Pescarenico a Rimini, che è una bella passeggiata. Una sera arrivò a Pescarenico un cappuccino di Milano, con un plico per il padre guardiano, contenente l’obbedienza per padre Cristoforo. Fu un colpo grave per il nostro frate, che pensò subito a Renzo. Lucia ed Agnese; ma subito si pentì d’aver mancato di fiducia, di essersi creduto necessario a qualche cosa. Chinò la testa, prese la sua sporta col pane del perdono, salutò i confratelli, prese la benedizione del padre guardiano, e s’incamminò per la strada che gli era stata prescritta. L’Innominato. – Intanto don Rodrigo, intestato più che mai di avere nelle sue mani Lucia, si era risoluto – come già è stato accennato – di cercare l’aiuto di un terribile uomo. L’anonimo tace studiosamente il nome di costui, ma il personaggio è storico, e il Ripamonti nella sua Storia Patria ne parla come di un pauroso appaltatore di delitti. Le sue passioni principali erano state, in ogni tempo, fare ciò che era vietato dalle leggi, o impedito da una forza qualunque; esser arbitro e padrone negli affari altrui, senz’altro interesse che il gusto di comandare; esser temuto da tutti; aver la mano da coloro che erano soliti averla dagli altri. Aveva in tal modo commesso, per conto suo o per conto d’altri, tanti delitti, che era stato costretto a uscir dallo Stato; ma era partito a cavallo, con un seguito di cani, a suon di tromba, e, passando davanti al palazzo di corte, aveva lasciato alla guardia un’ambasciata di insolenze per il governatore. Nell’assenza aveva continuato a mantenere relazioni coi suoi amici, i quali – secondo le parole del Ripamonti – rimasero uniti a lui «in lega occulta di consigli atroci e di cose funeste». Finalmente (non si sa per quali ragioni) era ritornato in patria, e si era stabilito in un castello confinante col territorio Bergamasco, che allora era Stato veneto. Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all’intorno, avevano dovuto, chi in un’occasione e chi in un’altra, scegliere tra l’amicizia e l’inimicizia di quel tiranno straordinario. Ma chi aveva scelto l’inimicizia, si era ben presto pentito. Don Rodrigo e l’Innominato. – Anche don Rodrigo, il cui palazzotto distava dal castello dell’Innominato non più di sette miglia, aveva dovuto comprendere che, a così poca distanza da un tal personaggio, non era possibile fare il tiranno senza venire alle prese o andar d’accordo con lui. Perciò gli si era offerto e gli era divenuto amico, gli aveva reso più di un servizio (il manoscritto non dice di più), e ne aveva riportate ogni volta promesse di contraccambio e di aiuto, in qualunque occasione. Metteva però molta cura a nascondere una tale amicizia, perché voleva bensì fare il tiranno, ma non il tiranno selvatico: voleva dimorare liberamente in città; godere i comodi, gli spassi, gli onori della vita civile; e perciò bisognava che usasse certi riguardi, tenesse di conto parenti, coltivasse l’amicizia di persone alte, avesse una mano sulle bilance della giustizia, per farle a un bisogno traboccare dalla sua parte, o per farle sparire, o darle anche, in qualche occasione, sulla testa di qualcheduno. Una mattina don Rodrigo uscì a cavallo, in tenuta da caccia, con una piccola scorta di bravi a piedi; il Griso alla staffa e quattro altri in coda, e s’avviò al castello dell’Innominato. |
|
| Le divisioni utilizzate sono quelle dei riassunti Bignami
Scritto con la partecipazione eccezionale di Mariantonietta |
|