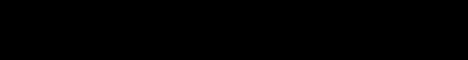
DUOMO
Austero edificio romanico e simbolo della città, è situato nel cuore del centro
storico, costeggiato dal Battistero e dal Palazzo del Vescovado. Iniziato
nell’XI sec. per ordine di Papa Onorio II, fu completato fra il 1130 e il 1178.
La facciata presenta una costruzione in pietra arenaria arricchita di tre
ordini di loggette e un portale centrale con protiro, opera di Giambono da
Bissone. A destra dell’edificio si eleva un campanile gotico del 1294.
L’interno, ha una forma a croce latina ed è suddiviso in tre navate con
pilastri cruciformi ed eleganti capitelli. Di particolare rilievo, sono gli
affreschi che rivestono le pareti e le volte delle navate, frutto di artisti di
scuola padana-lombarda (Orazio Samacchini, Bernardino Gatti, Lattanzio
Gambara). Nel soffitto della cupola è ammirabile, invece, il capolavoro del
Correggio (1526-30), rappresentazione fantastica dell’Assunzione della Vergine.
Si segnalano, inoltre, le prestigiose sculture medievali di Benedetto Antelami:
nell’abside spicca la famosa cattedra episcopale(1180), mentre nel transetto
destro è visitabile lo splendido rilievo raffigurante la Deposizione dalla
Croce (1180). Notevole è il coro intarsiato di Cristoforo da Lendinara (1473).
Sotto il presbiterio è collocata la vasta cripta con colonne in marmo e
pavimenti a mosaico del V-VI secolo.
S. GIOVANNI EVANGELISTA
Situata dietro il Duomo, fu costruita nei secoli XV e XVI su progetto di
Bernardino Zaccagni. L’esterno presenta una bella facciata in marmo, ideata da
Simone Moschino (1607) e uno slanciato campanile di epoca barocca. L’interno, a
croce latina e suddiviso in tre navate, è di particolare interesse per i
numerosi affreschi conservati, tutti opere del Correggio e del Parmigianino. Di
quest’ultimo, si segnalano le numerose figure di Santi nelle cappelle della
navata sinistra. Del Correggio, invece, sono gli affreschi della cupola, fra
cui il Transito di S. Giovanni, quelli della navata centrale, e il prezioso
Giovanni Evangelista che scrive l’Apocalisse nella lunetta della porta della sagrestia.
A fianco della chiesa è possibile visitare il monastero benedettino e la
storica Farmacia di S. Giovanni Evangelista. Fondata nel 1201 e funzionante
fino al 1766, è l’antica farmacia dei monaci benedettini. Di particolare
interesse, sono le tre sale adorne di affreschi cinquecenteschi e preziosi
arredi, tra cui splendidi vasi di ceramica, alambicchi e mortai dell’epoca.
![]()
PINACOTECA STUARD
Situata di fronte all’Università, raccoglie una preziosa collezione di dipinti,
donata nel 1834 da Giuseppe Stuard alla Congregazione di carità di S. Filippo
Neri. Sono conservate importanti opere di scuola toscana ed emiliana dal XIV al
XIX secolo.
![]()
MADONNA DELLA
STECCATA
Situata in Strada Garibaldi, a pochi passi dal Duomo, la chiesa fu costruita
tra il 1521 e il 1539 su progetto di Bernardino e Giovan Francesco Zaccagni.
Elegante edificio in stile rinascimentale a croce greca, è coronato da una
grande cupola centrale ed arricchito di tre absidi semicircolari. L’interno è
impreziosito di splendidi affreschi, tra cui si segnalano nel presbiterio i
capolavori del Parmigianino (1530-39) con motivi e figure simboliche, nella
cupola la preziosa Assunzione della Vergine di Bernardino Gatti (1560-72), ed
infine, nel catino dell’abside l’Incoronazione della Vergine di Michelangelo
Anselmi. Nei sotterranei della chiesa sono conservate le tombe dei duchi della
famiglia Farnese.
![]()
MUSEO GLAUCO LOMBARDI
Situato in strada Garibaldi, in prossimità del neoclassico Teatro Regio, il
museo raccoglie oggetti e cimeli di proprietà della duchessa Maria Luigia
d’Austria e dell’Imperatore Napoleone. Di particolare interesse, è la visita
alla sala che ospita dipinti di artisti francesi che lavorarono alla corte
parmense nei secoli XVIII e XIX, tra cui Jean Marc Nattier, François Gérard, e
Jean-Honoré Fragonard.
![]()
MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
Fondato da Filippo I di Borbone nel 1760, il museo ospita importanti resti
preistorici e di epoca romana provenienti dall’Italia settentrionale. Tra le
opere conservate, si segnalano preziosi oggetti di arte greca, etrusca e una
rara collezione egiziana. Di particolare interesse, sono le statue
dell’originaria basilica romana di Velleia, la prestigiosa iscrizione in
bronzo, “tabula alimentaria”, della stessa epoca, una testa di giovinetta in
bronzo del sec. I a.C. e la famosa tavola della “lex de Gallia Cisalpina”.
![]()
GALLERIA NAZIONALE
Allestita al piano superiore del palazzo, fu fondata nel 1822 dalla duchessa
Maria Luigia d’Austria ed ospita importanti dipinti di scuola emiliana e
parmense dal XV al XVIII secolo. Di particolare rilievo, si segnala la sala
dedicata alla pittura toscana con opere di Agnolo Gaddi e di Cima da
Conegliano, oltre alla famosa Madonna dell’Umiltà del Beato Angelico e la tela
di Leonardo da Vinci, raffigurante una splendida testa di fanciulla. La sezione
dedicata alla pittura cinquecentesca presenta l’elegante ritratto di Clemente
VII, opera di Sebastiano del Piombo e quello di Erasmo da Rotterdam di Hans
Holbein il Giovane. Nelle restanti sale sono allestite alcune opere di scuola fiamminga,
fra cui spicca una Madonna col Bambino e il ritratto di Isabella di Spagna del
pittore Antoine van Dyck, oltre a dipinti di artisti del Settecento veneto,
quali il Tiepolo, Canaletto e Ilario Spolverini. Infine, nella galleria che
conduce al Teatro Farnese si possono ammirare i magnifici affreschi del
Correggio, raffiguranti la Vergine in diverse scene: la Madonna della Scodella,
la Madonna della Scala e la Madonna di S. Girolamo. Opera del Parmigianino è la
celebre Schiava Turca ed altri dipinti, tra cui un autoritratto. La visita alla
Galleria si conclude con la sala delle Specole, dove sono collocati numerosi
quadri e famose statue di scuola francese e parmense del ‘700. Tra queste,
spicca la sontuosa statua di Maria Luigia di Antonio Canova.
BIBLIOTECA PALATINA
Allestita nei locali del palazzo della Pilotta, è una delle maggiori d’Italia e
raccoglie numerosi manoscritti, incisioni e stampe del IX-X sec., oltre a
preziosi codici miniati.
![]()
CAMERA DI S. PAOLO
Di fronte al Palazzo della Pilotta, si erge il bellissimo monumento
cinquecentesco che ospitava, anticamente, il tinello e la camera
dell’appartamento della badessa del monastero di S. Paolo. Di particolare
rilievo, è la camera affrescata dal Correggio (1519) con uno splendido soffitto
a volte, dove compaiono figure mitologiche ed allegoriche, raffiguranti scene
di caccia, e paesaggi di boschi e foreste.
![]()
PALAZZO DUCALE
Oltrepassato il torrente Parma, nella parte settentrionale della città,
incontriamo il vastissimo parco ducale sistemato “all’italiana” con una gran
varietà di alberi e piante e adorno di sculture degli artisti francesi
Jean-Baptiste Boudard e Ennemond Petitot (sec. XVIII). Sul lato destro si erge
il Palazzo Ducale, fatto costruire da Ottavio Farnese (1564) su progetto del
Vignola e modificato nel 1767 dall’architetto Petitot. All’interno si possono
ammirare affreschi di Girolamo Mirola e Agostino Carracci di gusto
rinascimentale.
PALAZZO VESCOVILE
Iniziata la costruzione nel secolo XI dall'antipapa Cadalo (Onorio II) quand'era vescovo di Parma. Fu ingrandito e restaurato in variperiodi fino a che nel 1232 il Vescovo Grazia non ne fece rifare completamente la facciata.
Dal 1553 al 1568 il Vescovado fu la prima residenza in città del duca Ottavio Farnese. Dal 1922 al 1930 sotto il vescovo Guido Maria Conforti la facciata f riportata all'antico aspetto duecentesco con il ripristino delle grandi trifoe, delle colonne del piano terra e delle logge del cortile murate nel secolo XVII.
Fra il 1957 e il 1959 sotto il Vescovo Evasio Colli fu restituito alle sue forme rinascimantali l'elegante cortile interno
OSPEDALE VECCHIO ----vedi approfondimento
Fondato nel 1201
in borgo Taschieri dal cavaliere Rodolfo Tanzi (m. 1216), meritò più di ogni
altra opera pia cittadina di essere sostenuto dal popolo a dai vescovi.
Rinvigorito per l'annessione di 59 minori istituti (ospedali, ospizi, oratori
della città e contado) accordata da Sisto IV in data 4 dicembre 1471, nel 1477
cominciò a costruirsi una nuova sede, per la quale si ricorse all'opera degli
architetti Gian Antonio da Erba, Gaspare Fatulli e Bernardino Zaccagni, allo
scultore Antonio Ferrari d'Agrate. Il nuovo Ospedale detto della Misericordia,
ebbe fine verso il 1512. Arricchito di privilegi spirituali da Giulio II,
Clemente VII e Paolo III, venne ben sostenuto da lasciti e oblazioni. Godette
il favore dei duchi e specialmente di Filippo di Borbone, che nel 1766 ne volle
l'ampliamento. Per decreto del generale Junot in data 7 marzo 1806 l'Ospedale e
le altre annese opere pie dovettero confluire in una sola amministrazione sotto
la comune denominazione di Ospizi Civili.
Nel 1843, infine, la duchessa Maria Luigia affidò all'architetto Nicola Bettoli (autore del Teatro Regio) la trasformazione del lato occidentale destinato ad ospitare le suore Vincenzine addette all'ospedale come testimonia una grande scritta sulla facciata.
Nonostante i precedenti ampliamenti, sull'inizio del secolo XIX l'Ospedale si manifestò ancora troppo piccolo. Il 6 marzo 1915 si approvava perciò il progetto di una nuova sede, la quale fu costruita poco dopo la porta S. Croce nei prati di Valera e inaugurata il 23 agosto 1926. Fin dal 22 marzo 1202 l'ospedale ebbe dai canonici della Chiesa parmense un proprio oratorio detto di S. Ilario.
Attualmente sede di numerosi Istituzioni Culturali fra cui l' Archivio di Stato, l'Archivio Storico Comunale, la Biblioteca Civica, la Biblioteca `A.Bizzozero' e l' Emeroteca Comunale.
UNIVERSITA’
Imponente costruzione seicentesca, già sede del Collegio Gesuitico, attigua
alla bella chiesa di S.Rocco, fu destinata all'Università (una delle più antiche
d'Italia) nel 1768 allorché i Gesuiti furono cacciati dal Ducato.
Solenni il grande atrio dalle volte a crociera sorrette da colonne a bugnato e le aule Magna e dei Filosofi adorne di stalli originali.
Costruito nel 1627 su progetto di Gian Battista Magnani e inaugurato
incompiuto nel 1628 per le nozze di Odoardo Farnese con Margherita De' Medici.
Il severo edificio sorge sulle rovine dell’ antico palazzo comunale del XIII secolo distrutto dalla caduta (nel 1606) della torre civica alta 130 metri.
Nel grande atrio e nelle sale di rappresentanza troviamo importanti tele di
soggetto storico di Ilario Spolverini e una crocifissione di Bernardino
Gatti; mentre l'aula consiliare è stata decorata da Girolamo Magnani (scenografo
prediletto da Verdi ) e da Cecrope Barilli.
IL PALAZZO DEL GOVERNATORE
Già sede del Capitano del Popolo alla fine del XII secolo, subì vari
rifacimenti fino all'attuale aspetto nel 1760 ad opera di Ennemond
Petitot, l'architetto francese alla corte di Filippo di Borbone
cui si deve gran parte dell'urbanistica settecentesca della città.
La torre barocca è del 1673 e nella cella campanaria viene conservata la campana dell'altissima torre civica crollata nel 1606.
La Vergine incoronata nella nicchia del campanile è opera dello scultore francese j.B.Boudard. interessanti le due meridiane a tempo vero e medio risalenti al 1829.
Voluto da Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza, quale luogo per gli svaghi di corte, il grande giardino a Ovest del torrente che attraversa la città di Parma nacque alla metà del XVI secolo dall'unione di diverse aree ortive e appezzamenti privati.
Ma l'attuale struttura del Giardino è dovuta a Filippo II di Borbone, che a metà del Settecento ne affidò il rifacimento all'architetto francese Ennemond Alexandre Petitot, latore del raffinatissimo gusto di transizione tra rocaille e neoclassicismo. Ispirandosi ai trattati di giardinaggio francese tra Sei e Settecento, egli ne caratterizzò il disegno attraverso rigorose geometrie.
La tipologia alla francese è oggi chiaramente leggibile, dopo l'importante restauro terminato nel 2001, che ha ripristinato la corretta pavimentazione e ridefinito gli spazi verdi.
L'ingresso principale immette nella grande étoile, delineata da maestosi platani risalenti all'epoca della Duchessa Maria Luigia (1820): da essa si diparte il viale centrale del Giardino, fiancheggiato da ippocastani, che ha come sfondo la suggestiva peschiera. Le siepi di carpini bianchi ed aceri, che circondano i boschetti, sono ritmate da palissades di tigli tra cui si aprivano finestre ritagliate ad arco dai giardinieri. Il giardino è impreziosito da dodici statue rappresentanti divinità mitologiche e cinque vasi monumentali in marmo bianco di Carrara, opera dello scultore di corte di Jean-Baptiste Boudard (1710-1768).
Il Parco racchiude edifici di pregio: il Palazzo Ducale, di origine cinquecentesca, completamente riformato nel '700 secondo linee classicheggianti, è decorato con importanti cicli pittorici e spettacolari volte a stucchi; il Palazzetto Sanvitale conserva invece la mirabile armonia della struttura tardo quattrocentesca, dalle perfette simmetrie e gli ariosi loggiati; il settecentesco Tempietto eretto in forma di rovina è immerso in uno dei suggestivi boschetti del Giardino a ricordare le rappresentazioni arcadiche che vi avevano luogo.
L'area è dominata dal complesso farnesiano del Palazzo della Pilotta, articolato reticolo di cortili, circondati da altissimi corpi traforati da portici pilastrati alle basi. La stessa Pilotta sembra incompiuta, poiché essa si appoggiava sull'abside della Chiesa domenicana di S. Pietro Martire, sede dell'Inquisizione, che si inseriva nell'angolo mancante del complesso come testimoniano anche dei pilastri tardogotici tuttora incorporati nelle strutture murarie del suddetto complesso.
La chiesa domenicana fu abbattuta dopo le requisizioni napoleoniche del 1805.
L'aspetto attuale della piazza, animato centro della vita cittadina, è il risultato di successive fasi di formazione, che videro disporsi in questo spazio le principali sedi del potere comunale.
Nel 1221 il Palazzo Vecchio ne definì il lato meridionale, mentre nel 1282-85 la costruzione del palazzo dei Mercanti (ora palazzo del Governatore) portò ad un ampliamento della piazza verso settentrione, consentendole di assumere la forma attuale. Altre grandi trasformazioni furono attuate nel secolo XIV, quando il luogo fu racchiuso entro una fortezza di torri e porte; nel 1606 il crollo della torre e la ridefinizione del palazzo del Comune anticiparono la sistemazione del lato settentrionale.
Infine le alterazioni novecentesche lungo il lato ovest hanno aumentato il carattere disomogeneo della piazza dandone la forma attuale.
Ph: © Franco Furoncoli Fotografo
PALAZZO DEL COMUNE Portici del Grano
 Il massiccio edificio in laterizi, alleggerito da una loggia al piano terreno,
Il massiccio edificio in laterizi, alleggerito da una loggia al piano terreno,
occupa il lato sud orientale di Piazza Garibaldi.
Disegnato dall architetto Magnani nel 1623 fu completato nel 1673 e ricorda nel motivo il Palazzo Farnese di Piacenza.
Fanno parte del complesso municipale altri edifici d'origine medievale: palazzo del Capitano del Popolo e Palazzo dei Notai.
Ph: © Carra Fotografo
Palazzo Eucherio Sanvitale vedi approfondimento
Palazzo Pigorini
Poco si conosce dell'assetto originario di Palazzo Pigorini . L'Atlante Sardi (1767) ne documenta l'impianto architettonico che poco si discosta dall'attuale, ma si può supporre che l'edificio abbia origini ben più antiche. Certamente in passato comprendeva anche lo stabile del Palazzo delle Poste. Ma prima di diventare sede dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e spazio espositivo per le mostre del Comune, la sua fama era legata al fatto di aver dato i natali (onde lapide sulla facciata che lo ricorda) al poeta Angelo Mazza e all'esploratore Vittorio Bottego.
Nel 1855 il pittore sissese Francesco Scaramuzza dipinse in una sala, tuttora conservati, affreschi con La Notte , L'Apoteosi del poete e medaglioni con ritratti di poeti.
Nei primi decenni del Novecento dopo varie compravendite, il Palazzo divenne di proprietà di Adriana Pigorini Lusignani, figlia del celeberrimo padre dell'archeologia preistorica italiana, che nel 1980 con lascito testamentario lo donò al Comune di Parma affinché fosse destinato a " Museo artistico o destinazione similare da denominare Pigorini ". Per adattare l'edificio alle nuove funzioni museali, il Comune di Parma ha effettuato un accurato intervento di recupero e restaurodiretto di Maurizio Bocchi . Sono stati realizzati impianti di sicurezza, l'installazione di un ascensore e parziali modifiche alle quote di pavimento con scivoli che rendono Palazzo Pigorini accessibile a tutti.
La Certosa di Parma
Fondata nel 1225 per volontà del Vescovo di Spoleto, Rolando Taverna, divenne così parte dell'ordine monastico dei Certosini, i quali vi abitarono per circa 500 anni. Nulla è rimasto dell'antico complesso religioso, infatti, gli interventi di restauro e di ampliamento, i periodi di abbandono e le successive trasformazioni, hanno profondamente modificato le architetture cancellandone le linee originarie. La Certosa ospito nel corso degli anni diverse strutture: la Manifattura Tabacchi, un istituto di rieducazione e dal 1975 ad oggi è adibita a scuola di Agenti di Custodia.
Home Personaggi
Monumentii Castelli Leggende