Le intercettazioni telefoniche
I politici e Fiorani: «Sono l’onorevole, a sua disposizione»
|
Paolo Biondani e Mario Gerevini su “Corriere.it” danno un quadro delle intecettazioni telefoniche dei colloqui di Gianpiero Fiorani con i politici. Ecco alcuni brani del servizio sul sito telematico del Corriere della Sera. In primo piano alcuni esponenti di AN e della Lega.
«Dottor Fiorani sono l’onorevole Ascierto e sono a disposizione». C’è bisogno di un’interrogazione parlamentare? Oplà. C’è da fare una durissima dichiarazione contro la Consob, rea di ostacolare la marcia impetuosa della Popolare Lodi verso l’Antonveneta? Ecco un altro deputato disposto a dettare alle agenzie la sua indignazione. C’è da appoggiare la Lodi all’assemblea Antonveneta? Uno dei più importanti imprenditori veneti si mette a disposizione anche per fare «da segnalibro». Siamo in luglio e quando il telefonino di Gianpiero Fiorani non squilla per Emilio Gnutti o Giovanni Consorte, quando si esce, ma non troppo, dalle ormai note conversazioni e vicende su scalate e concerti, ecco che emerge il mondo delle intercettazioni «a latere». Sono inedite e hanno il valore aggiunto di completare il quadro, per esempio con un’interessante conversazione tra Fiorani e il presidente dell’Abi Maurizio Sella. Perfino una suora chiama Fiorani sul telefonino. Va ricordato che allora nulla si sapeva dei traffici illeciti di Fiorani.
Interrogazione a gettone - Alcuni personaggi politici, non ancora noti come sponsor della scalata Antonveneta, spuntano tra i sostenitori del banchiere di Lodi e della sua causa. Il 28 giugno l’allora amministratore delegato della Bpi chiede alla segretaria di chiamargli l’onorevole Armani. Si tratta di Pietro Armani, esponente di Alleanza Nazionale e presidente della Commissione ambiente della Camera. Fiorani, è scritto nei brogliacci riassuntivi delle telefonate, racconta «del fatto che la Consob e Cardia (presidente Consob, ndr) non hanno dato certezze sull’Opas e sono pronti a un ricorso al Tar». Armani dà ragione al banchiere e dice di essere «pronto a fare una dichiarazione contro la Consob ... che si schiererebbe con l’Abn Amro». Ci saranno successivamente altre telefonate con Armani e anche incontri a quattr’occhi. Il parlamentare di An è un membro, coerente, del cosiddetto partito dei «fazisti», cioè dei sostenitori del governatore (ormai ex). A fine luglio, quando viene stoppata la scalata di Bpi con il sequestro delle azioni Antonveneta e scoppia il caso delle intercettazioni (l’ormai celebre «Tonino ti bacerei in fronte »), Armani attacca le Procure che hanno aperto le inchieste penali.
«Se mi chiama sono pronto» - Vicino a Fazio, ma con posizioni più equilibrate, era considerato anche Riccardo Pedrizzi, stessa parrocchia di Armani (An), presidente della Commissione finanze del Senato. Il figlio Giuseppe, noto avvocato, è un apprezzatissimo consigliere di amministrazione della Bipielle Investimenti, quotata in Borsa, e di altre importanti società del gruppo Lodi. Nonché amministratore della holding di Paolo Berlusconi, che ha come banca di riferimento proprio la Lodi. Restiamo in An e trascriviamo dai brogliacci un sms dell’onorevole Filippo Ascierto: «Dottor Fiorani sono l’on Ascierto. Il mio amico Paolo Sinigaglia mi ha parlato delle difficoltà di Antonveneta se mi chiama io sono pronto con un gruppo di parlamentari per un’interrogazione. Comunque sono a disposizione ».
Alberto Brambilla della Lega è un altro degli interlocutori di Fiorani. L’ex numero uno della Lodi lo cerca spesso ma non vi sono telefonate trascritte o in sintesi. Brambilla, sottosegretario al Welfare, è tuttora (doveva uscire mesi fa) nel consiglio di Euronord Holding, cioè l’ex Credieuronord, disastrata banca della Lega acquistata dalla Lodi (ma il contratto potrebbe essere invalidato). Il 15 luglio, dieci giorni prima di un’assemblea Antonveneta, l’imprenditore veneto Paolo Sinigaglia, socio e grande cliente della Bpi, scrive questo messaggio a Fiorani: «Carissimo in rif ass25 se necessita mia pres posso assicurarla modificando mia partenza ti vorrei comunque ribadire mia disponibilità a fare unicamente da segnalibro comprendendo tue necessità».
Due settimane prima, l’1 luglio, il segretario di Fiorani gli passa al telefono Maurizio Sella, presidente dell’Associazione bancaria (Abi). «Discutono sul fatto—riassume il finanziere di turno all’intercettazione — che gli olandesi fanno critiche quando le cose vanno male e viceversa e questo è un comportamento poco normale.
Discutono sul fatto che fanno male perché ciò non porta a nulla. Maurizio (Sella, ndr) dice che forse è il loro consulente che li consiglia male. Maurizio detta il portatile di Giuseppe Gallo a Fiorani e dice che lo ha chiamato e gli ha detto che ha inviato a Fiorani in maniera riservatissima e personale presso Bpi il documento che lo stesso Gallo ha redatto per arrivare a un’intesa. Maurizio dice che gli ha dato il numero in modo che possano parlarsi direttamente e capirsi. Gallo ha detto a Maurizio che se è possibile vuole arrivare a martedì (data di un incontro) con un accordo fatto. Gallo — annota la Gdf — dovrebbe essere un sindacalista». GiuseppeGallo è il segretario nazionale della Fiba-Cisl, il sindacato dei bancari. Sella ha annunciato mercoledì scorso che Bpi sarà sospesa dall’Abi e che l’associazione si costituirà parte civile.
Livolsi e il caso Cit - Il 22 luglio c’è un curioso teatrino. Alle 16.16 la segretaria dice a Fiorani che ha in linea «la segretaria di Sinigaglia per dei problemi con Letta», Fiorani risponde ma dall’altra parte l’interlocutore è «Aldo per il problema Cit» (il gruppo turistico sull’orlo del collasso). Aldo è Livolsi, il banchiere che tenta di salvare il gruppo, con sponda a Palazzo Chigi dove della faccenda si occupa Gianni Letta. Massimi livelli, quindi. Eppure «Fiorani dice che la loro banca non può deliberare una cosa del genere ... è una proposta irricevibile ....». Chiusa la telefonata, Fiorani chiama la segretaria e «dice che la telefonata precedente era Livolsi, lo hanno preso in giro ... e se dovesse richiamare Livolsi o il dottor Letta dire che non è raggiungibile fino a lunedì».

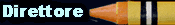
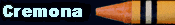

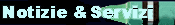
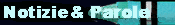
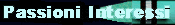
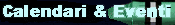
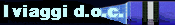

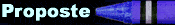
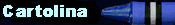


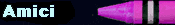


 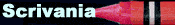

In "Navigare" orari aerei e ferroviari, notizie interne ed estere, meteo e tanti altri indirizzi per vivere meglio
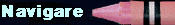 
 | 
| 
Perché sì all’autarchia europea
di Maurizio Blondet
(Fonte:effedieffe.com)
«Gli operai avevano orgoglio e dignità perché sapevano, ed erano sicuri di quel che sapevano; avevano il mitra sotto il letto, ma l’invidia sociale aveva poco spazio nelle loro anime».
Una bella intervista di Massimo Fini su La Padania che non voglio lasciar cadere. La tesi di Fini (che condivido) è che «Putin può salvarci dall’America». Che l’Europa ha interesse a integrare la Russia, cristiano-europea (specie ora, dice, che ha perso tante aree asiatiche dell’impero sovietico) piuttosto della Turchia che «essendo la longa manus degli Stati Uniti» ci porterà «alla paralisi politica e militare». Poi delinea il suo sogno dell’Europa: «un continente unito, neutrale, armato e nucleare». Io aggiungo anche autarchico, ma è una mio opzione soggettiva. Intuisco la precauzione; ma aggiungo che è una «opzione soggettiva» a cui aderisco di tutto cuore.
Il regime economico planetario in cui viviamo - la globalizzazione - è l’anti-autarchia. Infatti i suoi ideologi anglo-americani la chiamano anche «interdipendenza» e ne fanno discendere che la necessità di «dipendere» da altri Paesi per merci e materie prime, favorirebbe «la pace»! E’ una menzogna, come dimostra l’aggressività militare neo-americana. Ma non è questo il punto più urgente.
Il punto è che la globalizzazione liberista (libera circolazione di merci, uomini e soprattutto capitali) nasce dalla cultura anglo-imperiale e in qualche modo è consona al particolare individualismo anglosassone.
Per l’Europa continentale, essa determina un clima estraneo, in cui saremo i perdenti perché non aderiamo fino in fondo alle sue spietate durezze. Per noi, la globalizzazione non significa semplicemente la perdita di posti di lavoro verso l’Asia, di quote di mercato, o il deficit crescente della bilancia commerciale. Significa qualcosa di peggiore: la perdita di competenze, conoscenze tecniche e professionali plurime e varie, che arricchivano e diversificavano e la rendevano articolata in un modo «europeo» che gli americani non conoscono.
Non solo perdiamo a favore dell’Asia posti di lavoro; perdiamo la capacità di fabbricare, la serietà, l’orgoglio e la disciplina di una classe operaia, la diffusione di conoscenze tecniche pratiche necessarie. Carlo Emilio Gadda, che era ingegnere, ha raccontato quanto ha imparato dai suoi operai metallurgici lombardi; ed è certo che gli operai imparavano in fabbrica ogni giorno dagli ingegneri. Questa vicinanza di ceti che nasceva nelle fabbriche valeva più di qualunque profitto economico finanziario: ai superiori insegnava la responsabilità verso «i loro uomini», ai proletari il rispetto naturale per chi ha diritto di comandare in quanto sa.
Non a caso il Politecnico di Milano sfornava un tipo speciale, e ammirevole, di personalità civili. All’ingegnere si insegnava il calcolo preciso dei materiali per costruire un ponte col minimo di cemento - la teoria - e poi gli si diceva: moltiplicate il cemento per 2 o per 4, perché sul ponte passano uomini e automezzi. Insieme alla matematica, alla fisica e alla tecnologia necessaria, all’ingegnere si insegnava ad essere responsabile dei suoi uomini: e in questo consisteva l’attitudine vera al comando.
Certi operai della Breda parlavano del loro ingegnere come «un tipo che si mette la cintura e anche le bretelle», prudente e capace di decisioni: l’obbedienza veniva spontanea e anche allegra. Gli operai della Breda erano stalinisti e avevano il mitra sotto il letto nel caso che il Partito chiamasse alla rivoluzione; ma l’invidia sociale aveva poco spazio nelle loro anime.
Durante la repubblica di Salò, ingegneri SS presero la guida delle fabbriche milanesi; rimasero stupefatti dall’orgoglioso puntiglio degli operai dell’Alfa Romeo messi a fabbricare motori per caccia Messerschmitt; invano cercavano di convincere gli operai che, siccome un aereo tedesco ormai restava in volo in media un’ora prima di essere abbattuto, era inutile provarli al banco per 100 ore di volo. Quelli volevano fare motori «seri». Le SS ingegneri scrivevano a Berlino: questi saranno anche tutti comunisti, ma producono come nella Ruhr.
Gli operai avevano orgoglio e dignità perché sapevano, ed erano sicuri di quel che sapevano. Di tutto questo ci ha privato la globalizzazione. L’Italia fabbricava aerei, televisori, elettronica, alta tecnologia; ora li compra. Perde competenze tecniche; ogni giorno ne perde qualcuna in qualche settore. Bastano due o tre anni, e queste competenze tecniche sono perdute per sempre. In breve, non si trova nessuno che sappia più come fare quella merce, quel prodotto industriale, quella macchina utensile, quella mescola di gomme o quel prodotto chimico. In questo modo, è la qualità umana dell’intera società che s’impoverisce.
E’ il tessuto civile e sociale che si sfilaccia. E’ il senso di responsabilità che si perde, insieme con la serietà e l’applicazione. La società si «semplifica» allo stesso modo in cui un frutteto fertile «si semplifica» diventando deserto, e l’humus mineralizzandosi. La società americana è già questo deserto semplificato. Pochi miliardari di successo, e l’immensa maggioranza di «poveri pur lavorando» (working poors), praticamente tutti servitori impiegati nel «terziario», che sono appunto i «servizi», portinai, camerieri, sorveglianti. Due mondi separati, che non lavorano più gomito a gomito in nessuna fabbrica. Privi di solidarietà reciproca.
In USA si vedono ancora i lustrascarpe anche in alberghi di lusso, fatto che in Europa susciterebbe repulsione sociale (almeno spero). Sempre più spesso, i super-ricchi vanno a vivere in «comunità chiuse», closet communities di lusso, che sono città condominiali circondate da muri e con vigilanza privata armata. Il ceto medio è microscopico, e decresce ogni giorno.
Non si corra a un giudizio univocamente negativo: questa separatezza che nasce dallo specifico individualismo anglosassone, la perseguono volontariamente. A loro piace essere isolati. Da noi, chiunque possa permetterselo vuole vivere nel centro delle città vicino a tutti gli incontri sociali possibili; loro, se possono, vanno a vivere fuori, nei suburbia verdeggianti che per noi sono cimiteri di lusso. Per questo hanno persino un termine che noi ignoriamo, «gentrification», da «gentry» allusione velleitaria alla piccola nobiltà campagnola inglese. La globalizzazione ha acuito tutto questo, e in qualche modo (fino a un certo segno) loro ci stanno bene, o non sanno di starci male. Ma per noi è la morte della civiltà diversificata e articolata che ci ha nutrito.
Sere fa, in un ristorante milanese, avevamo vicina una tavolata di giovani. I giovani italiani d’oggi: la vacuità delle loro facce, risate e discorsi rifletteva vite a cui nessuno aveva posto esigenze, studi, sforzo di riflessione, seria preparazione professionale. Tanto, a che serve ormai prepararsi?
Quella tavolata di giovani, tutta la sera, ha parlato essenzialmente della stessa cosa: dei loro telefonini ultimo modello. Telefonini che non sono loro a fabbricare, che non sanno come funzionino «dentro» e di cui nemmeno sospettano la «serietà» tecnica. A loro basta comprarli e metterseli al collo, come il boscimano si metteva al collo la sveglia. Sono anche ben forniti di denaro, per ora. Si sarà notato come ormai tutte le merci che piacciono ai giovani italiani, i prodotti che desiderano, tutti i simboli di status di cui si abbigliano e si forniscono, non sono fatti in Italia.
Non solo i telefonini, gli schermi piatti, gli Ipod, ma anche le scarpe e il vestiario: non le belle scarpe di pelle italiane ma le orrende pedule con marchio americano Made in China, non le eleganti lane e lini di buon taglio, ma le felpacce che subito puzzano, con i soliti marchi da grande magazzino. Urta, carattere comune di queste cose, la loro dozzinalità; rattrista in quei giovani la perdita del gusto e delle sue finezze e complessità. Con questa generazione, anche il made in Italy non ha futuro.
Al nostro tavolo, un giovane matematico che sta seguendo un corso di dottorato a Yale, tornato per Natale. Ci diceva quanto «soffra» la vita americana, l’assenza di conversazione amicale che non sia la discussione scientifica coi professori, la ripugnanza dei party studenteschi che si riducono a ubriachezza, a monosillabi e a rissa.
Ma naturalmente non c’è posto in Italia per questo giovane. Il solo posto che aveva trovato era quello di attuario in una compagnia d’assicurazione; poi ha vinto una borsa di studio americana, dove i professori lo trattano da pari a pari. E i suoi vecchi professori italiani oggi, servili, gli scrivono che metta una buona parola perché vogliono invitare a tenere conferenze e lezioni i suoi professori americani di oggi, tutti Nobel o vicini ad esso, tutti primissimi, avanguardia assoluta, di assoluta fama mondiale nella loro specialità. Ma in Italia non ci sono posti ai «piani alti» della cultura e della scienza: in parte sono occupati da baroni che hanno smesso di studiare da mezzo secolo, in gran parte semplicemente «non sono previsti». L’Italia non ne ha bisogno, non li desidera, non vuole sopra di sé una classe seriamente competente e perciò eticamente giudicatrice dello svacco generale, della soddisfatta e presuntuosa mediocrità delle mezze calzette trionfanti.
A vedere questi due tipi di giovani - la tavolata coi telefonini e il giovane matematico - si sentiva dolorosamente, con urgenza, ciò di cui entrambi disperatamente mancano: di qualcuno che li «aiuti». L’aiuto di cui hanno bisogno non può essere individualistico, privato.
L’Italia ha bisogno di una cosa che va necessariamente insieme all’autarchia e le dà senso: il dirigismo pubblico. Uno Stato che, per paterna pietà dei giovani, dia una visione collettiva, una prospettiva comune, e vi impegni la società intera. Che si assuma il compito - pubblico e oggettivo - di dare ai giovani un «incarico» e un impegno. Di incardinarli al livello più esigente del loro destino: verso l’eccellenza scientifica e culturale massima cui la minoranza capace può salire, chiedendole il massimo sforzo; e agli altri, una medietà non mediocre e di bassa lega. Non si tratta qui di dittatura o di soppressione del pluralismo, anzi: si tratta di far fiorire libertà e possibilità, ma dentro una visione storica unitaria, dinamicamente in atto. Si tratta di dare il senso di appartenenza ad una comunità nazionale: e non nella visione bolsa e falsa, retorica e viscida (e vacua di risultati) delle predicozze di un Ciampi; molto di più, un impegno civile di cui tutti devono essere ritenuti responsabili, e dunque colpevoli se vi mancano.
Si può vietare ai padroni di «delocalizzare» aziende e posti in Cina o in Romania, ma solo se si impartisce ai giovani la voglia di prepararsi all’eccellenza, e si vieta loro di riempirsi di oggetti dozzinali e stranieri; e questo si «deve» fare, nonostante le proteste degli uni e degli altri. Perché è la nostra civiltà che è in gioco. Ciò vale non solo per l’Italia, ma per l’Europa continentale intera.
La pullulante anarchia francese, la depressione pessimistica tedesca (e la riduzione generale della natalità) vengono dal dubbio sull’autorità che per decenni ci ha guidato; dubbio che chi comanda oggi «non debba comandare», non ne abbia il diritto; angoscia di fronte a un mondo «privatizzato» in cui siamo abbandonati a noi stessi; smarrimento di essere ridotti a modellarci su un individualismo che forse ha un senso nella cultura anglosassone, ma non da noi. Là forse, la nozione vissuta di essere «privati» e ridotti alle proprie risorse suscita negli individui le forze migliori. Da noi, l’individualismo che non viviamo bene ci incita all’irresponsabilità, allo accaparramento amorale dei Fiorani (e dei D’Alema con il suo yacht, di Berlusconi con le sue TV irresponsabilmente idiote). Senza essere collettivisti o fascisti, abbiamo bisogno di una saggezza della comunità che ci indichi la strada, o di un’autorità cui affidarci non alla cieca, ma per convinzione. Faccio fatica a definirla, e forse Fini (Massimo) ha idee più precise.
Ma come segnale e indizio dell’ordine politico-sociale che vorrei, posso citare Bernard Stiegler, filosofo di sinistra. Un tipo incredibile: rivoltoso gauchiste nel ‘68, tenutario di un bar comunista con musica jazz, rapinatore di banche, anni di galera per rapina (durante i quali ha studiato). Oggi, messo a dirigere le politiche culturali del Centro Pompidou a Parigi, l’ex galeotto anarco-trotzkista che non rinnega il suo passato ideologico, confessa apertamente a Le Monde una cosa inaudita: «mi ha allevato la televisione del generale De Gaulle. E’ quella che mi ha fatto scoprire, a 12 anni, Eschilo e la tragedia greca». E aggiunge: allora, «si poteva essere poveri e istruiti». (1)
E’ la mia stessa esperienza, di me che sono quasi coetaneo di Stiegler. Anch’io ho imparato il mio primo francese alla TV di Stato italiana, che teneva questi corsi educativi. Anch’io ho scoperto Eschilo e Chekov e Tolstoi da antiche trasmissioni popolari (e quanto popolari!) di Vittorio Gassman, o di «appuntamenti con la novella» letti da attori italiani di prosa. So precisamente cosa intende Stiegler quando dice: «allora si poteva essere poveri e istruiti», perché anch’io sono stato così: povero che bevevo istruzione dalla TV di allora, povero che voleva istruirsi. E non «per fare soldi», o salire sulla «scala sociale», ma per essere degno di una società degnamente esigente, preparato a un avvenire comune migliore.
Per me allora quest’idea un po’ vaga faceva tutt’uno con «fascismo», la sola autarchia di cui avevo nozione, per Stiegler con ciò che lui chiama «culture ouvrière». Penso oggi che stiamo parlando della stessa cosa, della stessa nostalgia.
Io ho il sospetto che ci abbiano demonizzato il fascismo per impedirci di indagare come riuscì a dare una direzione comune e condivisa all’Italia, a nazionalizzare le masse; Stiegler parla di De Gaulle come di un nemico di classe da cui però prendere esempio, un’autorità che non si poteva disprezzare (come Berlusconi, come Prodi, come Ciampi).
E’ l’autarchia di cui abbiamo bisogno. L’autarchia nazionale non è più possibile, naturalmente. Ma l’autarchia d’Europa non solo è possibile, è necessaria. Una comunità di 400 milioni di persone, che dispone ancora di varietà straordinarie di competenze, ha diritto a chiudere i confini e produrre in proprio tutto. Anzi ne ha il dovere. Anche perché - e qui chiudo, prometto - l’economia interdipendente globalizzata può incontrare una fine traumatica e rapida. La compravendita di merci prodotte in lontani continenti si fonda profondamente sui bassissimi costi dei trasporti intercontinentali. Ma da 15 anni non si trovano più nuovi importanti giacimenti petroliferi; tra una ventina, il costo dell’energia sarà molto più caro, e converrà tornare a produrre cose e alimenti vicino, anziché comprarli lontano.
Ciò può avvenire d’improvviso, come di colpo può scoppiare una qualunque guerra per l’energia che infatua le vie di comunicazione, e blocca i traffici. Allora sarà vincente di nuovo chi ha conservato competenze diverse (oggi «non competitive» per la miopia di un affarismo ossessionato dalla finanza), società articolate e complesse e non già semplificate-desertificate: chi ha ancora contadini sulla terra nazionale capaci di coltivare, operai orgogliosi nelle fabbriche, ingegneri tecnici e matematici, chimici capaci di sintetizzare «surrogati» di materie prime introvabili; e non solo «bocconiani» e servitori e lustrascarpe. Perdente sarà chi avrà società «semplici». Autarchia, autarchia.
Note 1) Michel Alberganti, «Bernard Stiegler, un philosophe interactif», Le Monde, 4 gennaio 2006.
Fa discutere in questi giorni un "Manifesto" di Massimo Fini al quale si può aderire semplicemente scrivendo "aderisco" - e ovviamente firmando - all'indirizzo segreteria@massimofini.it

Documenti storici per i lettori de "Il Vascello"
Il testo originale in inglese (e in PDF) della incriminazione di Lewis Libby (braccio destro del vice presidente Cheney, è accusato di spergiuro, fu un architetto dell'invasione dell'Iraq): fa tremare Bush. Cliccare qui
Offriamo molti strumenti per capire la vicenda Calipari che raccontiamo per esteso (con la ripresa dei documenti ufficiali e del finto sdegno italiano) Intanto gli inglesi se ne vanno in giro a provocare attentati?. Per leggere il tutto, con un contributo di Maurizio Blondet, cliccare qui
|  |
Un articolo di Massimo Fini
Il successo del pesce lesso

Quello di Gianfranco Fini, presidente di An e ora anche ministro degli Esteri, è un mistero. Doloroso.
Soprattutto per la Destra. Per quanto ci si sforzi e si aguzzi l’ingegno non si riescono a trovare le ragioni della sua fortuna politica. Ha l’appeal di un pesce lesso o di una lucertola, animale a sangue freddo. Non ha la rude affettività di Bossi, ma neanche l’aria da simpatica canaglia di Berlusconi, al massimo sta al livello di Follini. Forse l’unico dei “big” cui potrebbe essere apparigliato, per l’atteggiamento scostante e superbioso, è Massimo D’Alema. Ma il presidente dei Ds, che esce dalla Normale di Pisa, è un uomo di cultura, Fini, no. “Anzi, la cultura la disprezza” mi ha detto una volta Gennaro Malgieri, direttore del Secolo d’Italia poi, di fatto, costretto alle dimissioni, uno dei pochi uomini di spessore di An, intellettuali che Fini ha diligentemente e sistematicamente eliminato o emarginato, dallo stesso Malgieri a Fisichella e Menniti. Non ha nemmeno capito che dagli avversari bisogna prendere, per poi trasformare a modo proprio, quello che hanno di positivo, e che se la cultura comunista ha dominato per mezzo secolo in Italia (con conseguenti e succose ricadute politiche) è perché il Pci nella cultura aveva investito.
Per sapere che gode di pochissima considerazione anche fra i suoi “colonnelli“ non era necessario aspettare le “quattro chiacchiere al bar” carpite dallo stagista del Tempo.
Essendo l’unico intellettuale italiano, insieme a Giampiero Mughini, che negli anni ’80 frequentava le convention del Msi (non perché condividessi, naturalmente, ma per testimoniare il diritto all’esistenza politica di tre o quattro milioni di elettori, esclusi dalla truffa dell’“arco costituzionale”) ho conosciuto abbastanza bene quasi tutti coloro che oggi sono ai vertici di An e che allora erano dei ragazzi (Gasparri, Alemanno, Malgieri e molti altri) e dalle loro bocche non ho mai sentito uscire una sola parola di apprezzamento per Gianfranco Fini.
I giovani di An poi, che ogni tanto mi invitano nei loro circoli perché consonano con alcune delle mie idee, lo detestano. Perché, pur di rifarsi una verginità, ha buttato a mare l’intero patrimonio ideale del fascismo (anche, per fare un esempio, alcuni concetti, come quello di autarchia, che oggi, in tempi di globalizzazione selvaggia, potrebbero tornare buoni, sia pur non più a livello nazionale ma europeo) e, scimmiottando lessicamente Bush, ha definito il regime mussoliniano “il Male Assoluto”, azzardo cui non erano arrivati nemmeno i comunisti.

Pur di rimanere nel salotto buono della politica è disposto a vendere il padre putativo, Almirante. E infatti in questi anni non ha fatto politica, si è limitato ad appecoronarsi a Berlusconi, in un modo così servile e sciocco che come cognome più del suo gli si adatterebbe meglio quello della moglie, che fa Di Sotto. Da Berlusconi ha mutato l’americanismo “senza se e senza ma”.
Ora, quando nel 1985 partecipai a Taormina a una convention dell’Msi cui erano presenti migliaia di giovani di quel partito, fra cui i “colonnelli” di oggi, e dissi “Non ho mai capito perché voi missini siete atlantisti” ricevetti la più lunga “standing ovation” della mia carriera.
Ma, soprattutto, Fini ha appoggiato senza riserve la devastante campagna di Berlusconi contro la magistratura italiana (e tutte le infami leggi “ad personam”), dimenticando che è stato proprio grazie alle inchieste di Mani Pulite se l’Msi, poi An, e lui stesso, sono potuti tornare all’onor nel mondo politico dopo quarant’anni di emarginazione. Ma non è un problema di riconoscenza. Il fatto è che il concetto di Destra può essere declinato in mille modi, ma su una cosa le Destre di tutto il mondo sono concordi: nella difesa di “law and order”.
Solo in Italia abbiamo una Destra indecente che spara a zero sulla magistratura, e soprattutto su quella più efficiente, per cui oggi non c’è islamico integralista che, preso con le mani nel sacco, non gridi al “complotto” e all“accanimento giudiziario”. Questi sono i risultati.
Anche Umberto Bossi ha appoggiato Berlusconi, non in tutto peraltro, ma perlomeno si è fatto dare una contropartita: la devolution. Il leader di An lo ha fatto invece “a gratis”.
Forse Gianfranco Fini è stato indotto a questo atteggiamento così poco autonomo e sottomesso, che ha privato il suo partito di ogni identità, perché è consapevole – e questo sarebbe già un segno di intelligenza – della propria mediocrità, che però è all’origine della sua straordinaria suscettibilità e del suo dispotismo.
Ha azzerato i vertici del partito, lo ha commissariato e quasi distrutto per “quattro chiacchiere al bar” che ledevano la sua personcina (se gli uomini di An non sono liberi di dire le proprie fregnacce almeno al bar dove lo saranno mai?).
Gianni Alemanno ha commentato: “Basta con l’idea di un capo che pensa per tutti”. Il problema è che Fini non pensa per tutti, pensa, da sempre, solo a se stesso. Io lo chiamo “il Fini sbagliato”.
( da “Elogi e stroncature - Giudizio Universale)

La pagina è aggiornata alle ore 10:00:06 di Mer, 11 gen 2006
|